
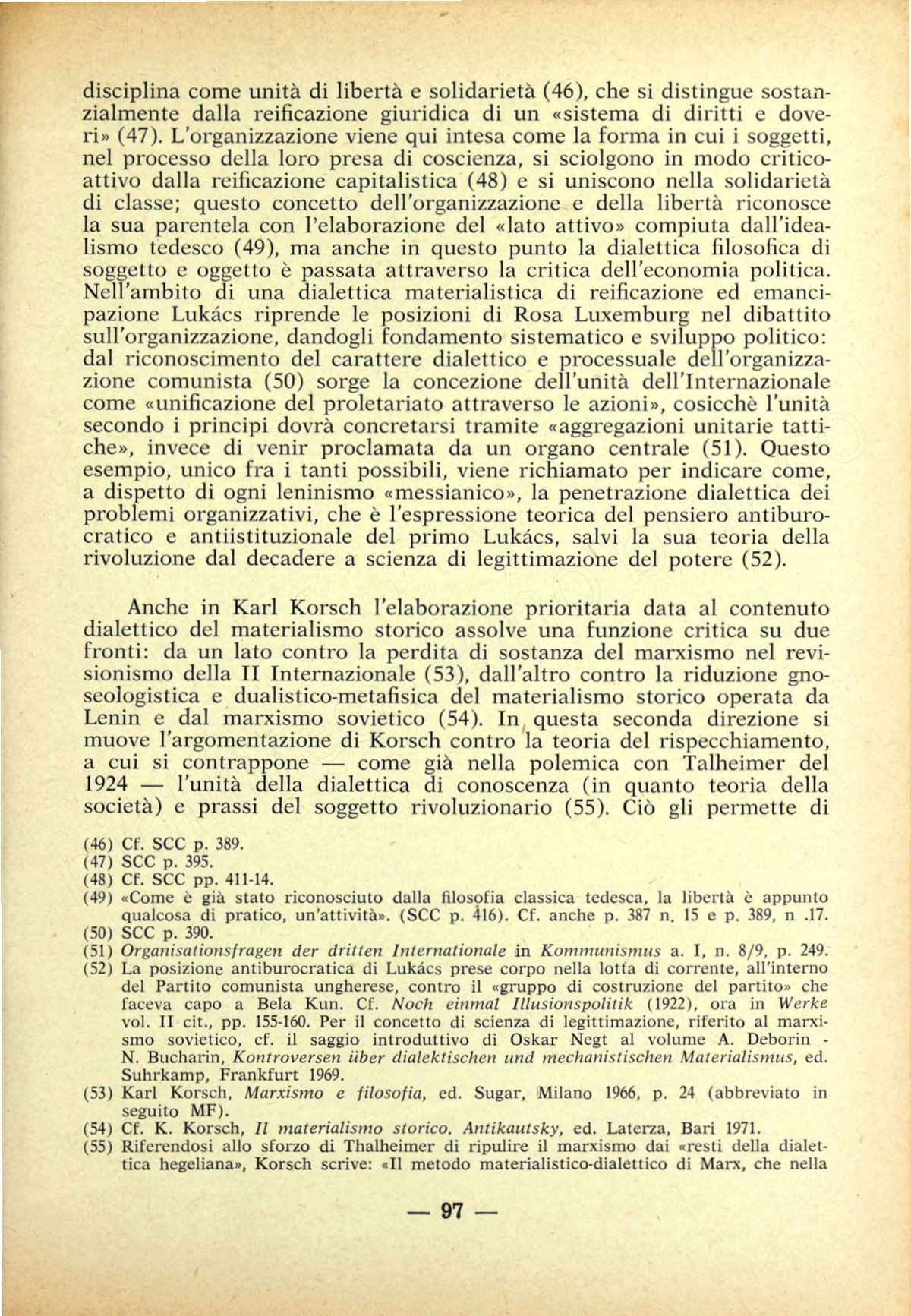
disciplina come unità di libertà e solidarietà (46), che si distingue sostan-
zialmente dalla reificazione giuridica di un «sistema di diritti e dove-
ri» (47). L'organizzazione viene qui intesa come la forma in cui i soggetti,
nel processo della loro presa di coscienza, si sciolgono in modo critico-
attivo dalla reificazione capitalistica (48) e si uniscono nella solidarietà
di classe; questo concetto dell'organizzazione e della libertà riconosce
la sua parentela con l'elaborazione del «lato attivo» compiuta dall'idea-
lismo tedesco (49), ma anche in questo punto la dialettica filosofica di
soggetto e oggetto è passata attraverso la critica dell'economia politica.
Nell'ambito di una dialettica materialistica di reificazione ed emanci-
pazione Luicks riprende le posizioni di Rosa Luxemburg nel dibattito
sull'organizzazione, dandogli fondamento sistematico e sviluppo politico:
dal riconoscimento del carattere dialettico e processuale dell'organizza-
zione comunista (50) sorge la concezione dell'unità dell'Internazionale
come«unificazione del proletariato attraverso le azioni», cosicchè l'unità
secondo i principi dovrà concretarsi tramite «aggregazioni unitarie tatti-
che», invece di venir proclamata da un organo centrale (51). Questo
esempio, unico fra i tanti possibili, viene richiamato per indicare come,
adispetto di ogni leninismo «messianico», la penetrazione dialettica dei
problemi organizzativi, che è l'espressione teorica del pensiero antiburo-
cratico e antiistituzionale del primo Lukàcs, salvi la sua teoria della
rivoluzione dal decadere a scienza di legittimazione del potere (52).
Anche in Karl Korsch l'elaborazione prioritaria data al contenuto
dialettico del materialismo storico assolve una funzione critica su due
fronti: da un lato contro la perdita di sostanza del marxismo nel revi-
sionismo della I I Internazionale (53), dall'altro contro la riduzione gno-
seologistica e dualistico-metafisica del materialismo storico operata da
Lenin e dal marxismo sovietico (54). In, questa seconda direzione si
muove l'argomentazione di Korsch contro la teoria del rispecchiamento,
a cui si contrappone — come già nella polemica con Talheimer del
1924 — l'unità della dialettica di conoscenza (in quanto teoria della
società) e prassi del soggetto rivoluzionario (55). Ciò gli permette di
(46) Cf. SCC p. 389.
(47) SCC p. 395.
(48) Cf. SCC pp. 411-14.
(49) «Come è già stato riconosciuto dalla filosofia classica tedesca, la libertà è appunto
qualcosa di pratico, un'attività». (SCC p. 416). Cf. anche p. 387 n. 15 e p. 389, n .17.
(50) SCC p. 390.
(Si) Organisationsfragen der dritten Internationale in Kommunismus a. I , n. 8/9, p. 249.
(52) La posizione antiburocratica di Lukks prese corpo nella lotta di corrente, all'interno
del Partito comunista ungherese, contro i l «gruppo di costruzione del partito» che
faceva capo a Bela Kun. Cf .
Noch einmal Illusionspolitik
(1922), ora i n
Werke
vol.
I I cit., pp. 155-160. Per il concetto di scienza di legittimazione, riferito al mani-
smo sovietico, cf . i l saggio introduttivo d i Oskar Negt a l volume A. Deborin -
N. Bucharin, Kontroversen iiber dialektischen und mechanistischen Materialismus, ed.
Suhrkamp, Frankfurt 1969.
(53) Karl Korsch,
Marxismo
e
filosofia,
ed. Sugar, Milano 1966, p. 24 (abbreviato i n
seguito MF) .
(54) Cf. K. Korsch,
11 materialismo storico. Antikautsky,
ed. Laterza, Bari 1971.
(55) Riferendosi allo sforzo di Thalheimer di ripulire i l marxismo dai «resti della dialet-
tica hegeliana», Korsch scrive: «I l metodo materialistico-dialettico di Man, che nella
97
















