
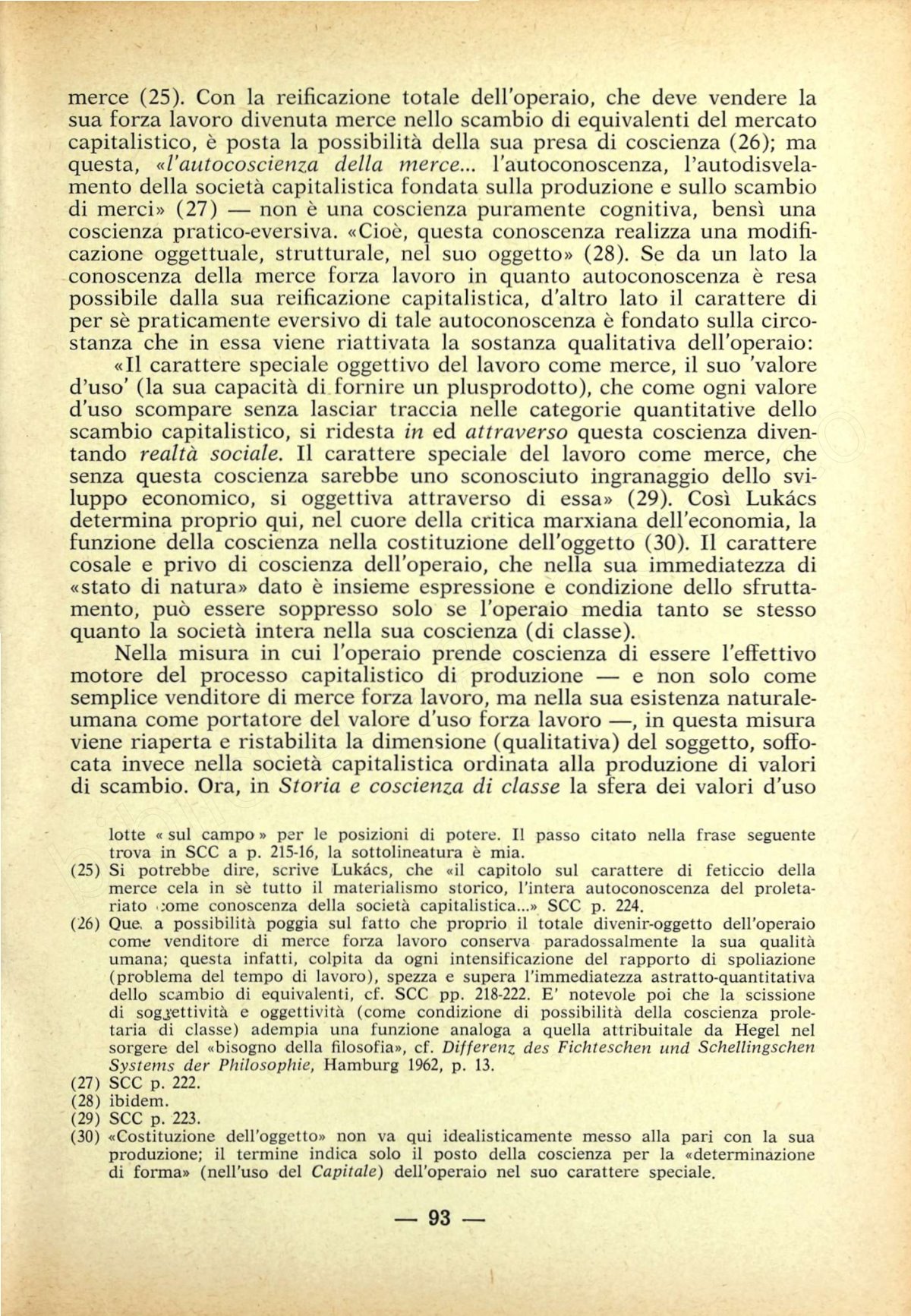
merce (25). Con la reificazione totale dell'operaio, che deve vendere la
sua forza lavoro divenutamerce nello scambio di equivalenti del mercato
capitalistico, è posta la possibilità della sua presa di coscienza (26); ma
questa,
«l'autocoscienza della merce...
l'autoconoscenza, l'autodisvela-
mento della società capitalistica fondata sulla produzione e sullo scambio
di merci» (27) — non è una coscienza puramente cognitiva, bensì una
coscienza pratico-eversiva. «Cioè, questa conoscenza realizza una modifi-
cazioneoggettuale, strutturale, nel suo oggetto» (28). Se da un lato la
conoscenza della merce forza lavoro in quanto autoconoscenza è resa
possibile dalla sua reificazione capitalistica, d'altro lato il carattere di
per sepraticamente eversivo di tale autoconoscenza è fondato sulla circo-
stanza che in essa viene riattivata la sostanza qualitativa dell'operaio:
«Il carattere speciale oggettivo del lavoro comemerce, il suo 'valore
d'uso' (la sua capacitàdi_ fornire un plusprodotto), che come ogni valore
d'usoscompare senza lasciar traccia nelle categorie quantitative dello
scambiocapitalistico, si ridesta
in
ed
attraverso
questa coscienza diven-
tando
realtà sociale.
I l carattere speciale del lavoro come merce, che
senzaquesta coscienza sarebbe uno sconosciuto ingranaggio dello svi-
luppo economico, si oggettiva attraverso di essa» (29). Così Lulcàcs
determina proprio qui, nel cuore della critica marxiana dell'economia, la
funzione della coscienza nella costituzione dell'oggetto (30). I l carattere
cosale e privo di coscienza dell'operaio, che nella sua immediatezza di
«stato di natura» dato è insieme espressione e condizione dello sfrutta-
mento, può essere soppresso solo se l'operaio media tanto se stesso
quanto la società intera nella sua coscienza (di classe).
Nella misura in cui l'operaio prende coscienza di essere l'effettivo
motore del processo capitalistico di produzione — e non solo come
semplicevenditore di merce forza lavoro, ma nella suaesistenza naturale-
umanacome portatore del valore d'uso forza lavoro —, in questamisura
viene riaperta e ristabilita la dimensione (qualitativa) del soggetto, soffo-
cata invece nella società capitalistica ordinata alla produzione di valori
di scambio. Ora, in
Storia
e
coscienza di classe
la sfera dei valori d'uso
lotte « sul campo » per le posizioni d i potere. I l passo ci tato nel la frase seguente
trova i n SCC a p. 215-16, la sottolineatura è mia.
(25) Si potrebbe di re, scr ive l u k k s , che « i l capi tolo su l carattere d i fet iccio del la
merce cela i n sè tut to i l materialismo storico, l ' intera autoconoscenza del proleta-
riato ..tome conoscenza della società capitalistica...» SCC p. 224.
(26) Qua a possibilità poggia sul fat to che proprio i l totale divenir-oggetto dell'operaio
come venditore d i merce forza lavoro conserva paradossalmente l a sua qual i tà
umana; questa infat t i , colpi ta da ogni intensificazione del rapporto d i spoliazione
(problema del tempo di lavoro), spezza e supera l'immediatezza astratto-quantitativa
dello scambio d i equivalenti, cf . SCC pp. 218-222. E ' notevole poi che l a scissione
di sogjett ivi tà e oggettività (come condizione d i possibilità del la coscienza prole-
taria d i classe) adempia una funzione analoga a quella attribuitale da Hegel nel
sorgere del «bisogno della filosofia», cf. Differenz des Fichteschen und Schellingschen
Systems der Philosophie, Hamburg 1962, p. 13.
(27) SCC p. 222.
(28) ibidem.
(29) SCC p. 223.
(M) «Costituzione dell'oggetto» non va qu i idealisticamente messo al la par i con l a sua
produzione; i l termine indica solo i l posto del la coscienza per l a «determinazione
di forma» (nell'uso del
Capitale)
dell'operaio nel suo carattere speciale.
93 —
















