
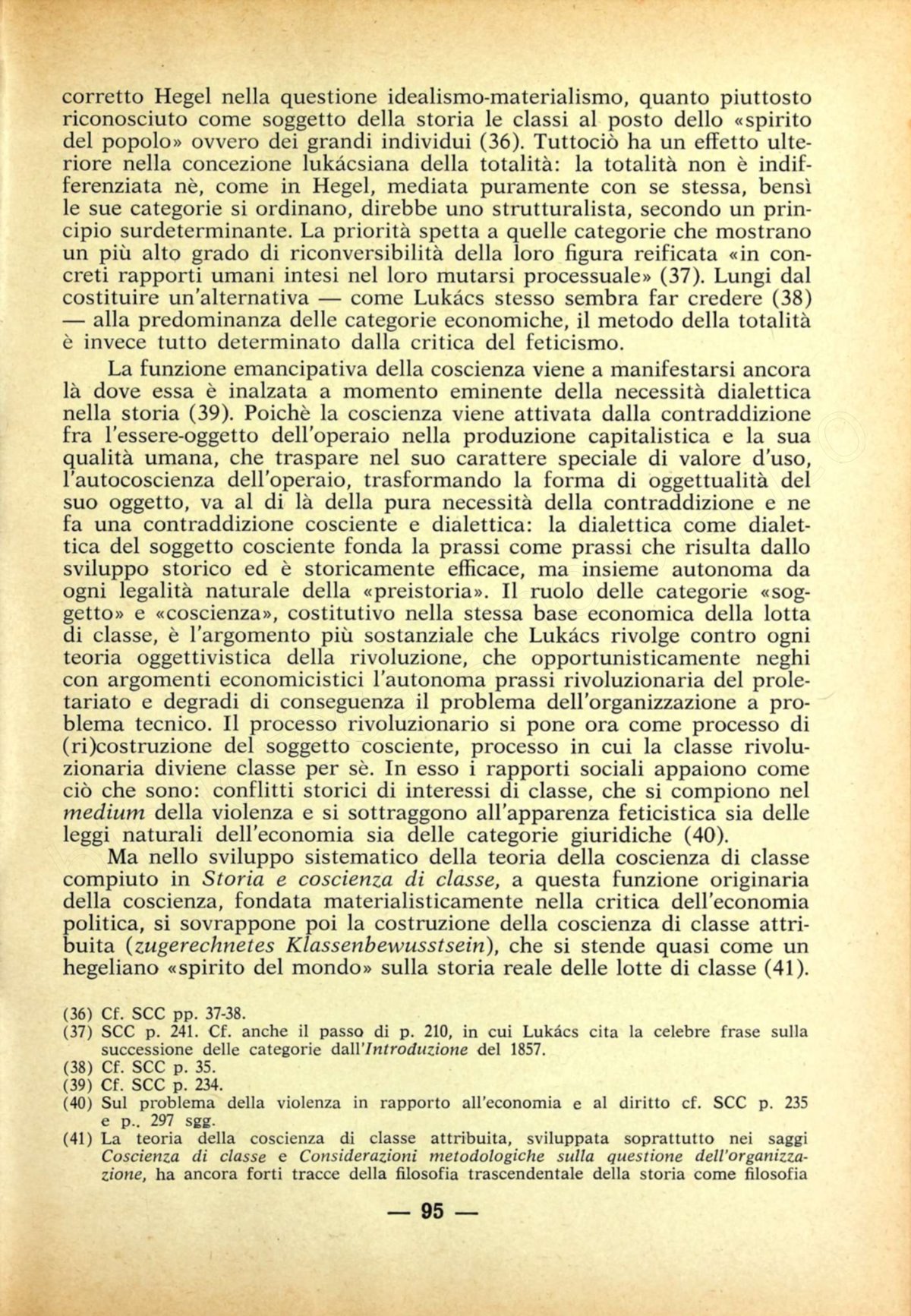
corretto Hegel nella questione idealismo-materialismo, quanto piuttosto
riconosciuto come soggetto della storia le classi al posto dello «spirito
del popolo» ovvero dei grandi individui (36). Tuttociò ha un effetto ulte-
riore nella concezione luld.csiana della totalità: la totalità non è indif-
ferenziata ne, come in Hegel, mediata puramente con se stessa, bensì
lesue categorie si ordinano, direbbe uno strutturalista, secondo un prin-
cipio surdeterminante. La priorità spetta a quelle categorie chemostrano
un più alto grado di riconversibilità della loro figura reificata «in con-
creti rapporti umani intesi nel loro mutarsi processuale» (37). Lungi dal
costituire un'alternativa — come Lukàcs stesso sembra far credere (38)
alla predominanza delle categorie economiche, il metodo della totalità
èinvece tutto determinato dalla critica del feticismo.
La funzione emancipativa della coscienzaviene a manifestarsi ancora
là dove essa è inalzata a momento eminente della necessità dialettica
nella storia (39). Poichè la coscienza viene attivata dalla contraddizione
fra l'essere-oggetto dell'operaio nella produzione capitalistica e la sua
qualità umana, che traspare nel suo carattere speciale di valore d'uso,
l'autocoscienza dell'operaio, trasformando la forma di oggettualità del
suooggetto, va al di là della pura necessità della contraddizione e ne
fa una contraddizione cosciente e dialettica: l a dialettica come dialet-
tica del soggettocosciente fonda la prassi come prassi che risulta dallo
sviluppo storico ed è storicamente efficace, ma insieme autonoma da
ogni legalità naturale della «preistoria». I l ruolo delle categorie «sog-
getto» e «coscienza», costitutivo nella stessabase economica della lotta
di classe, è l'argomento più sostanziale che Lulcàcs rivolge contro ogni
teoria oggettivistica della rivoluzione, che opportunisticamente neghi
conargomenti economicistici l'autonoma prassi rivoluzionaria del prole-
tariato e degradi di conseguenza il problema dell'organizzazione a pro-
blema tecnico. I l processo rivoluzionario si pone ora comeprocesso di
(ri)costruzione del soggetto cosciente, processo in cui la classe rivolu-
zionaria diviene classe per sè. In esso i rapporti sociali appaiono come
ciòche sono: conflitti storici di interessi di classe, che si compiono nel
medium
della violenza e si sottraggono all'apparenza feticistica sia delle
leggi naturali dell'economia sia delle categorie giuridiche (40).
Ma nello sviluppo sistematico della teoria della coscienza di classe
compiuto in
Storia
e
coscienza di classe,
a questa funzione originaria
della coscienza, fondata materialisticamente nella critica dell'economia
politica, si sovrappone poi la costruzione della coscienza di classe attri-
buita
(zugerechnetes Klassenbewusstsein),
che si stende quasi come un
hegeliano «spirito del mondo» sulla storia reale delle lotte di classe (41).
(36) Cf. SCC pp. 37-38.
(37) SCC p. 241. Cf. anche i l passo di p. 210, in cui Lukacs cita la celebre frase sulla
successione delle categorie
dall'Introduzione
del 1857.
(38) Cf. SCC p. 35.
(39) Cf. SCC p. 234.
(40) Sul problema della violenza i n rapporto all'economia e a l diritto cf . SCC p. 235
e p.. 297 sgg.
(41) La teoria del la coscienza d i classe attribuita, sviluppata soprattutto nei saggi
Coscienza d i classe e Considerazioni metodologiche sul la questione dell'organizza-
zione,
ha ancora forti tracce della filosofia trascendentale della storia come filosofia
95
















