
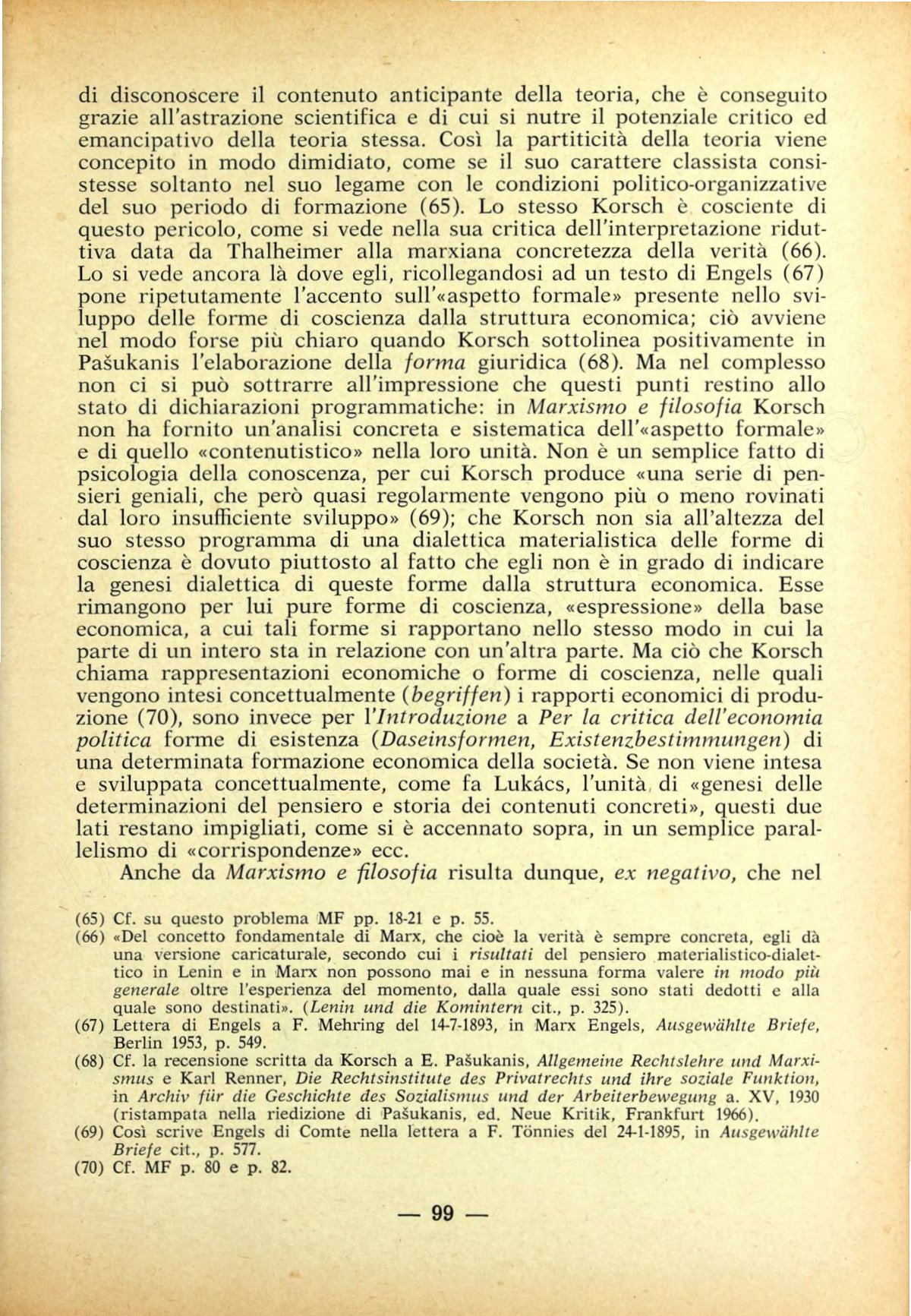
di disconoscere i l contenuto anticipante della teoria, che è conseguito
grazie all'astrazione scientifica e di cui si nutre i l potenziale critico ed
emancipativo della teoria stessa. Così la partiticità della teoria viene
concepito in modo dimidiato, come se i l suo carattere classista consi-
stesse soltanto nel suo legame con le condizioni politico-organizzative
del suo periodo di formazione (65). Lo stesso Korsch è cosciente d i
questo pericolo, come si vede nella sua critica dell'interpretazione ridut-
tiva data da Thalheimer alla marxiana concretezza della verità (66).
Lo si vede ancora là dove egli, ricollegandosi ad un testo di Engels (67)
pone ripetutamente l'accento sull'«aspetto formale» presente nello svi-
luppo delle forme di coscienza dalla struttura economica; ciò avviene
nel modo forse più chiaro quando Korsch sottolinea positivamente in
Pagukanis l'elaborazione della
forma
giuridica (68). Ma nel complesso
non c i si può sottrarre all'impressione che questi punti restino al lo
stato di dichiarazioni programmatiche: in
Marxismo
e
filosofia
Korsch
non ha fornito un'analisi concreta e sistematica dell'«aspetto formale»
e di quello «contenutistico» nella loro unità. Non è un semplice fatto di
psicologia della conoscenza, per cui Korsch produce «una serie di pen-
sieri geniali, che però quasi regolarmente vengono più o meno rovinati
dal loro insufficiente sviluppo» (69); che Korsch non sia all'altezza del
suo stesso programma d i una dialettica materialistica delle forme d i
coscienza è dovuto piuttosto al fatto che egli non è in grado di indicare
la genesi dialettica d i queste forme dalla struttura economica. Esse
rimangono per lui pure forme d i coscienza, «espressione» della base
economica, a cui tal i forme si rapportano nello stesso modo in cui la
parte di un intero sta in relazione con un'altra parte. Ma ciò che Korsch
chiama rappresentazioni economiche o forme di coscienza, nelle quali
vengono intesi concettualmente
(begriffen)
i rapporti economici di produ-
zione (70), sono invece per l'Introduzione a Per la critica dell'economia
politica forme di esistenza (Daseinsformen, Existenzbestimmungen) d i
una determinata formazione economica della società. Se non viene intesa
esviluppata concettualmente, come fa Lukées, l'unità, di «genesi delle
determinazioni del pensiero e storia dei contenuti concreti», questi due
lati restano impigliati, come si è accennato sopra, in un semplice paral-
lelismo di «corrispondenze» ecc.
Anche da Marxismo e filosofia risulta dunque, ex negativo, che nel
(65) Cf. su questo problema MF pp. 18-21 e p. 55.
(66) «Del concetto fondamentale d i Marx, che cioè l a verità è sempre concreta, egl i dà
una versione caricaturale, secondo cui i
r isul tat i
del pensiero materialistico-dialet-
tico i n Lenin e i n Marx non possono mai e i n nessuna forma valere i n
modo più
generale
ol t re l'esperienza del momento, dal la quale essi sono stat i dedotti e al la
quale sono destinati».
(Lenin und die Komintern
cit., p. 325).
(67) Lettera d i Engels a F. Mehring del 14-7-1893, i n Marx Engels,
Ausgewiihlte Briefe,
Berlin 1953, p. 549.
(68) Cf. la recensione scritta
da
Korsch a
E.
Pa§ukanis,
Allgemeine Rechtslehre und Marxi-
smus e Kar l Renner, Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion,
in Archiv / l i r die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung a. XV, 1930
(ristampata nella riedizione d i PaAukanis, ed. Neue Kr i t i k, Frankfurt 1966).
(69) Così scrive Engels d i Comte nella léttera a F. Tstinnies del 24-1-1895, i n
Ausgewiihlte
Briefe
cit., p. 577.
(70) Cf. MF p. 80 e p. 82.
99
o
















