
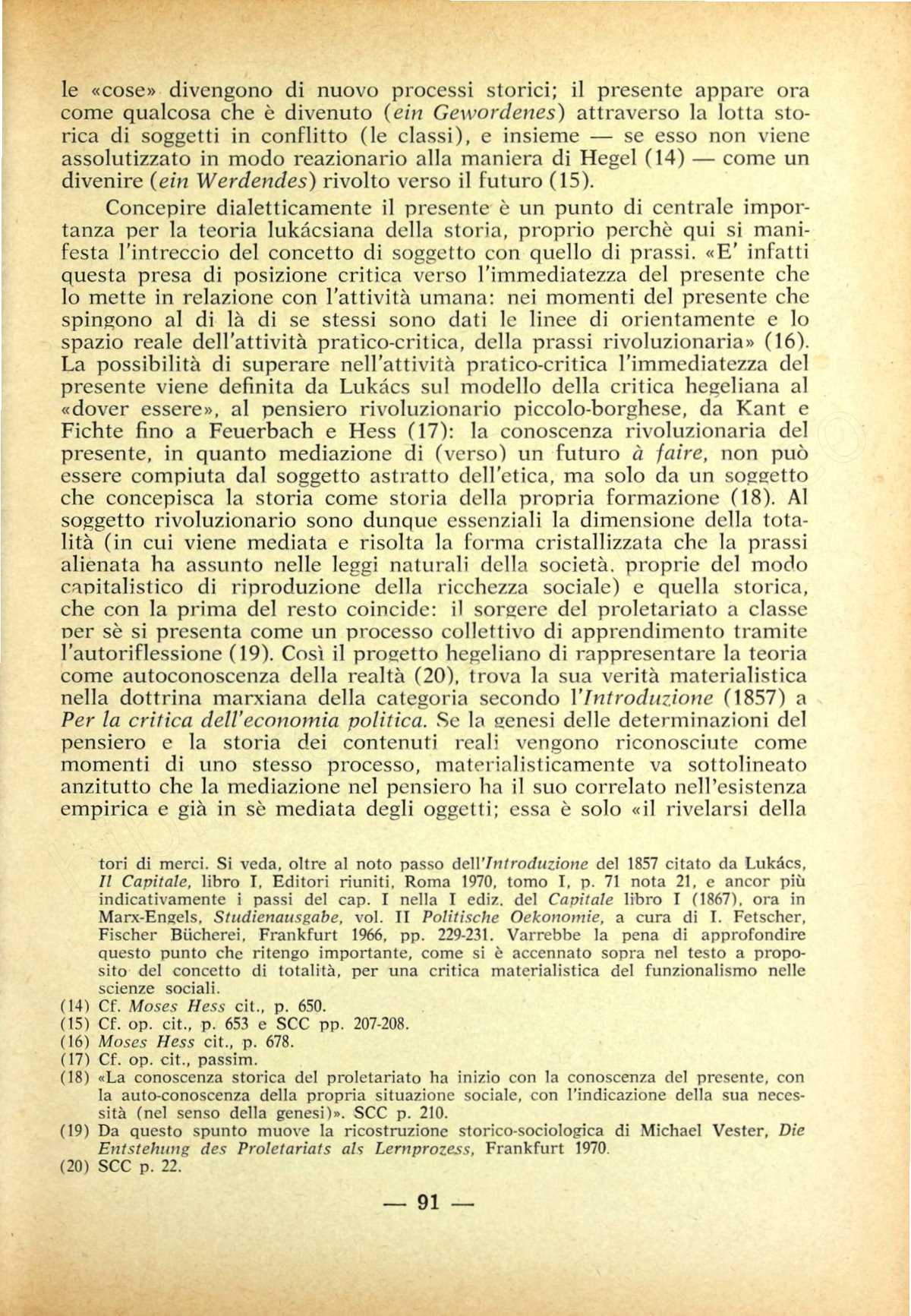
le«cose» divengono di nuovo processi storici; i l presente appare ora
comequalcosa che è divenuto
(ein Gewordenes)
attraverso la lotta sto-
rica di soggetti in conflitto (le classi), e insieme — se esso non viene
assolutizzato in modo reazionario alla maniera di Hegel (14) — come un
divenire
(ein
W
erdendes)
rivolto verso il futuro (15).
Concepire dialetticamente il presente- è un punto di centrale impor-
tanza per la teoria luldesiana della storia, proprio perchè qui si mani-
festa l'intreccio del concetto di soggetto con quello di prassi. «E' infatti
questapresa di posizione critica verso l'immediatezza del presente che
lomette in relazione con l'attività umana: nei momenti del presente che
spingono al di là di se stessi sono dati le linee di orientamente e lo
spazio reale dell'attività pratico-critica, della prassi rivoluzionaria» (16).
La possibilità di superare nell'attività pratico-critica l'immediatezza del
presente viene definita da Lukks sul modello della critica hegeliana al
«dover essere», al pensiero rivoluzionario piccolo-borghese, da Kant e
Fichte fino a Feuerbach e Hess (17): l a conoscenza rivoluzionaria del
presente, in quanto mediazione di (verso) un futuro à
faire,
non può
esserecompiuta dal soggetto astratto dell'etica, ma solo da un soggetto
checoncepisca la storia come storia della propria formazione (18). Al
soggetto rivoluzionario sono dunque essenziali la dimensione della tota-
lità (in cui viene mediata e risolta la forma cristallizzata che la prassi
alienata ha assunto nelle leggi naturali della società. proprie del modo
capitalistico di riproduzione della ricchezza sociale) e quella storica,
checon la prima del resto coincide: i l sorgere del proletariato a classe
Persè si presenta come un processo collettivo di apprendimento tramite
l'autoriflessione (19). Così il progetto hegeliano di rappresentare la teoria
comeautoconoscenza della realtà (20), trova la sua verità materialistica
nella dottrina marxiana della categoria secondo
l'Introduzione
(1857) a
Per la critica dell'economia politica.
Se la genesi delle determinazioni del
pensiero e la storia dei contenuti reali vengono riconosciute come
momenti di uno stesso processo, materialisticamente va sottolineato
anzitutto che la mediazione nel pensiero ha il suo correlato nell'esistenza
empirica e già in sè mediata degli oggetti; essa è solo «il rivelarsi della
tori di merci. Si veda, oltre al noto passo
dell'Introduzione
del 1857 citato da Lukks,
I l Capitale,
libro I , Editori riuniti, Roma 1970, tomo I , p. 71 nota 21, e ancor più
indicativamente i passi del cap. I nella I ediz. del
Capitale
libro I (1867), ora in
Marx-Engels,
Studienausgabe,
vol. 11
Politische Oekonomie,
a cura di I . Fetscher,
Fischer Bucherei, Frankfurt 1966, pp. 229-231. Varrebbe l a pena d i approfondire
questo punto che ritengo importante, come si è accennato sopra nel testo a propo-
sito del concetto di totalità, per una critica materialistica del funzionalismo nelle
scienze sociali.
(14) Cf.
Moses Hess
cit., p. 650.
(15) C t op. cit., p. 653 e SCC pp. 207-208.
(16)
Moses Hess
cit., p. 678.
(17) Cf. op. cit., passim.
(18) «La conoscenza storica del proletariato ha inizio con la conoscenza del presente, con
la auto-conoscenza della propria situazione sociale, con l'indicazione della sua neces-
sità (nel senso della genesi)». SCC p. 210.
(19) Da questo spunto muove la ricostruzione storico-sociologica di Michael Vester,
Die
Entstehung des Prole tariats als Lernprozess,
Frankfurt 1970.
(20) SCC p. 22.
- 91 -
















