
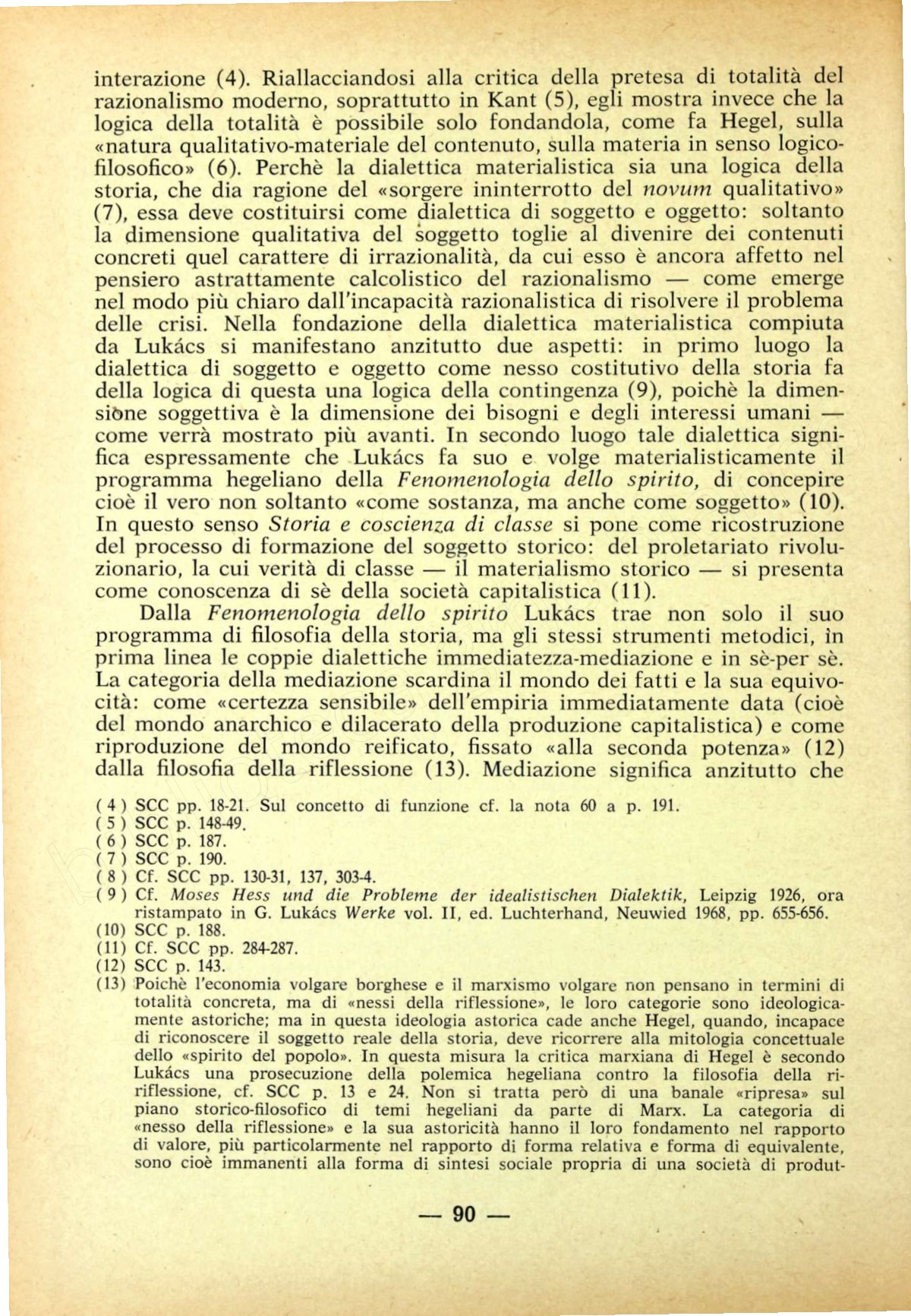
interazione (4). Riallacciandosi alla critica della pretesa di totalità del
razionalismomoderno, soprattutto in Kant (5), egli mostra invece che la
logica della totalità è possibile solo fondandola, come fa Hegel, sulla
«natura qualitativo-materiale del contenuto, sulla materia in senso logico-
filosofico» (6). Perchè la dialettica materialistica sia una logica della
storia, che dia ragione del «sorgere ininterrotto del
novum
qualitativo»
(7), essadeve costituirsi come dialettica di soggetto e oggetto: soltanto
la dimensione qualitativa del g'oggetto toglie al divenire dei contenuti
concreti quel carattere di irrazionalità, da cui esso è ancora affetto nel
pensiero astrattamente calcolistico del razionalismo — come emerge
nelmodo più chiaro dall'incapacità razionalistica di risolvere il problema
delle crisi. Nella fondazione della dialettica materialistica compiuta
daLukàcs si manifestano anzitutto due aspetti: i n primo luogo la
dialettica di soggetto e oggetto come nesso costitutivo della storia fa
della logica di questa una logica della contingenza (9), poichè la dimen-
sibnesoggettiva è la dimensione dei bisogni e degli interessi umani
come verrà mostrato più avanti. In secondo luogo tale dialettica signi-
ficaespressamente che Lukàcs fa suo e volge materialisticamente i l
programma hegeliano della
Fenomenologia dello spirito,
di concepire
cioè il vero non soltanto «comesostanza, ma anche comesoggetto» (10).
In questosenso
Storia
e
coscienza di classe
si pone come ricostruzione
del processo di formazione del soggetto storico: del proletariato rivolu-
zionario, la cui verità di classe — il materialismo storico — si presenta
comeconoscenza di sè della società capitalistica (11).
Dalla
Fenomenologia dello spirito
Lukàcs trae non solo i l suo
programma di filosofia della storia, ma gli stessi strumenti metodici, In
prima linea le coppie dialettiche immediatezza-mediazione e in se-per se.
La categoria dellamediazione scardina il mondo dei fatti e la sua equivo-
cità: come «certezza sensibile» dell'empiria immediatamente data (cioè
delmondo anarchico e dilacerato della produzione capitalistica) e come
riproduzione del mondo reificato, fissato «alla seconda potenza» (12)
dalla filosofia della riflessione (13). Mediazione significa anzitutto che
( 4 ) SCC pp. 18-21. Sul concetto di funzione cf. la nota 60 a p. 191.
( 5 ) SCC p. 148-49.
( 6 ) SCC p. 187.
( 7 ) SCC p. 190.
( 8 ) Cf. SCC pp. 130-31, 137, 303-4.
( 9 ) Cf. Moses Hess und die Probleme der idealistischen Dialektik, Leipzig 1926, ora
ristampato in G. Lukàcs
Werke
vol. I I , ed. Luchterhand, Neuwied 1968, pp. 655-656.
(10) SCC p. 188.
(11) Cf. SCC •pp. 284-287.
(12) SCC P. 143.
(13) Poiché l'economia volgare borghese e i l marxismo volgare non pensano in termini di
totalità concreta, ma di «nessi della riflessione», le loro categorie sono ideologica-
mente astoriche; ma in questa ideologia astorica cade anche Hegel, quando, incapace
di riconoscere i l soggetto reale della storia, deve ricorrere alla mitologia concettuale
dello «spirito del popolo». I n questa misura la critica marxiana di Hegel è secondo
Lukàcs una prosecuzione della polemica hegeliana contro l a filosofia del la r i -
riflessione, cf . SCC p . 13 e 24. Non s i tratta però d i una banale «ripresa» sul
piano storico-filosofico d i t emi hegeliani d a parte d i Marx. L a categoria d i
«nesso della riflessione» e la sua astoricità hanno i l loro fondamento nel rapporto
di valore, più particolarmente nel rapporto di forma relativa e forma di equivalente,
sono cioè immanenti alla forma di sintesi sociale propria di una società di produt-
- 90
















