
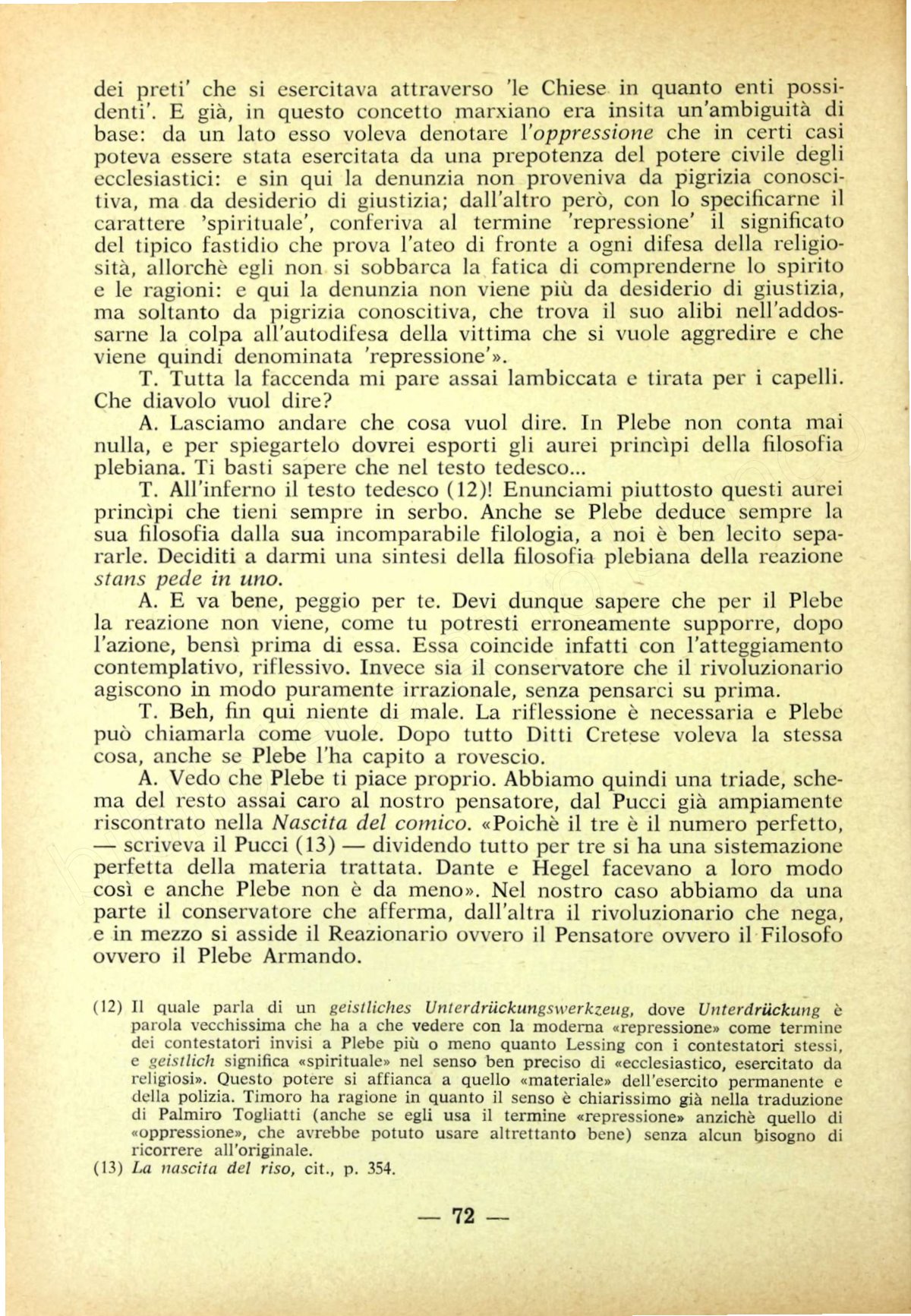
dei preti' che si esercitava attraverso 'le Chiese in quanto enti possi-
denti'. E già, in questo concetto marxiano era insita un'ambiguità di
base: da un lato esso voleva denotare
l'oppressione
che in certi casi
poteva essere stata esercitata da una prepotenza del potere civile degli
ecclesiastici: e sin qui la denunzia non proveniva da pigrizia conosci-
tiva, ma da desiderio di giustizia; dall'altro però, con lo specificarne il
carattere 'spirituale', conferiva a l termine repressione' i l significato
del tipico fastidio che prova l'ateo di fronte a ogni difesa della religio-
sità, allorchè egli non. si sobbarca la fatica di comprenderne lo spirito
e le ragioni: e qui la denunzia non viene più da desiderio di giustizia,
ma soltanto da pigrizia conoscitiva, che trova i l suo alibi nell'addos-
sarne la colpa all'autodifesa della vittima che si vuole aggredire e che
viene quindi denominata 'repressione'».
T. Tutta la faccenda mi pare assai lambiccata e tirata per i capelli.
Che diavolo vuol dire?
A. Lasciamo andare che cosa vuol dire. I n Plebe non conta mai
nulla, e per spiegartelo dovrei esporti gli aurei princìpi della filosofia
plebiana. Ti basti sapere che nel testo tedesco...
T. All'inferno il testo tedesco (12)! Enunciami piuttosto questi aurei
princìpi che tieni sempre in serbo. Anche se Plebe deduce sempre la
sua filosofia dalla sua incomparabile filologia, a noi è ben lecito sepa-
rarle. Deciditi a darmi una sintesi della filosofia plebiana della reazione
stans pede in uno.
A. E va bene, peggio per te. Devi dunque sapere che per i l Plebe
la reazione non viene, come tu potresti erroneamente supporre, dopo
l'azione, bensì prima di essa. Essa coincide infatti con l'atteggiamento
contemplativo, riflessivo. Invece sia il conservatore che il rivoluzionario
agiscono in modo puramente irrazionale, senza pensarci su prima.
T. Beh, fin qui niente di male. La riflessione è necessaria e Plebe
può chiamarla come vuole. Dopo tutto Ditti Cretese voleva la stessa
cosa, anche se Plebe l'ha capito a rovescio.
A. Vedo che Plebe ti piace proprio. Abbiamo quindi una triade, sche-
ma del resto assai caro al nostro pensatore, dal Pucci già ampiamente
riscontrato nella
Nascita del comico.
«Poichè il tre è il numero perfetto,
scriveva il Pucci (13) — dividendo tutto per tre si ha una sistemazione
perfetta della materia trattata. Dante e Hegel facevano a loro modo
così e anche Plebe non è da meno». Nel nostro caso abbiamo da una
parte i l conservatore che afferma, dall'altra i l rivoluzionario che nega,
e in mezzo si asside il Reazionario ovvero il Pensatore ovvero il Filosofo
ovvero i l Plebe Armando.
(12) I l quale parla d i un
geistliches Unterdriickungswerkzeug, dove Unterdri ickung è
parola vecchissima che ha a che vedere con la moderna «repressione» come termine
dei contestatori invisi a Plebe più o meno quanto Lessing con i contestatori stessi,
e
geistlich
significa «spirituale» nel senso ben preciso d i «ecclesiastico, esercitato da
religiosi». Questo potere s i affianca a quello «materiale» dell'esercito permanente e
della polizia. Timoro ha ragione in quanto i l senso è chiarissimo già nella traduzione
di Palmi ro Togl iat t i (anche se egl i usa i l termine «repressione» anzichè quel lo d i
«oppressione», che avrebbe potuto usare altrettanto bene) senza alcun bisogno d i
ricorrere all'originale.
(13) La nascita del riso, cit., p. 354.
72 —
















