
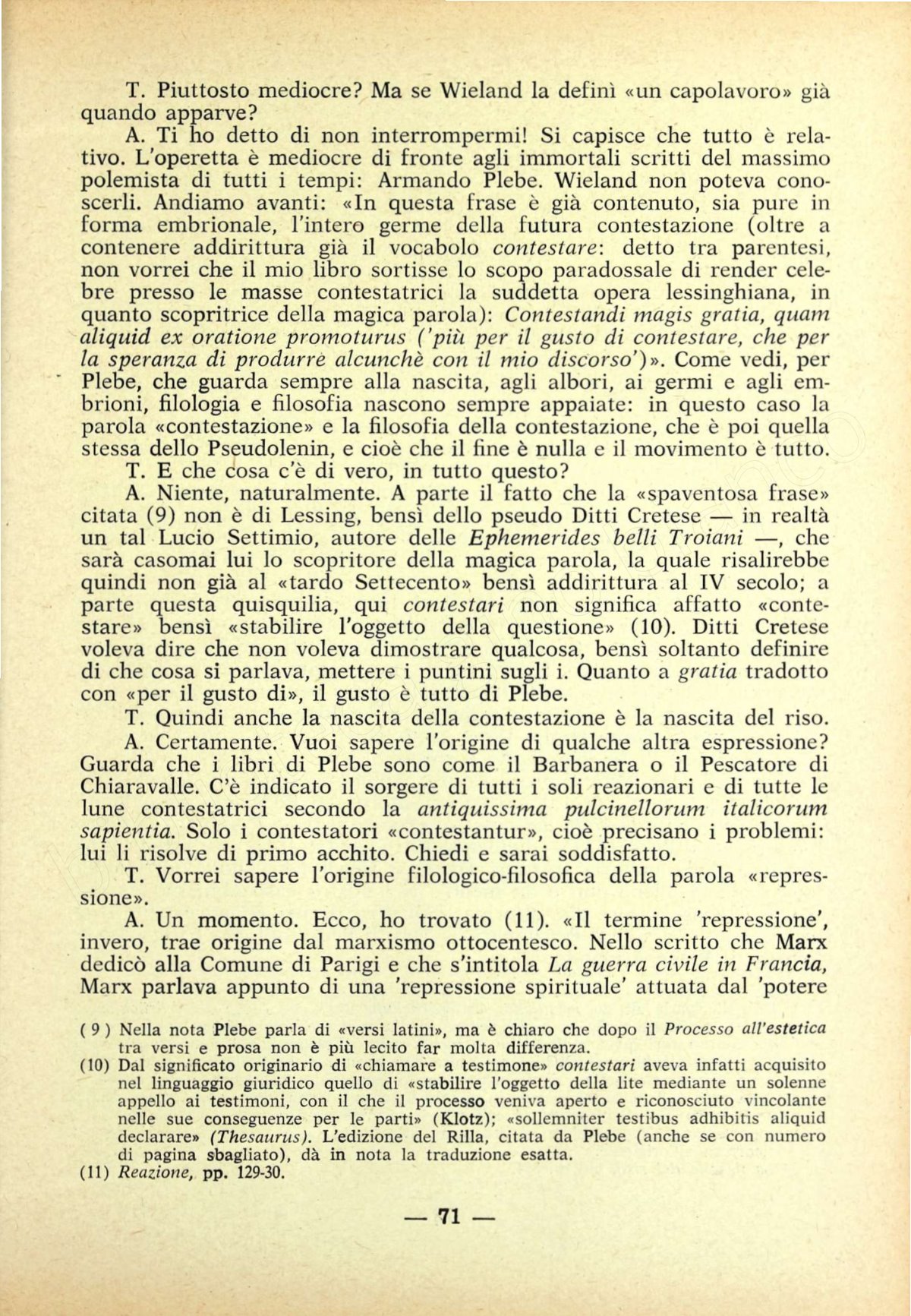
T. Piuttostomediocre? Ma seWieland la definì «un capolavoro» già
quandoapparve?
A. Ti ho detto di non interrompermi! Si capisce che tutto è rela-
tivo. L'operetta è mediocre di fronte agli immortali scritti del massimo
polemista di tutti i tempi: Armando Plebe. Wieland non poteva cono-
scerli. Andiamo avanti: «In questa frase è già contenuto, sia pure in
forma embrionale, l'intero germe della futura contestazione (oltre a
contenere addirittura già i l vocabolo
contestare:
detto tra parentesi,
non vorrei che il mio libro sortisse lo scopoparadossale di render cele-
bre presso le masse contestatrici la suddetta opera lessinghiana, in
quanto scopritrice della magica parola):
Contestandi magis gratia, quam
aliquid ex oratione promoturus ('più per il gusto di contestare, che per
la speranza di produrre alcunchè con il mio discorso')». Come vedi, per
Plebe, che guarda sempre alla nascita, agli albori, ai germi e agli em-
brioni, filologia e filosofia nascono sempre appaiate: in questo caso la
parola «contestazione» e la filosofia della contestazione, che è poi quella
stessadello Pseudolenin, e cioè che il fine è nulla e il movimento è tutto.
T. E che cosa c'è di vero, in tutto questo?
A. Niente, naturalmente. A parte il fatto che la «spaventosa frase»
citata (9) non è di Lessing, bensì dello pseudo Ditti Cretese — in realtà
un tal Lucio Settimi°, autore delle
Ephemerides belli Troiani —,
che
saràcasomai lui lo scopritore della magica parola, la quale risalirebbe
quindi non già al «tardo Settecento» bensì addirittura al IV secolo; a
parte questa quisquilia, qui
contestari
non significa affatto «conte-
stare» bensì «stabilire l'oggetto della questione» (10). Ditti Cretese
voleva dire che non voleva dimostrare qualcosa, bensì soltanto definire
di checosa si parlava, mettere i puntini sugli i. Quanto a
gratia
tradotto
con«per il gusto di», il gusto è tutto di Plebe.
T. Quindi anche la nascita della contestazione è la nascita del riso.
A. Certamente. Vuoi sapere l'origine di qualche altra espressione?
Guarda che i libri di Plebe sono come i l Barbanera o i l Pescatore di
Chiaravalle. C'è indicato il sorgere di tutti i soli reazionari e di tutte le
lune contestatrici secondo l a antiquissima pulcinellorum italicorum
sapientia.
Solo i contestatori «contestantur», cioè precisano i problemi:
lui li risolve di primo acchito. Chiedi e sarai soddisfatto.
T. Vorrei sapere l'origine filologico-filosofica della parola «repres-
sione».
A. Un momento. Ecco, ho trovato (11). «I l termine 'repressione',
invero, trae origine dal marxismo ottocentesco. Nello scritto che Marx
dedicò alla Comune di Parigi e che s'intitola
La guerra civile in Francia,
Marx parlava appunto di una 'repressione spirituale' attuata dal 'potere
( 9 ) Nella nota Plebe parla di «versi latini», ma è chiaro che dopo i l
Processo all'estetica
tra versi e prosa non è più lecito far molta differenza.
(10) Dal significato originario di «chiamare a testimone»
contestari aveva
infatti acquisito
nel linguaggio giuridico quello di «stabilire l'oggetto della lite mediante un solenne
appello ai testimoni, con i l che i l processo veniva aperto e riconosciuto vincolante
nelle sue conseguenze per le parti» (Klotz); «sollemniter testibus adhibitis aliquid
declarare»
(Thesaurus).
L'edizione del Rilla, citata da Plebe (anche se con numero
di pagina sbagliato), dà in nota la traduzione esatta.
(11)
Reazione,
pp. 129-30.
71 —
















