
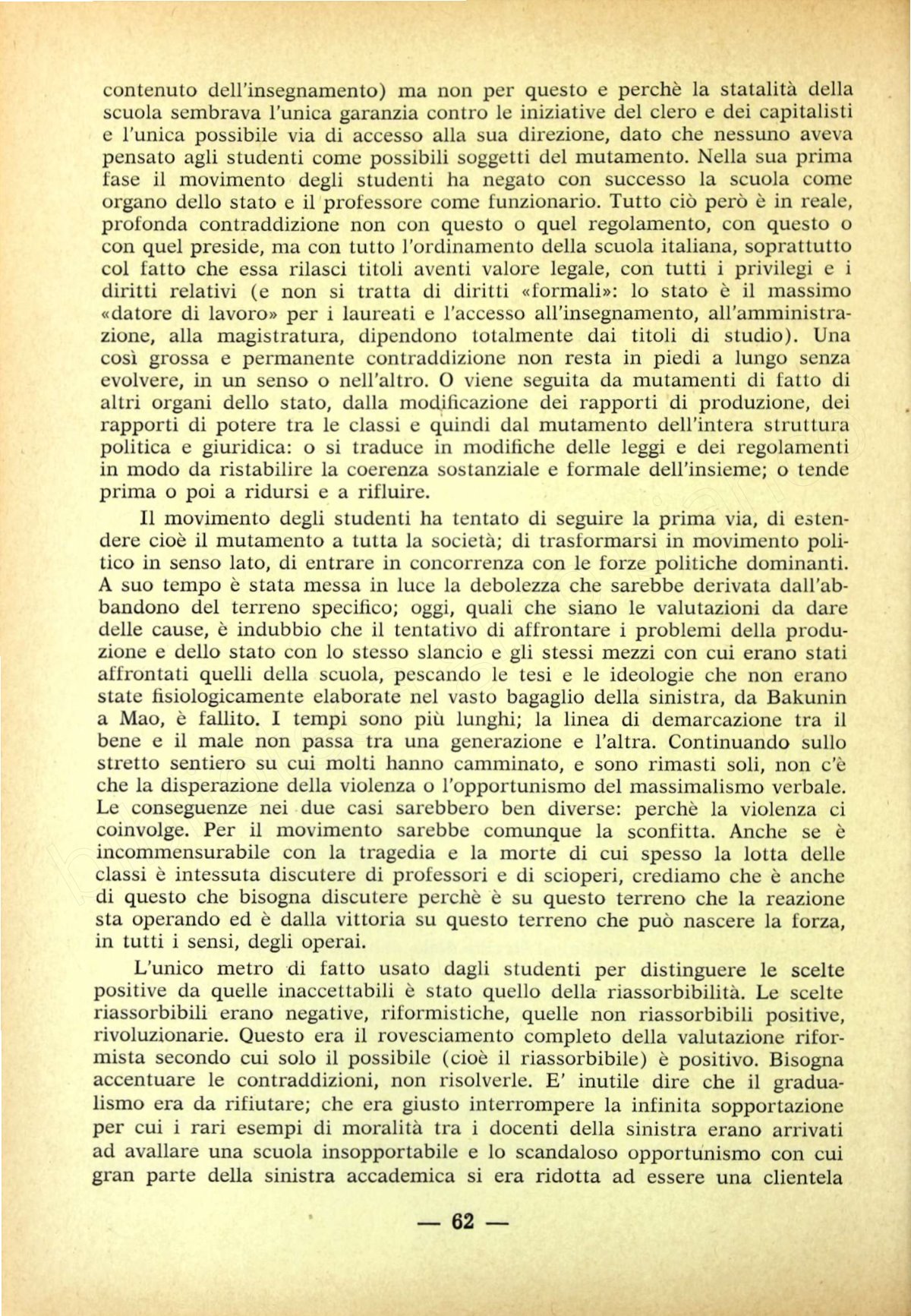
contenuto dell'insegnamento) ma non per questo e perchè la statalità della
scuola sembrava l'unica garanzia contro le iniziative del clero e dei capitalisti
e l'unica possibile via di accesso alla sua direzione, dato che nessuno aveva
pensato agli studenti come possibili soggetti del mutamento. Nella sua prima
fase i l movimento degli studenti ha negato con successo l a scuola come
organo dello stato e il professore come funzionario. Tutto ciò però è in reale,
profonda contraddizione non con questo o quel regolamento, con questo o
con quel preside, ma con tutto l'ordinamento della scuola italiana, soprattutto
col fatto che essa rilasci titoli aventi valore legale, con tutti i privilegi e i
diritti relativi ( e non si tratta di diritti «formali»: l o stato è i l massimo
«datore di lavoro» per i laureati e l'accesso all'insegnamento, all'amministra-
zione, al la magistratura, dipendono totalmente dai t i tol i d i studio). Una
così grossa e permanente contraddizione non resta in piedi a lungo senza
evolvere, in un senso o nell'altro. O viene seguita da mutamenti di fatto di
altri organi dello stato, dalla modificazione dei rapporti di produzione, dei
rapporti di potere tra le classi e quindi dal mutamento dell'intera struttura
politica e giuridica: o si traduce in modifiche delle leggi e dei regolamenti
in modo da ristabilire la coerenza sostanziale e formale dell'insieme; o tende
prima o poi a ridursi e a rifluire.
I l movimento degli studenti ha tentato di seguire la prima via, di esten-
dere cioè il mutamento a tutta la società; di trasformarsi in movimento poli-
tico in senso lato, di entrare in concorrenza con le forze politiche dominanti.
A suo tempo è stata messa in luce la debolezza che sarebbe derivata dall'ab-
bandono del terreno specifico; oggi, quali che siano le valutazioni da dare
delle cause, è indubbio che i l tentativo di affrontare i problemi della produ-
zione e dello stato con lo stesso slancio e gli stessi mezzi con cui erano stati
affrontati quelli della scuola, pescando le tesi e le ideologie che non erano
state fisiologicamente elaborate nel vasto bagaglio della sinistra, da Bakunin
a Mao, è fallito. I tempi sono più lunghi; l a linea di demarcazione t ra i l
bene e i l male non passa tra una generazione e l'altra. Continuando sullo
stretto sentiero su cui molti hanno camminato, e sono rimasti soli, non c'è
che la disperazione della violenza o l'opportunismo del massimalismo verbale.
Le conseguenze nei due casi sarebbero ben diverse: perchè l a violenza ci
coinvolge. Per i l movimento sarebbe comunque l a sconfitta. Anche se è
incommensurabile con l a tragedia e l a morte d i cui spesso l a lotta delle
classi è intessuta discutere di professori e di scioperi, crediamo che è anche
di questo che bisogna discutere perchè è su questo terreno che la reazione
sta operando ed è dalla vittoria su questo terreno che può nascere la forza,
in tutti i sensi, degli operai.
L'unico metro •di fatto usato dagli studenti per distinguere l e scelte
positive da quelle inaccettabili è stato quello della riassorbibilità. Le scelte
riassorbibili erano negative, riformistiche, quelle non riassorbibili positive,
rivoluzionarie. Questo era i l rovesciamento completo della valutazione rifor-
mista secondo cui solo i l possibile (cioè i l riassorbibile) è positivo. Bisogna
accentuare l e contraddizioni, non risolverle. E ' inutile dire che i l gradua-
lismo era da rifiutare; che era giusto interrompere la infinita sopportazione
per cui i rari esempi di moralità tra i docenti della sinistra erano arrivati
ad avallare una scuola insopportabile e lo scandaloso opportunismo con cui
gran parte della sinistra accademica si era ridotta ad essere una clientela
62
















