
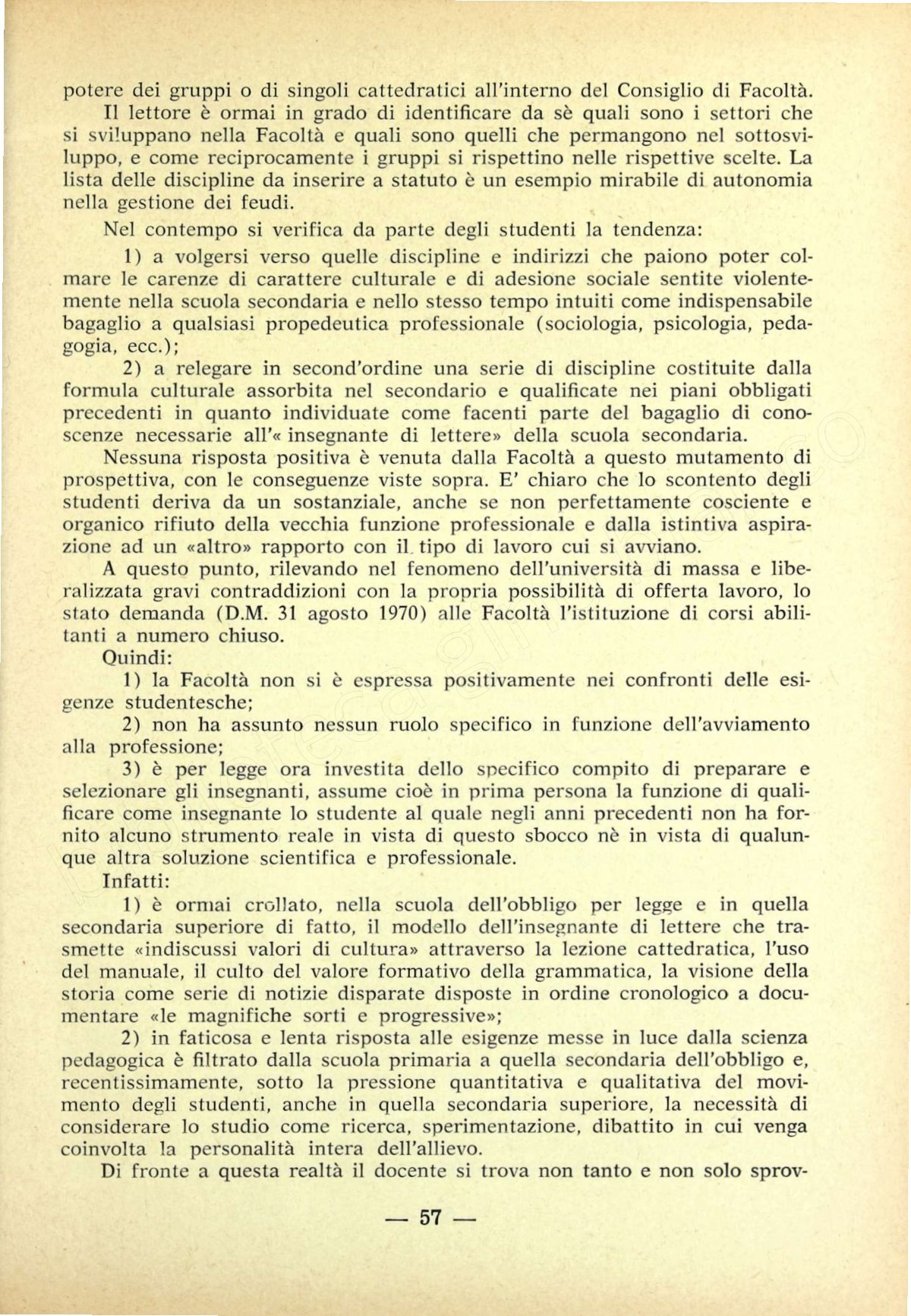
potere dei gruppi o di singoli cattedratici all'interno del Consiglio di Facoltà.
Il lettore è ormai in grado di identificare da sè quali sono i settori che
si sviluppano nella Facoltà e quali sono quelli che permangono nel sottosvi-
luppo, e come reciprocamente i gruppi si rispettino nelle rispettive scelte. La
lista delle discipline da inserire a statuto è un esempio mirabile di autonomia
nella gestione dei feudi.
Nel contempo si verifica da parte degli studenti la tendenza:
1) a volgersi verso quelle discipline e indirizzi che paiono poter col-
mare le carenze di carattere culturale e di adesione sociale sentite violente-
mente nella scuola secondaria e nello stesso tempo intuiti come indispensabile
bagaglio a qualsiasi propedeutica professionale (sociologia, psicologia, peda-
gogia, ecc.);
2) a relegare in second'ordine una serie di discipline costituite dalla
formula culturale assorbita nel secondario e qualificate nei piani obbligati
precedenti i n quanto individuate come facenti parte del bagaglio di cono-
scenze necessarie all'« insegnante di lettere» della scuola secondaria.
Nessuna risposta positiva è venuta dalla Facoltà a questo mutamento di
prospettiva, con le conseguenze viste sopra. E' chiaro che lo scontento degli
studenti deriva da un sostanziale, anche se non perfettamente cosciente e
organico rifiuto della vecchia funzione professionale e dalla istintiva aspira-
zione ad un «altro» rapporto con il. tipo di lavoro cui si avviano.
Aquesto punto, rilevando nel fenomeno dell'università di massa e libe-
ralizzata gravi contraddizioni con la propria possibilità di offerta lavoro, lo
stato demanda (D.M. 31 agosto 1970) alle Facoltà l'istituzione di corsi abili-
tanti a numero chiuso.
Quindi:
1) la Facoltà non si è espressa positivamente nei confronti delle esi-
genze studentesche;
2) non ha assunto nessun ruolo specifico in funzione dell'avviamento
alla professione;
3) è per legge ora investita dello specifico compito d i preparare e
selezionare gli insegnanti, assume cioè in prima persona la funzione di quali-
ficare come insegnante lo studente al quale negli anni precedenti non ha for-
nito alcuno strumento reale in vista di questo sbocco nè in vista di qualun-
que altra soluzione scientifica e professionale.
Infatti:
1) è ormai crollato, nella scuola dell'obbligo per legge e i n quella
secondaria superiore di fatto, i l modello dell'insegnante di lettere che tra-
smette «indiscussi valori di cultura» attraverso la lezione cattedratica, l'uso
del manuale, i l culto del valore formativo della grammatica, la visione della
storia come serie di notizie disparate disposte in ordine cronologico a docu-
mentare «le magnifiche sorti e progressive»;
2) in faticosa e lenta risposta alle esigenze messe in luce dalla scienza
pedagogica è filtrato dalla scuola primaria a quella secondaria dell'obbligo e,
recentissimamente, sotto l a pressione quantitativa e qualitativa del movi-
mento degli studenti, anche in quella secondaria superiore, la necessità di
considerare lo studio come ricerca, sperimentazione, dibattito in cui venga
coinvolta la personalità intera dell'allievo.
Di fronte a questa realtà il docente si trova non tanto e non solo sprov-
57
















