
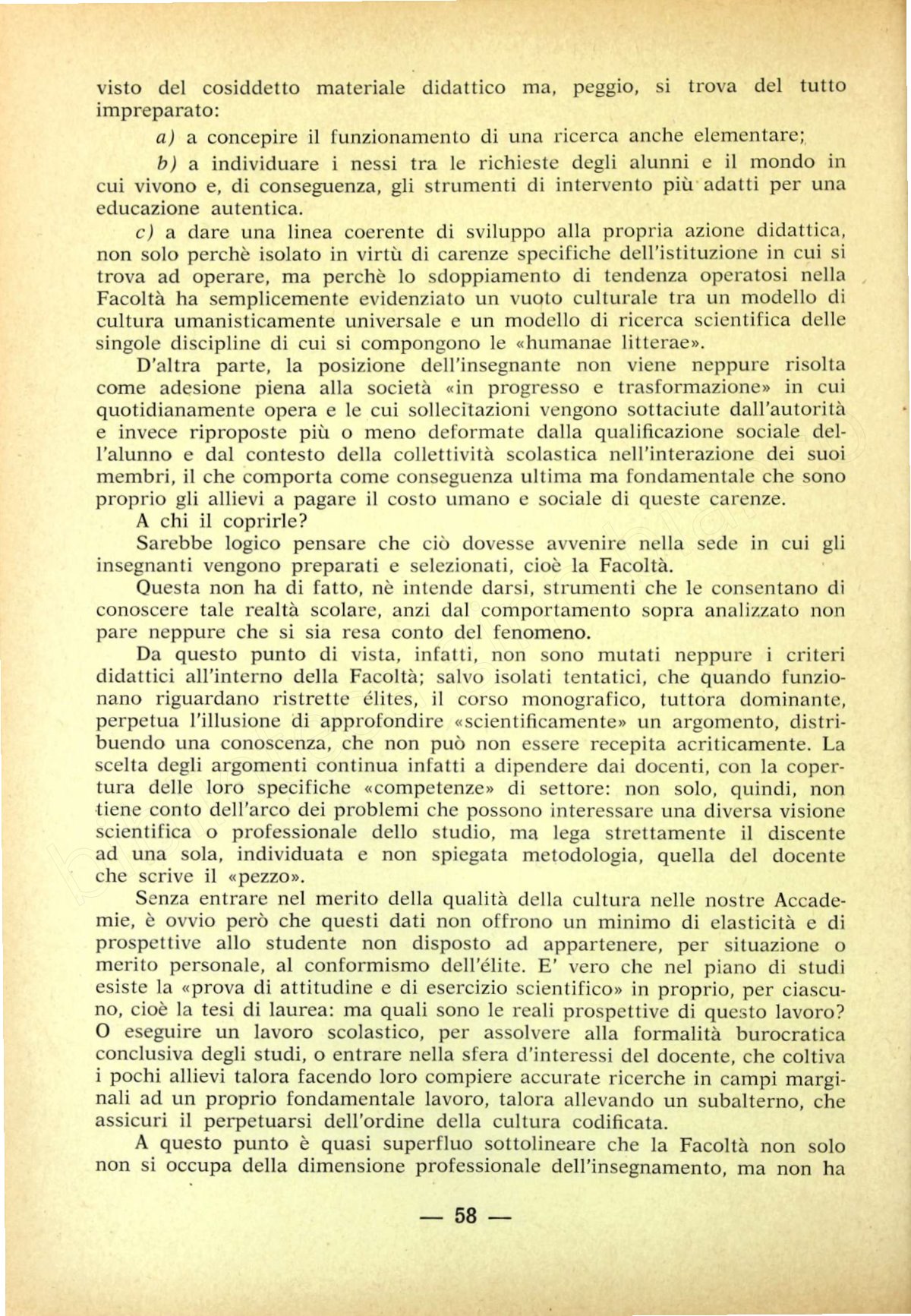
visto de l cosiddetto materiale didattico ma , peggio, s i trova de l tut to
impreparato:
a)
a concepire i l funzionamento di una ricerca anche elementare;,
b)
a individuare i nessi t ra le richieste degli alunni e i l mondo in
cui vivono e, di conseguenza, gli strumenti di intervento più •adatti per una
educazione autentica.
c)
a dare una linea coerente di sviluppo alla propria azione didattica,
non solo perchè isolato in virtù di carenze specifiche dell'istituzione in cui si
trova ad operare, ma perchè lo sdoppiamento di tendenza operatosi nella
Facoltà ha semplicemente evidenziato un vuoto culturale tra un modello di
cultura umanisticamente universale e un modello di ricerca scientifica delle
singole discipline di cui si compongono le «humanae litterae».
D'altra parte, l a posizione dell'insegnante non viene neppure risolta
come adesione piena alla società «in progresso e trasformazione» i n cui
quotidianamente opera e le cui sollecitazioni vengono sottaciute dall'autorità
e invece riproposte più o meno deformate dalla qualificazione sociale del-
l'alunno e dal contesto della collettività scolastica nell'interazione dei suoi
membri, il che comporta come conseguenza ultima ma fondamentale che sono
proprio gli allievi a pagare i l costo umano e sociale di queste carenze.
A chi i l coprirle?
Sarebbe logico pensare che ciò dovesse avvenire nella sede in cui gl i
insegnanti vengono preparati e selezionati, cioè la Facoltà.
Questa non ha di fatto, nè intende darsi, strumenti che le consentano di
conoscere tale realtà scolare, anzi dal comportamento sopra analizzato non
pare neppure che si sia resa conto del fenomeno.
Da questo punto d i vista, infatti, non sono mutati neppure i criteri
didattici all'interno della Facoltà; salvo isolati tentatici, che quando funzio-
nano riguardano ristrette élites, i l corso monografico, tuttora dominante,
perpetua l'illusione di approfondire «scientificamente» un argomento, distri-
buendo una conoscenza, che non può non essere recepita acriticamente. La
scelta degli argomenti continua infatti a dipendere dai docenti, con la coper-
tura delle loro specifiche «competenze» d i settore: non solo, quindi, non
tiene conto dell'arco dei problemi che possono interessare una diversa visione
scientifica o professionale dello studio, ma lega strettamente i l discente
ad una sola, individuata e non spiegata metodologia, quella del docente
che scrive i l «pezzo».
Senza entrare nel merito della qualità della cultura nelle nostre Accade-
mie, è ovvio però che questi dati non offrono un minimo di elasticità e di
prospettive al lo studente non disposto ad appartenere, per situazione o
merito personale, al conformismo dell'élite. E ' vero che nel piano di studi
esiste la «prova di attitudine e di esercizio scientifico» in proprio, per ciascu-
no, cioè la tesi di laurea: ma quali sono le reali prospettive di questo lavoro?
O eseguire un lavoro scolastico, per assolvere al la formalità burocratica
conclusiva degli studi, o entrare nella sfera d'interessi del docente, che coltiva
i pochi allievi talora facendo loro compiere accurate ricerche in campi margi-
nali ad un proprio fondamentale lavoro, talora allevando un subalterno, che
assicuri i l perpetuarsi dell'ordine della cultura codificata.
A questo punto è quasi superfluo sottolineare che la Facoltà non solo
non si occupa della dimensione professionale dell'insegnamento, ma non ha
58
















