
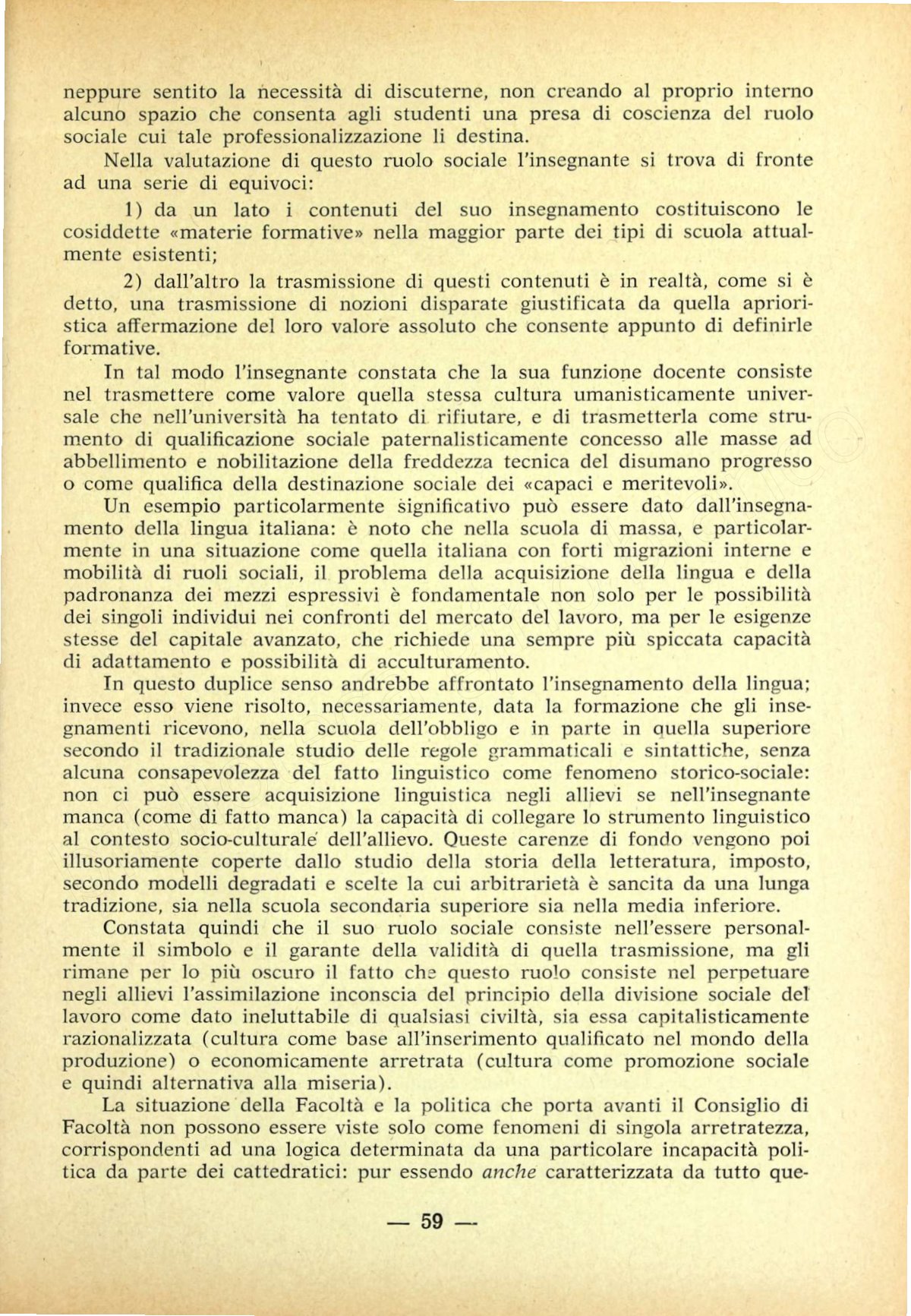
neppure sentito la necessità di discuterne, non creando al proprio interno
alcuno spazio che consenta agli studenti una presa di coscienza del molo
sociale cui tale professionalizzazione l i destina.
•
Nella valutazione di questo ruolo sociale l'insegnante si trova di fronte
ad una serie di equivoci:
1) da u n lato i contenuti de l suo insegnamento costituiscono l e
cosiddette «materie formative» nella maggior parte dei tipi di scuola attual-
mente esistenti;
2) dall'altro la trasmissione di questi contenuti è in realtà, come si è
detto, una trasmissione di nozioni disparate giustificata da quella apriori-
stica affermazione del loro valore assoluto che consente appunto di definirle
formative.
In tal modo l'insegnante constata che la sua funzione docente consiste
nel trasmettere come valore quella stessa cultura umanisticamente univer-
sale che nell'università ha tentato di rifiutare, e di trasmetterla come stru-
mento di qualificazione sociale paternalisticamente concesso alle masse ad
abbellimento e nobilitazione della freddezza tecnica del disumano progresso
o come qualifica della destinazione sociale dei «capaci e meritevoli».
Un esempio particolarmente àignificativo può essere dato dall'insegna-
mento della lingua italiana: è noto che nella scuola di massa, e particolar-
mente in una situazione come quella italiana con forti migrazioni interne e
mobilità di ruoli sociali, i l problema della acquisizione della lingua e della
padronanza dei mezzi espressivi è fondamentale non solo per le possibilità
dei singoli individui nei confronti del mercato del lavoro, ma per le esigenze
stesse del capitale avanzato, che richiede una sempre più spiccata capacità
di adattamento e possibilità di acculturamento.
In questo duplice senso andrebbe affrontato l'insegnamento della lingua;
invece esso viene risolto, necessariamente, data la formazione che gli inse-
gnamenti ricevono, nella scuola dell'obbligo e in parte in quella superiore
secondo i l tradizionale studio delle regole grammaticali e sintattiche, senza
alcuna consapevolezza del fatto linguistico come fenomeno storico-sociale:
non c i può essere acquisizione linguistica negli allievi se nell'insegnante
manca (come di fatto manca) la capacità di collegare lo strumento linguistico
al contesto socio-culturali dell'allievo. Queste carenze di fondo vengono poi
illusoriamente coperte dallo studio della storia della letteratura, imposto,
secondo modelli degradati e scelte la cui arbitrarietà è sancita da una lunga
tradizione, sia nella scuola secondaria superiore sia nella media inferiore.
Constata quindi che i l suo molo sociale consiste nell'essere personal-
mente i l simbolo e i l garante della validità di quella trasmissione, ma gli
rimane per lo più oscuro i l fatto che questo ruolo consiste nel perpetuare
negli allievi l'assimilazione inconscia del principio della divisione sociale dei
lavoro come dato ineluttabile di qualsiasi civiltà, sia essa capitalisticamente
razionalizzata (cultura come base all'inserimento qualificato nel mondo della
produzione) o economicamente arretrata (cultura come promozione sociale
e quindi alternativa alla miseria).
La situazione della Facoltà e la politica che porta avanti i l Consiglio di
Facoltà non possono essere viste solo come fenomeni di singola arretratezza,
corrispondenti ad una logica determinata da una particolare incapacità poli-
tica da parte dei cattedratici: pur essendo
anche
caratterizzata da tutto que-
- 59 -
















