
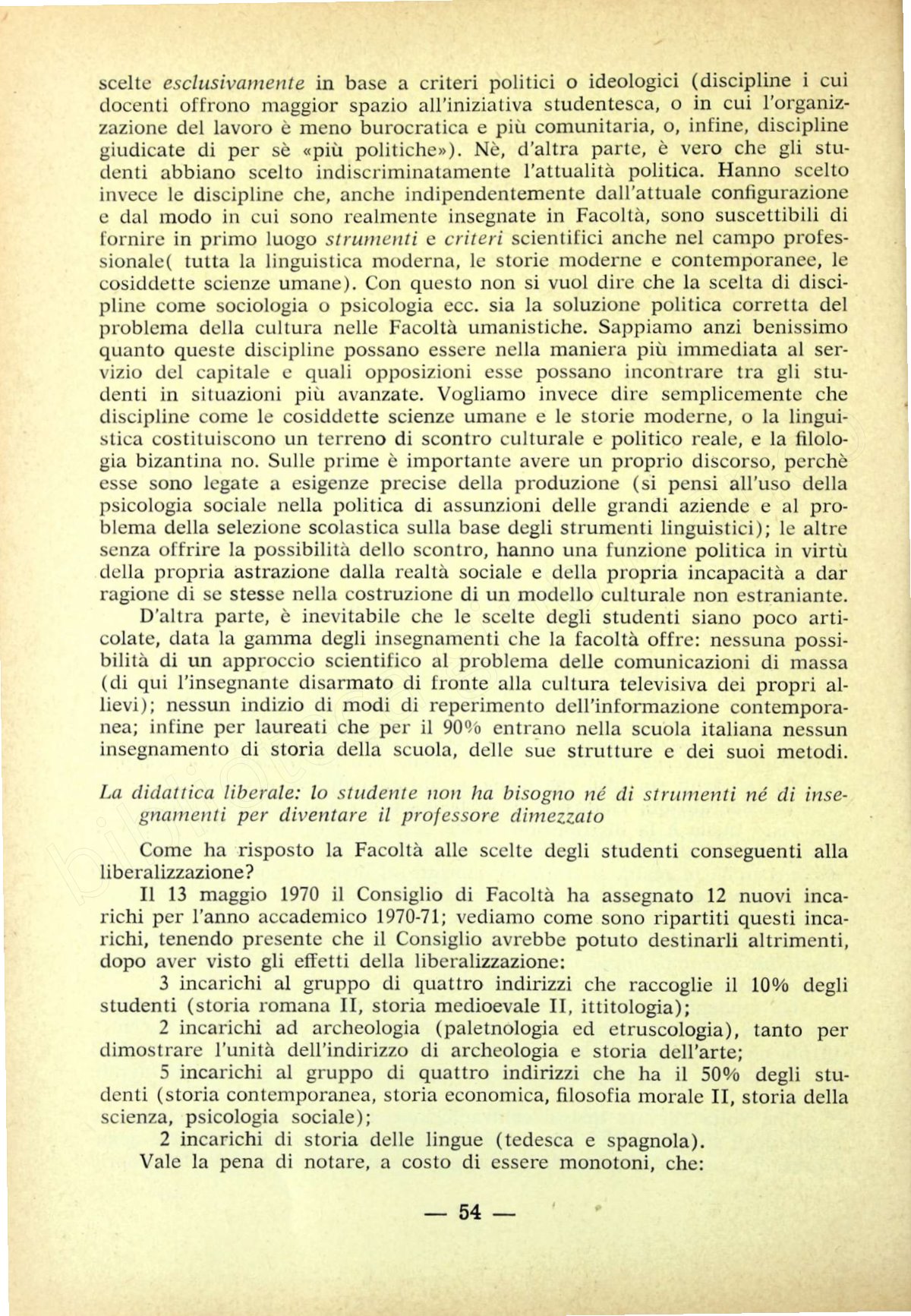
scelte
esclusivamente
in base a criteri politici o ideologici (discipline i cui
docenti offrono maggior spazio all'iniziativa studentesca, o in cui l'organiz-
zazione del lavoro è meno burocratica e più comunitaria, o, infine, discipline
giudicate di per sè «più politiche»). Nè, d'altra parte, è vero che gl i stu-
denti abbiano scelto indiscriminatamente l'attualità politica. Hanno scelto
invece le discipline che, anche indipendentemente dall'attuale configurazione
e dal modo in cui sono realmente insegnate in Facoltà, sono suscettibili di
fornire in primo luogo
strumenti
e
criteri
scientifici anche nel campo profes-
sionale( tutta la linguistica moderna, le storie moderne e contemporanee, le
cosiddette scienze umane). Con questo non si vuol dire che la scelta di disci-
pline come sociologia o psicologia ecc. sia la soluzione politica corretta del
problema della cultura nelle Facoltà umanistiche. Sappiamo anzi benissimo
quanto queste discipline possano essere nella maniera più immediata al ser-
vizio del capitale e quali opposizioni esse possano incontrare t ra gl i stu-
denti i n situazioni più avanzate. Vogliamo invece dire semplicemente che
discipline come le cosiddette scienze umane e le storie moderne, o la lingui-
stica costituiscono un terreno di scontro culturale e politico reale, e la filolo-
gia bizantina no. Sulle prime è importante avere un proprio discorso, perchè
esse sono legate a esigenze precise della produzione (si pensi all'uso della
psicologia sociale nella politica di assunzioni delle grandi aziende e al pro-
blema della selezione scolastica sulla base degli strumenti linguistici); le altre
senza offrire la possibilità dello scontro, hanno una funzione politica in virtù
della propria astrazione dalla realtà sociale e della propria incapacità a dar
ragione di se stesse nella costruzione di un modello culturale non estraniante.
D'altra parte, è inevitabile che le scelte degli studenti siano poco arti-
colate, data la gamma degli insegnamenti che la facoltà offre: nessuna possi-
bilità di un approccio scientifico al problema delle comunicazioni di massa
(di qui l'insegnante disarmato di fronte alla cultura televisiva dei propri al-
lievi); nessun indizio di modi di reperimento dell'informazione contempora-
nea; infine per laureati che per i l 90% entrano nella scuola italiana nessun
insegnamento di storia della scuola, delle sue strutture e dei suoi metodi.
La didattica liberale: lo studente non ha bisogno né di strumenti né di inse-
gnamenti per diventare i l professore dimezzato
Come ha risposto la Facoltà alle scelte degli studenti conseguenti alla
liberalizzazione?
I l 13 maggio 1970 i l Consiglio di Facoltà ha assegnato 12 nuovi inca-
richi per l'anno accademico 1970-71; vediamo come sono ripartiti questi inca-
richi, tenendo presente che i l Consiglio avrebbe potuto destinarli altrimenti,
dopo aver visto gli effetti della liberalizzazione:
3 incarichi al gruppo di quattro indirizzi che raccoglie i l 10% degli
studenti (storia romana I I , storia medioevale I I , ittitologia);
2 incarichi ad archeologia (paletnologia ed etruscologia), tanto per
dimostrare l'unità dell'indirizzo di archeologia e storia dell'arte;
5 incarichi a l gruppo d i quattro indirizzi che ha i l 50% degli stu-
denti (storia contemporanea, storia economica, filosofia morale I I , storia della
scienza, psicologia sociale);
2 incarichi di storia delle lingue (tedesca e spagnola).
Vale la pena di notare, a costo di essere monotoni, che:
- 54 -
















