
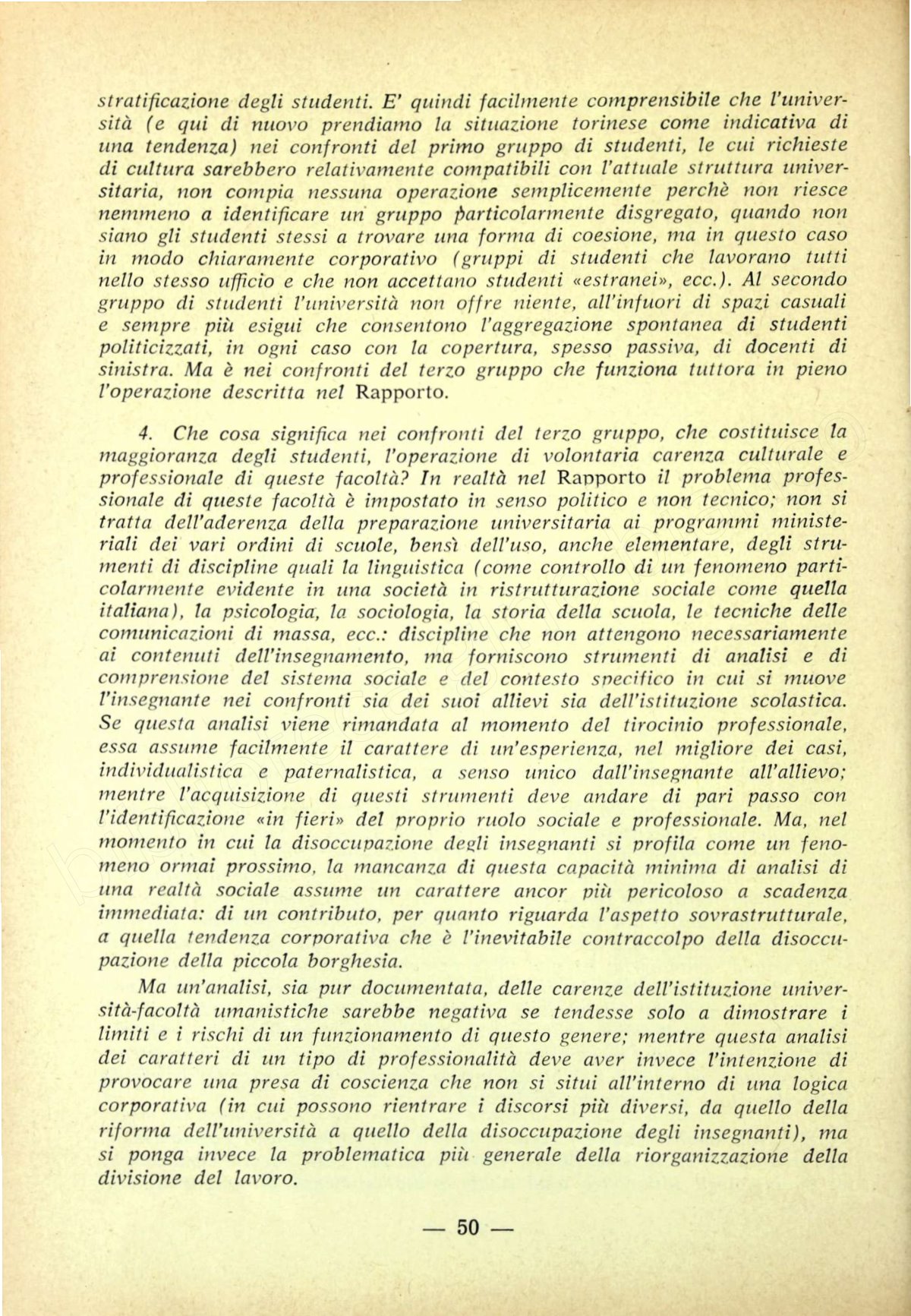
stratificazione degli studenti. E' quindi facilmente comprensibile che l'univer-
sità ( e qui d i nuovo prendiamo l a situazione torinese come indicativa d i
una tendenza) nei confronti del primo gruppo di studenti, le cui richieste
di cultura sarebbero relativamente compatibili con l'attuale struttura univer-
sitaria, non compia nessuna operazione semplicemente perchè non riesce
nemmeno a identificare un gruppo particolarmente disgregato, quando non
siano gli studenti stessi a trovare una forma di coesione, ma in questo caso
in modo chiaramente corporativo (gruppi d i studenti che lavorano tut t i
nello stesso ufficio e che non accettano studenti «estranei», ecc.). Al secondo
gruppo di studenti l'università non offre niente, all'infuori di spazi casuali
e sempre più esigui che consentono l'aggregazione spontanea d i studenti
politicizzati, i n ogni caso con l a copertura, spesso passiva, d i docenti d i
sinistra. Ma è nei confronti del terzo gruppo che funziona tuttora in pieno
l'operazione descritta nel Rapporto.
4. Che cosa significa nei confronti del terzo gruppo, che costituisce la
maggioranza degli studenti, l'operazione d i volontaria carenza culturale e
professionale di queste facoltà? I n realtà nel Rapporto i l problema profes-
sionale di queste facoltà è impostato in senso politico e non tecnico; non si
tratta dell'aderenza della preparazione universitaria a i programmi ministe-
riali dei vari ordini di scuole, bensì dell'uso, anche elementare, degli stru-
menti di discipline quali la linguistica (come controllo di un fenomeno parti-
colarmente evidente in una società in ristrutturazione sociale come quella
italiana), la psicologia', la sociologia, la storia della scuola, le tecniche delle
comunicazioni di massa, ecc.: discipline che non attengono necessariamente
ai contenuti dell'insegnamento, ma forniscono strumenti d i analisi e d i
comprensione del sistema sociale e del contesto specifico in cui si muove
l'insegnante nei confronti sia dei suoi allievi sia dell'istituzione scolastica.
Se questa analisi viene rimandata a l momento del tirocinio professionale,
essa assume facilmente i l carattere di un'esperienza, nel migliore dei casi,
individualistica e paternalistica, a senso unico dall'insegnante all'allievo;
mentre l'acquisizione d i questi strumenti deve andare d i par i passo con
l'identificazione «in fieri» del proprio ruolo sociale e professionale. Ma, nel
momento in cui la disoccupazione degli insegnanti si profila come un feno-
meno ormai prossimo, la mancanza di questa capacità minima di analisi di
una realtà sociale assume un carattere ancor più pericoloso a scadenza
immediata: di un contributo, per quanto riguarda l'aspetto sovrastrutturale,
a quella tendenza corporativa che è l'inevitabile contraccolpo della disoccu-
pazione della piccola borghesia.
Ma un'analisi, sia pur documentata, delle carenze dell'istituzione univer-
sità-facoltà umanistiche sarebbe negativa se tendesse solo a dimostrare i
limiti e i rischi di un funzionamento di questo genere; mentre questa analisi
dei caratteri di un tipo di professionalità deve aver invece l'intenzione d i
provocare una presa di coscienza che non si situi all'interno di una logica
corporativa ( in cui possono rientrare i discorsi più diversi, da quello della
riforma dell'università a quello della disoccupazione degli insegnanti), ma
si ponga invece l a problematica più• generale della riorganizzazione della
divisione del lavoro.
50 -
















