
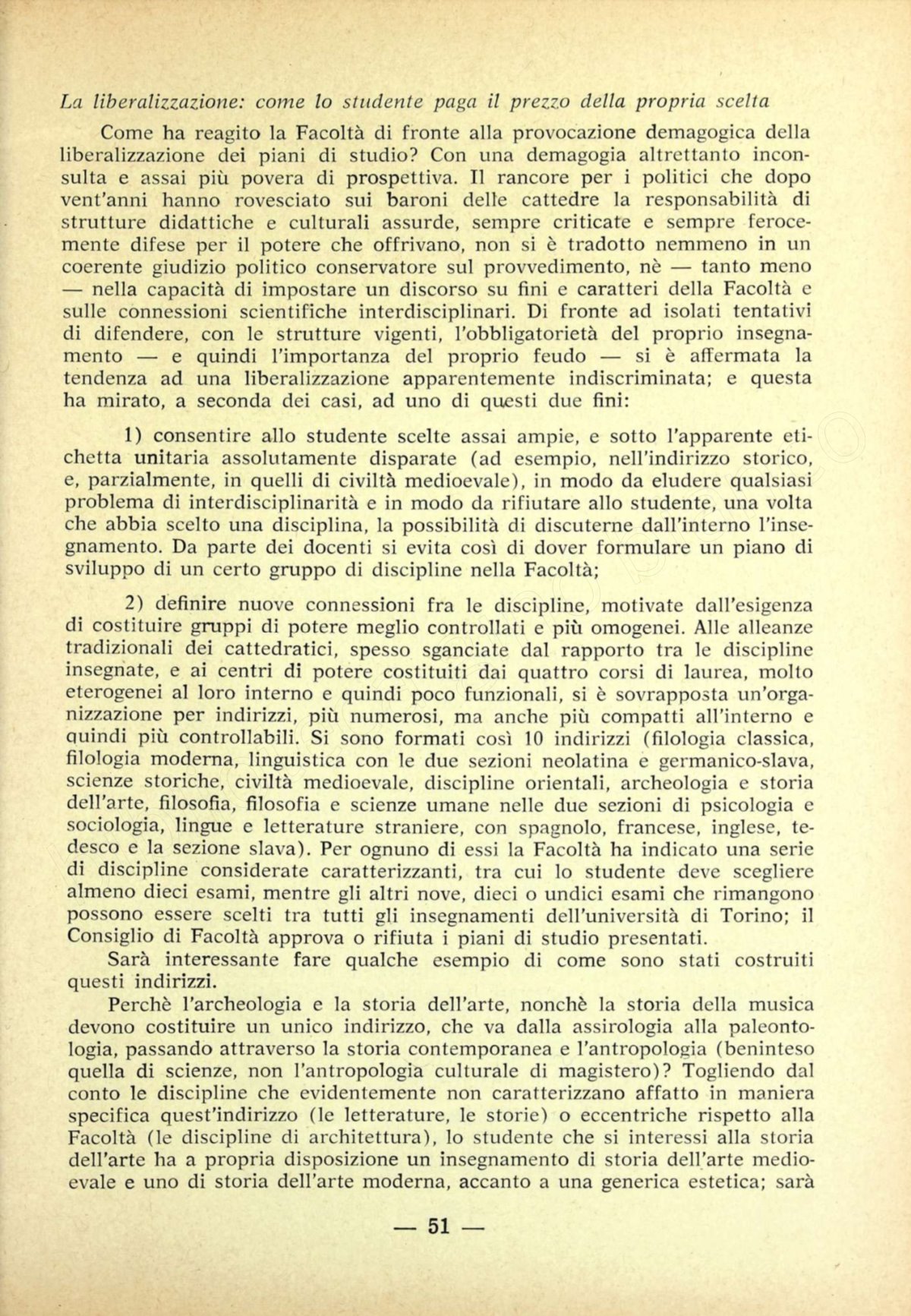
La liberalizzazione: come lo studente paga i l prezzo della propria scelta
Come ha reagito la Facoltà di fronte alla provocazione demagogica della
liberalizzazione dei piani d i studio? Con una demagogia al trettanto incon-
sulta e assai p i ù povera d i prospettiva. I l rancore per i pol i t ici che dopo
vent'anni hanno rovesciato su i baroni del le cattedre l a responsabilità d i
strutture didattiche e cul tural i assurde, sempre cri t icate e sempre feroce-
mente difese per i l potere che offrivano, non si è tradotto nemmeno i n un
coerente giudizio pol itico conservatore sul provvedimento, nè — tanto meno
nella capacità di impostare un discorso su f ini e caratteri della Facoltà e
sulle connessioni scientifiche interdiscipl inari. D i f ronte ad isolat i tentat ivi
di difendere, con l e st rut ture vigenti, l'obbligatorietà de l propr io insegna-
mento — e qu i nd i l ' importanza de l propr i o feudo — s i è affermata l a
tendenza ad una liberalizzazione apparentemente indiscriminata; e questa
ha mirato, a seconda dei casi, ad uno d i questi due f ini :
1) consentire al lo studente scelte assai ampie, e sotto l'apparente eti-
chetta uni tar ia assolutamente disparate ( ad esempio, nell ' indirizzo storico,
e, parzialmente, in quelli di civi ltà medioevale), in modo da eludere qualsiasi
problema di interdisciplinarità e in modo da rifiutare allo studente, una volta
che abbia scelto una disciplina, la possibilità di discuterne dall'interno l'inse-
gnamento. Da parte dei docenti si evita così d i dover formulare un piano di
sviluppo di un certo gruppo di discipline nella Facoltà;
2) definire nuove connessioni f r a l e discipline, motivate dall'esigenza
di costituire gruppi di potere meglio controllati e più omogenei. Al le alleanze
tradizionali dei cattedratici, spesso sganciate dal rapporto t r a l e discipline
insegnate, e ai centri d i potere cost i tui t i dai quat tro corsi d i laurea, mol to
eterogenei al loro interno e quindi poco funzionali, si è sovrapposta un'orga-
nizzazione per indirizzi, p i ù numerosi, ma anche p i ù compatti al l ' interno e
quindi p i ù controllabili. Si sono format i così 10 indirizzi (fi lologia classica,
filologia moderna, linguistica con le due sezioni neolatina e germanico-slava,
scienze storiche, civi l tà medioevale, discipline orientali, archeologia e storia
dell'arte, filosofia, filosofia e scienze umane nelle due sezioni d i psicologia e
sociologia, lingue e letterature straniere, con spagnolo, francese, inglese, te-
desco e la sezione slava). Per ognuno di essi la Facoltà ha indicato una serie
di discipl ine considerate caratterizzanti, t r a cui l o studente deve scegliere
almeno dieci esami, mentre gl i al tr i nove, dieci o undici esami che rimangono
possono essere scelti t r a t u t t i gl i insegnamenti dell'università d i Tor ino; i l
Consiglio di Facoltà approva o r i f iuta i piani di studio presentati.
Sarà interessante fare qualche esempio d i come sono s tat i cost rui t i
questi indirizzi.
Perchè l'archeologia e l a storia dell'arte, nonchè l a storia del la musica
devono costituire un unico indirizzo, che va dal la assirologia al la paleonto-
logia, passando attraverso la storia contemporanea e l'antropologia (beninteso
quella d i scienze, non l'antropologia culturale d i magistero)? Togliendo dal
conto le discipline che evidentemente non caratterizzano affatto i n maniera
specifica quest'indirizzo ( le letterature, le storie) o eccentriche rispetto al la
Facoltà ( le discipline di architettura), lo studente che si interessi alla storia
dell'arte ha a propria disposizione un insegnamento di storia dell'arte medio-
evale e uno di storia dell'arte moderna, accanto a una generica estetica; sarà
- 51
















