
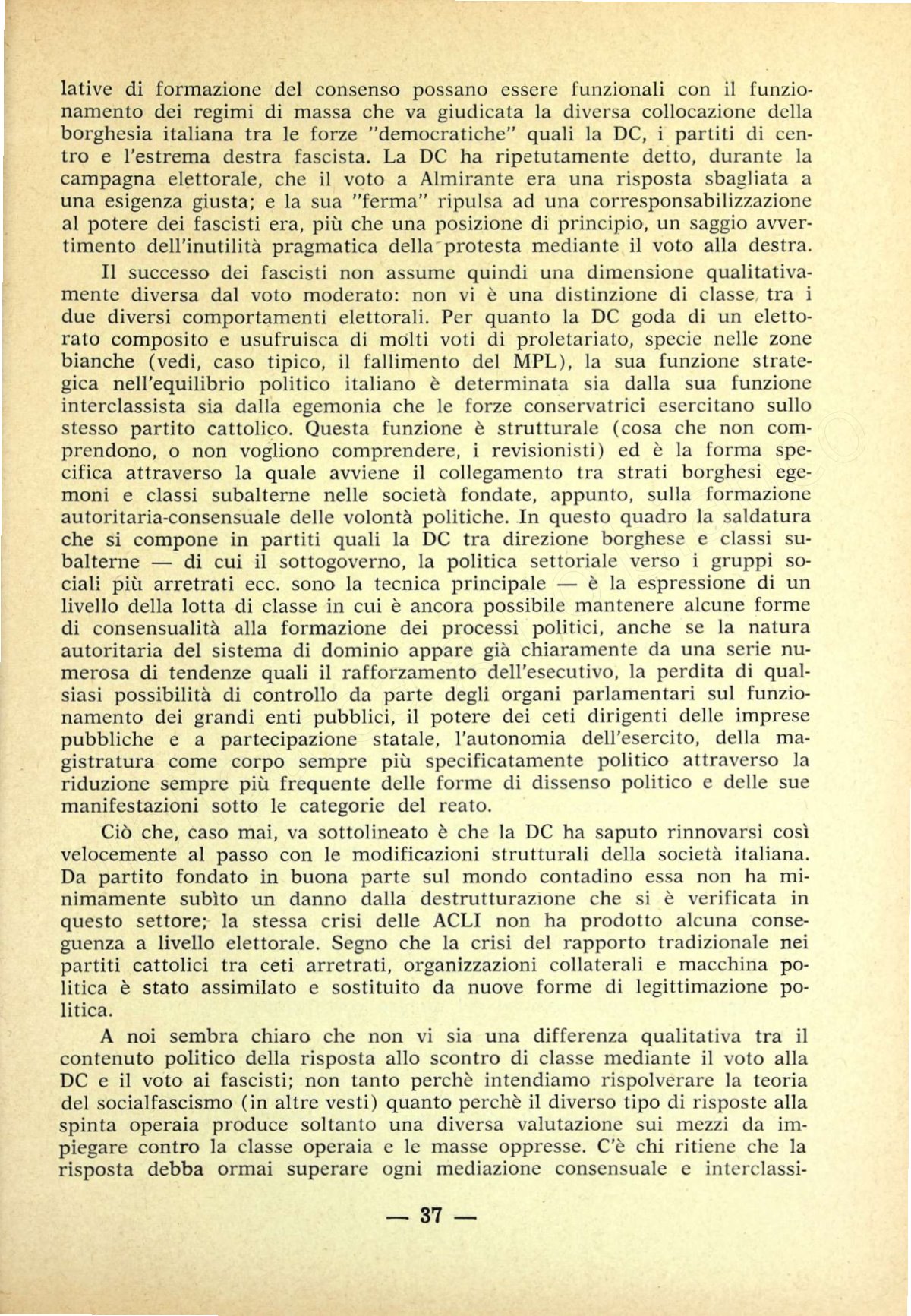
lative di formazione del consenso possano essere funzionali con i l funzio-
namento dei regimi di massa che va giudicata la diversa collocazione della
borghesia italiana tra le forze "democratiche" quali la DC, i partiti di cen-
tro e l'estrema destra fascista. La DC ha ripetutamente detto, durante l a
campagna elettorale, che i l voto a Almirante era una risposta sbagliata a
una esigenza giusta; e la sua "ferma" ripulsa ad una corresponsabilizzazione
al potere dei fascisti era, più che una posizione di principio, un saggio avver-
timento dell'inutilità pragmatica della-protesta mediante i l voto alla destra.
Il successo dei fascisti non assume quindi una dimensione qualitativa-
mente diversa dal voto moderato: non vi è una distinzione di classe, tra i
due diversi comportamenti elettorali. Per quanto la DC goda di un eletto-
rato composito e usufruisca di mi n i voti di proletariato, specie nelle zone
bianche (vedi, caso tipico, i l fallimento del MPL) , l a sua funzione strate-
gica nell'equilibrio politico italiano è determinata sia dalla sua funzione
interclassista sia dalla egemonia che le forze conservatrici esercitano sullo
stesso partito cattolico. Questa funzione è strutturale (cosa che non com-
prendono, o non vogliono comprendere, i revisionisti) ed è l a forma spe-
cifica attraverso l a quale avviene i l collegamento t ra strati borghesi ege-
moni e classi subalterne nelle società fondate, appunto, sulla formazione
autoritaria-consensuale delle volontà politiche. In questo quadro la saldatura
che si compone in partiti quali l a DC t ra direzione borghese e classi su-
balterne — di cui i l sottogoverno, la politica settoriale verso i gruppi so-
ciali più arretrati ecc. sono la tecnica principale — è la espressione di un
livello della lotta di classe in cui è ancora possibile mantenere alcune forme
di consensualità alla formazione dei processi politici, anche se l a natura
autoritaria del sistema di dominio appare già chiaramente da una serie nu-
merosa di tendenze quali i l rafforzamento dell'esecutivo, la perdita di qual-
siasi possibilità di controllo da parte degli organi parlamentari sul funzio-
namento dei grandi enti pubblici, i l potere dei ceti dirigenti delle imprese
pubbliche e a partecipazione statale, l'autonomia dell'esercito, della ma-
gistratura come corpo sempre più specificatamente politico attraverso l a
riduzione sempre più frequente delle forme di dissenso politico e delle sue
manifestazioni sotto le categorie del reato.
Ciò che, caso mai, va sottolineato è che la DC ha saputo rinnovarsi così
velocemente al passo con le modificazioni strutturali della società italiana.
Da partito fondato in buona parte sul mondo contadino essa non ha mi -
nimamente subìto un danno dalla destrutturazione che si è verificata i n
questo settore; l a stessa crisi delle ACLI non ha prodotto alcuna conse-
guenza a livello elettorale. Segno che la crisi del rapporto tradizionale nei
partiti cattolici t ra ceti arretrati, organizzazioni collaterali e macchina po-
litica è stato assimilato e sostituito da nuove forme di legittimazione po-
litica.
A noi sembra chiaro che non vi sia una differenza qualitativa t ra i l
contenuto politico della risposta allo scontro di classe mediante i l voto alla
DC e i l voto ai fascisti; non tanto perchè intendiamo rispolverare la teoria
del socialfascismo (in altre vesti) quanto perchè il diverso tipo di risposte alla
spinta operaia produce soltanto una diversa valutazione sui mezzi da im-
piegare contro la classe operaia e le masse oppresse. C'è chi ritiene che la
risposta debba ormai superare ogni mediazione consensuale e interclassi-
37
















