
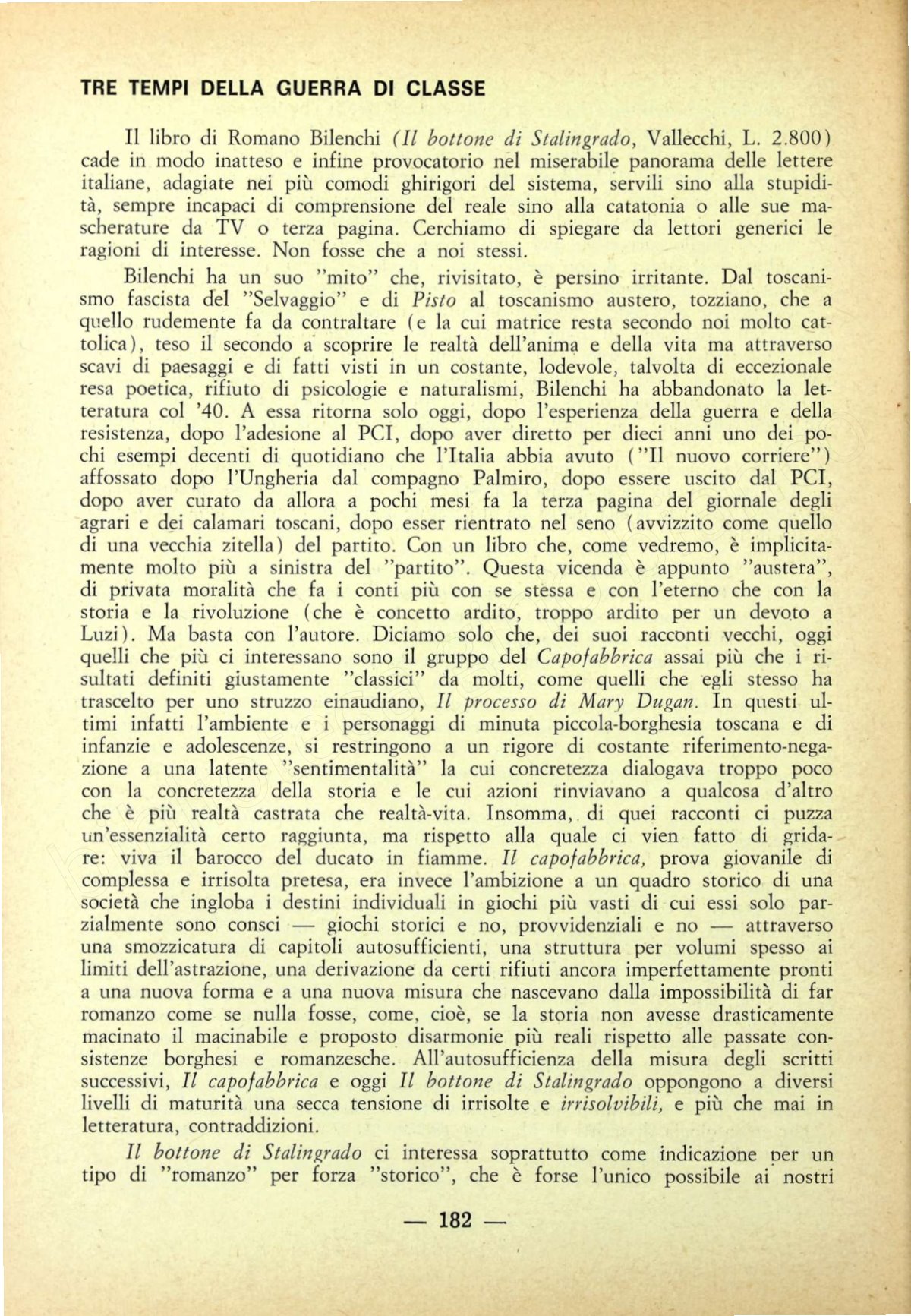
TRE TEMPI DELLA GUERRA DI CLASSE
I l libro di Romano Bilenchi
( I l bottone di Stalingrado,
Vallecchi, L. 2.800)
cade in modo inatteso e infine provocatorio nel miserabile panorama delle lettere
italiane, adagiate nei più comodi ghirigori del sistema, servili sino alla stupidi-
tà, sempre incapaci di comprensione del reale sino alla catatonia o alle sue ma-
scherature da TV o terza pagina. Cerchiamo di spiegare da lettori generici le
ragioni di interesse. Non fosse che a noi stessi.
Bilenchi ha un suo "mito" che, rivisitato, è persino irritante. Dal toscani-
smofascista del "Selvaggio" e di
Pisto
al toscanismo austero, tozziano, che a
quello rudemente fa da contraltare (e la cui matrice resta secondo noi molto cat-
tolica), teso i l secondo i scoprire le realtà dell'anima e della vita ma attraverso
scavi di paesaggi e di fatti visti in un costante, lodevole, talvolta di eccezionale
resapoetica, rifiuto di psicologie e naturalismi, Bilenchi ha abbandonato la let-
teratura col '40. A essa ritorna solo oggi, dopo l'esperienza della guerra e della
resistenza, dopo l'adesione al PCI, dopo aver diretto per dieci anni uno dei po-
chi esempi decenti di quotidiano che l'Italia abbia avuto ( "Il nuovo corriere")
affossato dopo l'Ungheria dal compagno Palmiro, dopo essere uscito dal PCI,
dopo aver curato
da
allora a pochi mesi fa la terza pagina del giornale degli
agrari e dei calamari toscani, dopo esser rientrato nel seno ( avvizzito come quello
di una vecchia zitella) del partito. Con un libro che, come vedremo, è implicita-
mentemolto più a sinistra del "partito". Questa vicenda è appunto "austera",
di privata moralità che fa i conti più con se stessa e con l'eterno che con la
storia e la rivoluzione (che è concetto ardito, troppo ardito per un devoto a
Luzi ). Ma basta con l'autore. Diciamo solo che, dei suoi racconti vecchi, oggi
quelli che più ci interessano sono i l gruppo del
Capofabbrica
assai più che i ri-
sultati definiti giustamente "classici" da molti, come quelli che egli stesso ha
trascelto per uno struzzo einaudiano,
I l processo di Mary Dugan.
I n questi ul-
timi infatti l'ambiente e i personaggi di minuta piccola-borghesia toscana e di
infanzie e adolescenze, si restringono a un rigore di costante riferimento-nega-
zione a una latente "sentimentalità" la cui concretezza dialogava troppo poco
con la concretezza della storia e le cui azioni rinviavano a qualcosa d'altro
che è più realtà castrata che realtà-vita. Insomma, d i quei racconti ci puzza
un'essenzialità certo raggiunta, ma rispetto alla quale ci vien fatto d i grida-
re: viva i l barocco del ducato in fiamme.
I l capofabbrica,
prova giovanile di
complessa e irrisolta pretesa, era invece l'ambizione a un quadro storico di una
società che ingloba i destini individuali in giochi più vasti di cui essi solo par-
zialmente sono consci — giochi storici e no, provvidenziali e no — attraverso
unasmozzicatura di capitoli autosufficienti, una struttura per volumi spesso ai
limiti dell'astrazione, una derivazione da certi rifiuti ancora imperfettamente pronti
auna nuova forma e a una nuova misura chenascevano dalla impossibilità di far
romanzocome se nulla fosse, come, cioè, se la storia non avessedrasticamente
macinato i l macinabile e proposto disarmonie più reali rispetto alle passate con-
sistenze borghesi e romanzesche. All'autosufficienza della misura degli scritti
successivi,
I l capofabbrica
e oggi I l
bottone di Stalingrado
oppongono a diversi
livelli di maturità una secca tensione di irrisolte e
irrisolvibili,
e più che mai in
letteratura, contraddizioni.
I l bottone di Stalin grado
ci interessa soprattutto come indicazione per un
tipo di "romanzo" per forza "storico", che è forse l'unico possibile ai nostri
— 182
















