
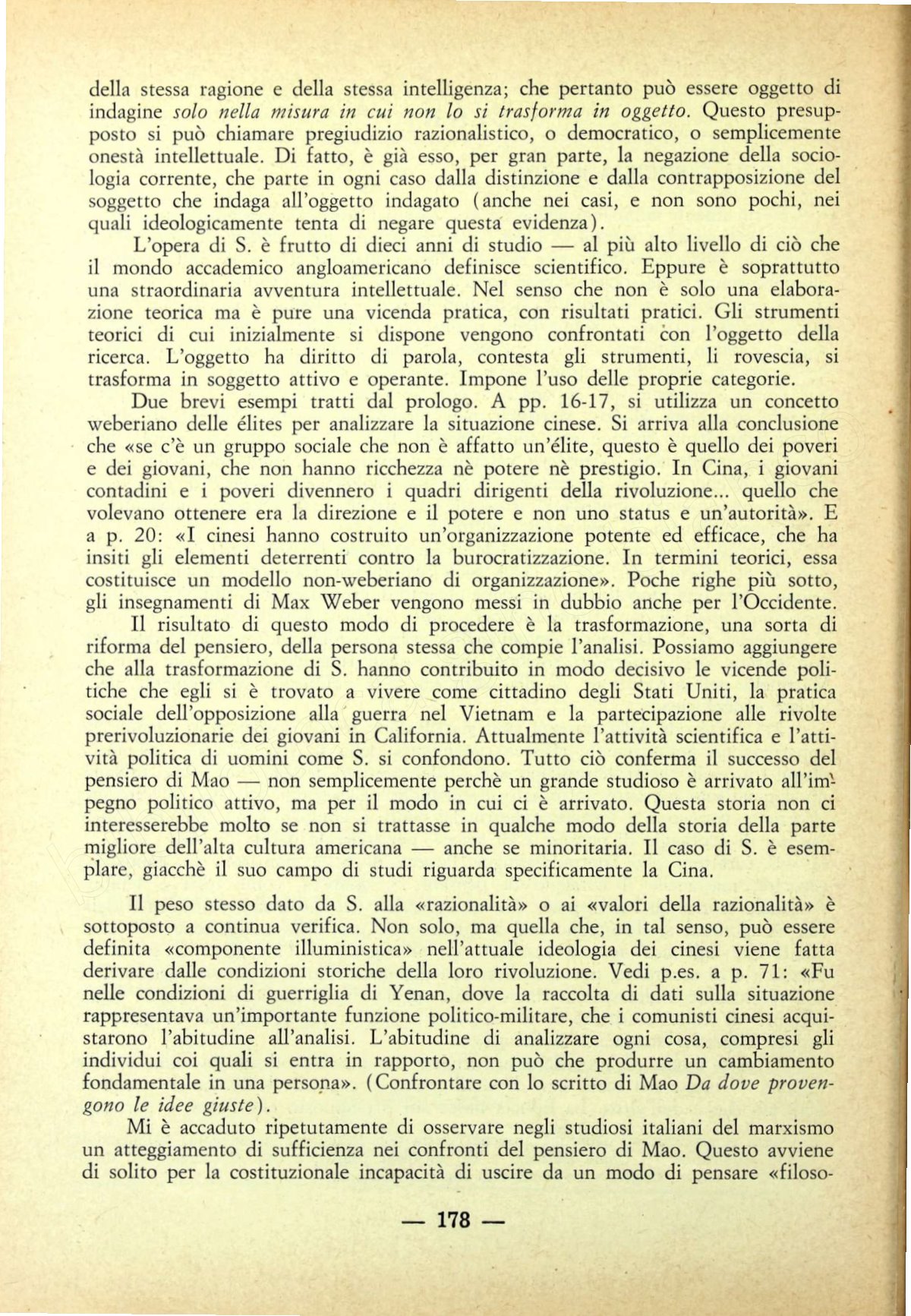
dellastessaragione e dellastessaintelligenza; chepertantopuòessereoggetto di
indaginesolonellamisura in cui non lo si trasforma in oggetto.Questopresup-
postosi puòchiamarepregiudiziorazionalistico, o democratico, o semplicemente
onestàintellettuale. Di fatto, è giàesso, per granparte, la negazionedellasocio-
logiacorrente, cheparte in ognicasodalladistinzione e dallacontrapposizionedel
soggettoche indagaall'oggetto indagato ( anchenei casi, e nonsonopochi, nei
quali ideologicamente tenta di negarequestaevidenza).
L'opera di S. è frutto di dieci anni di studio — al più alto livello di ciòche
il mondoaccademicoangloamericanodefiniscescientifico. Eppure è soprattutto
unastraordinariaavventura intellettuale. Nel sensoche non è solo una elabora-
zioneteoricama è pure unavicendapratica, con risultati pratici. Gli strumenti
teorici di cui inizialmente si disponevengonoconfrontati Con l'oggetto della
ricerca.L'oggetto ha diritto di parola, contesta gli strumenti, l i rovescia, si
trasforma in soggettoattivo e operante. Impone l'uso delle propriecategorie.
Duebrevi esempi tratti dal prologo. A pp. 16-17, si utilizza un concetto
weberianodelle élites per analizzare la situazionecinese. Si arriva allaconclusione
che«sec'è ungrupposocialechenon è affatto un'élite, questoè quellodei poveri
edei giovani, chenonhannoricchezzane potere ne prestigio. In Cina, i giovani
contadini e i poveri divennero i quadri dirigenti della rivoluzione.., quello che
volevanoottenere era la direzione e il potere e nonunostatus e un'autorità». E
ap. 20: « I cinesi hannocostruitoun'organizzazionepotente ed efficace, che ha
insiti gli elementi deterrenti contro la burocratizzazione. In termini teorici, essa
costituisceunmodellonon-weberiano di organizzazione».Poche righe più sotto,
gli insegnamenti di Max Weber vengonomessi in dubbioancheper l'Occidente.
Il risultato di questomodo di procedere è la trasformazione, una sorta di
riformadel pensiero, dellapersonastessachecompiel'analisi.Possiamoaggiungere
chealla trasformazione di S. hannocontribuito in mododecisivo le vicende poli-
ticheche egli si è trovato a vivere comecittadino degli Stati Uniti, la pratica
socialedell'opposizione alla )guerra nel Vietnam e la partecipazione alle rivolte
prerivoluzionariedei giovani in California.Attualmente l'attività scientificae l'atti-
vitàpolitica di uominicomeS. si confondono. Tutto ciòconferma il successodel
pensierodi Mao — nonsemplicementeperchèungrandestudiosoè arrivato
pegnopolitico attivo, ma per il modo in cui ci è arrivato. Questa storia non ci
interesserebbemolto se non si trattasse in qualchemododella storia della parte
miglioredell'alta culturaamericana — ancheseminoritaria. I l caso di S. è esem-
plare,giacchè il suocampo di studi riguardaspecificamente la Cina.
Il pesostessodato da S. alla «razionalità» o ai «valori della razionalità» è
sottoposto a continuaverifica. Non solo, ma quella che, in tal senso, puòessere
definita«componente illuministica» nell'attuale ideologia dei cinesi viene fatta
derivaredalle condizioni storichedella loro rivoluzione. Vedi
p.es.a p. 71: «Fu
nellecondizioni di guerriglia di Yenan, dove la raccolta di dati sulla situazione
rappresentavaun'importantefunzionepolitico-militare,che i comunisticinesiacqui-
staronol'abitudine all'analisi. L'abitudine di analizzare ogni cosa, compresi gli
individui coi quali si entra in rapporto, non può cheprodurre un cambiamento
fondamentale inunapersopa». (Confrontarecon lo scritto di Mao
Dadoveproven-
gonole ideegiuste).
Mi è accadutoripetutamente di osservarenegli studiosi italiani delmarxismo
unatteggiamento di sufficienzanei confronti del pensiero di Mao. Questoavviene
di solito per la costituzionaleincapacità di uscireda unmodo di pensare«filoso-
178 —
















