
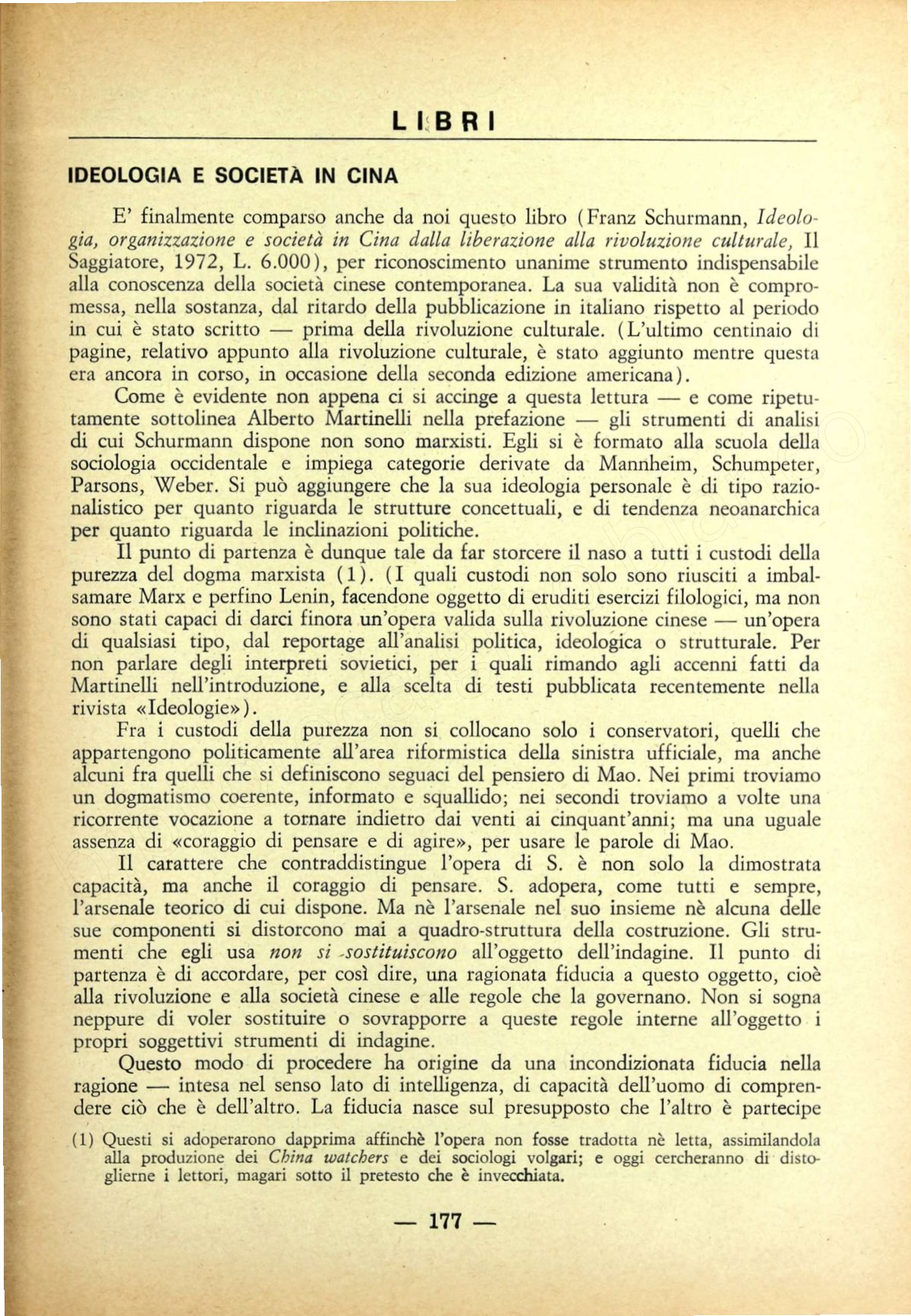
ssiS
L I B R I
IDEOLOGIA E SOCIETÀ IN CINA
E' finalmente comparsoanche da noi questo libro (Franz Schurmann,
Ideolo-
gia, organizzazione e società in Cina dalla liberazione alla rivoluzione culturale, I l
Saggiatore, 1972, L. 6.000), per riconoscimento unanime strumento indispensabile
allaconoscenza della società cinesecontemporanea. La sua validità non è compro-
messa,nella sostanza, dal ritardo della pubblicazione in italiano rispetto al periodo
in cui è stato scritto — prima della rivoluzione culturale. (L'ultimo centinaio di
pagine, relativo appunto alla rivoluzione culturale, è stato aggiunto mentre questa
eraancora in corso, in occasione della secondaedizione americana).
Come è evidente non appena ci si accinge a questa lettura — e come ripetu-
tamente sottolinea Alberto Martinelli nella prefazione — gli strumenti di analisi
di cui Schurmann dispone non sono marxisti. Egli si è formato alla scuola della
sociologia occidentale e impiega categorie derivate da Mannheim, Schumpeter,
Parsons,Weber. Si può aggiungere che la sua ideologia personale è di tipo razio-
nalistico per quanto riguarda le strutture concettuali, e di tendenzaneoanarchica
per quanto riguarda le inclinazioni politiche.
Il punto di partenza è dunque tale da far storcere il nasoa tutti i custodi della
purezza del dogmamarxista (1). ( I quali custodi non solo sono riusciti a imbal-
samareMarx e perfino Lenin, facendoneoggetto di eruditi esercizi filologici, manon
sonostati capaci di darci finora un'opera valida sulla rivoluzione cinese— un'opera
di qualsiasi tipo, dal reportage all'analisi politica, ideologica o strutturale. Per
non parlare degli interpreti sovietici, per i quali rimando agli accenni fatti da
Martinelli nell'introduzione, e alla scelta di testi pubblicata recentemente nella
rivista «Ideologie»).
Fra i custodi della purezza non si collocano solo i conservatori, quelli che
appartengono politicamente all'area riformistica della sinistra ufficiale, ma anche
alcuni fra quelli che si definisconoseguaci del pensiero di Mao. Nei primi troviamo
undogmatismo coerente, informato e squallido; nei secondi troviamo a volte una
ricorrente vocazione a tornare indietro dai venti ai cinquant'anni; ma una uguale
assenza di «coraggio di pensare e di agire», per usare le parole di Mao.
Il carattere che contraddistingue l'opera d i S. è non solo la dimostrata
capacità, ma anche i l coraggio d i pensare. S. adopera, come tutt i e sempre,
l'arsenale teorico di cui dispone. Ma nè l'arsenale nel suo insieme nè alcuna delle
suecomponenti si distorcono mai a quadro-struttura della costruzione. Gl i stru-
menti che egli usa
non si -sostituiscono
all'oggetto dell'indagine. I l punto d i
partenza è di accordare, per così dire, una ragionata fiducia a questo oggetto, cioè
alla rivoluzione e alla società cinese e alle regole che la governano. Non si sogna
neppure di voler sostituire o sovrapporre a queste regole interne all'oggetto i
propri soggettivi strumenti di indagine.
Questomodo di procedere ha origine da una incondizionata fiducia nella
ragione — intesa nel senso lato di intelligenza, di capacità dell'uomo di compren-
dere ciò che è dell'altro. La fiducia nasce sul presupposto che l'altro è partecipe
(1) Questi si adoperarono dapprima affinchè l'opera non fosse tradotta nè letta, assimilandola
alla produzione dei
China watchers
e dei sociologi volgari; e oggi cercheranno d i disto-
glierne i lettori, magari sotto i l pretesto che è invecchiata.
177
















