
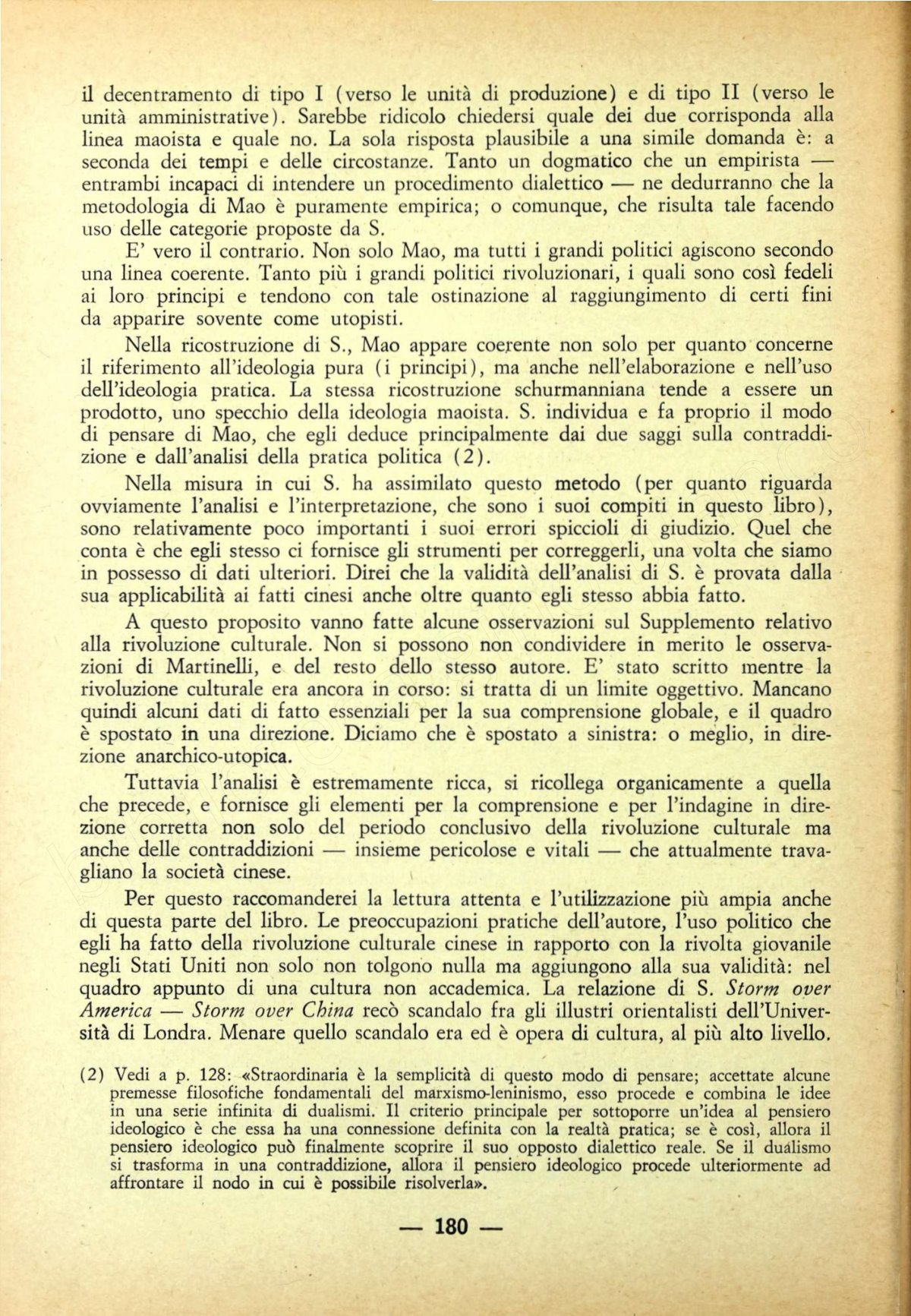
il
decentramento di tipo I ( verso le unità di produzione) e di tipo
I I
(verso le
unità amministrative). Sarebbe ridicolo chiedersi quale dei due corrisponda alla
lineamaoista e quale no. La sola risposta plausibile a una simile domanda è: a
seconda dei tempi e delle circostanze Tanto un dogmatico che un empirista
entrambi incapaci di intendere un procedimento dialettico — ne dedurranno che la
metodologia di Mao è puramente empirica; o comunque, che risulta tale facendo
usodelle categorie proposte da S.
E' vero il contrario. Non soloMao, ma tutti i grandi politici agisconosecondo
una linea coerente. Tanto più i grandi politici rivoluzionari, i quali sono così fedeli
ai loro principi e tendono con tale ostinazione al raggiungimento di certi fini
daapparire sovente come utopisti.
Nella ricostruzione di S., Mao appare coerente non solo per quanto concerne
il riferimento all'ideologia pura ( i principi), ma anche nell'elaborazione e nell'uso
dell'ideologia pratica. La stessa ricostruzione schurmanniana tende a essere
un
prodotto, uno specchio della ideologiamaoista. S. individua e fa proprio i l modo
di pensare di Mao, che egli deduce principalmente dai due saggi sulla contraddi-
zione e dall'analisi della pratica politica ( 2).
Nella misura in cui S. ha assimilato questo
metodo
(per quanto riguarda
ovviamente l'analisi e l'interpretazione, che sono i suoi compiti in questo libro),
sono relativamente poco importanti i suoi errori spiccioli di giudizio. Quel che
conta è che egli stesso ci fornisce gli strumenti per correggerli, una volta che siamo
inpossesso di dati ulteriori. Direi che la validità dell'analisi di S. è provata dalla
suaapplicabilità ai fatti cinesi anche oltre quanto egli stesso abbia fatto.
Aquesto proposito vanno fatte alcune osservazioni sul Supplemento relativo
alla rivoluzione culturale. Non si possono non condividere
in
merito le osserva-
zioni di Martinelli, e del resto dello stesso autore. E' stato scritto mentre la
rivoluzione culturale era ancora in corso: si tratta di un limite oggettivo. Mancano
quindi alcuni dati di fatto essenziali per la sua comprensione globale, e i l quadro
èspostato
in
una direzione. Diciamo che è spostato a sinistra: o meglio, in dire-
zioneanarchico-utopica.
Tuttavia l'analisi è estremamente ricca, si ricollega organicamente a quella
cheprecede, e fornisce gli elementi per la comprensione e per l'indagine in dire-
zione corretta non solo del periodo conclusivo della rivoluzione culturale ma
anchedelle contraddizioni — insieme pericolose e vitali — che attualmente trava-
gliano la società cinese.
Per questo raccomanderei la lettura attenta e l'utilizzazione più ampia anche
di questa parte del libro. Le preoccupazioni pratiche dell'autore, l'uso politico che
egli ha fatto della rivoluzione culturale cinese in rapporto con
la
rivolta giovanile
negli Stati Uniti non solo non tolgono nulla ma aggiungono alla sua validità: nel
quadro appunto di una cultura non accademica. La relazione di S.
Storm over
America
-
Storm over China
recò scandalo fra gli illustri orientalisti dell'Univer-
sità di Londra. Menare quello scandaloera ed è opera di cultura, al più
alto livello.
(2) Vedi a p. 128: «Straordinaria è la semplicità di questo modo di pensare; accettate alcune
premesse filosofiche fondamentali del marxismo-leninismo, esso procede e combina le idee
in una serie infinita d i dualismi. I l criterio principale per sottoporre un'idea al pensiero
ideologico è che essa ha una connessione definita con la realtà pratica; se è così, allora i l
pensiero ideologico può finalmente scoprire i l suo opposto dialettico reale. Se i l dualismo
si trasforma i n una contraddizione, allora i l pensiero ideologico procede ulteriormente ad
affrontare i l nodo in cui è possibile risolverla».
180
















