
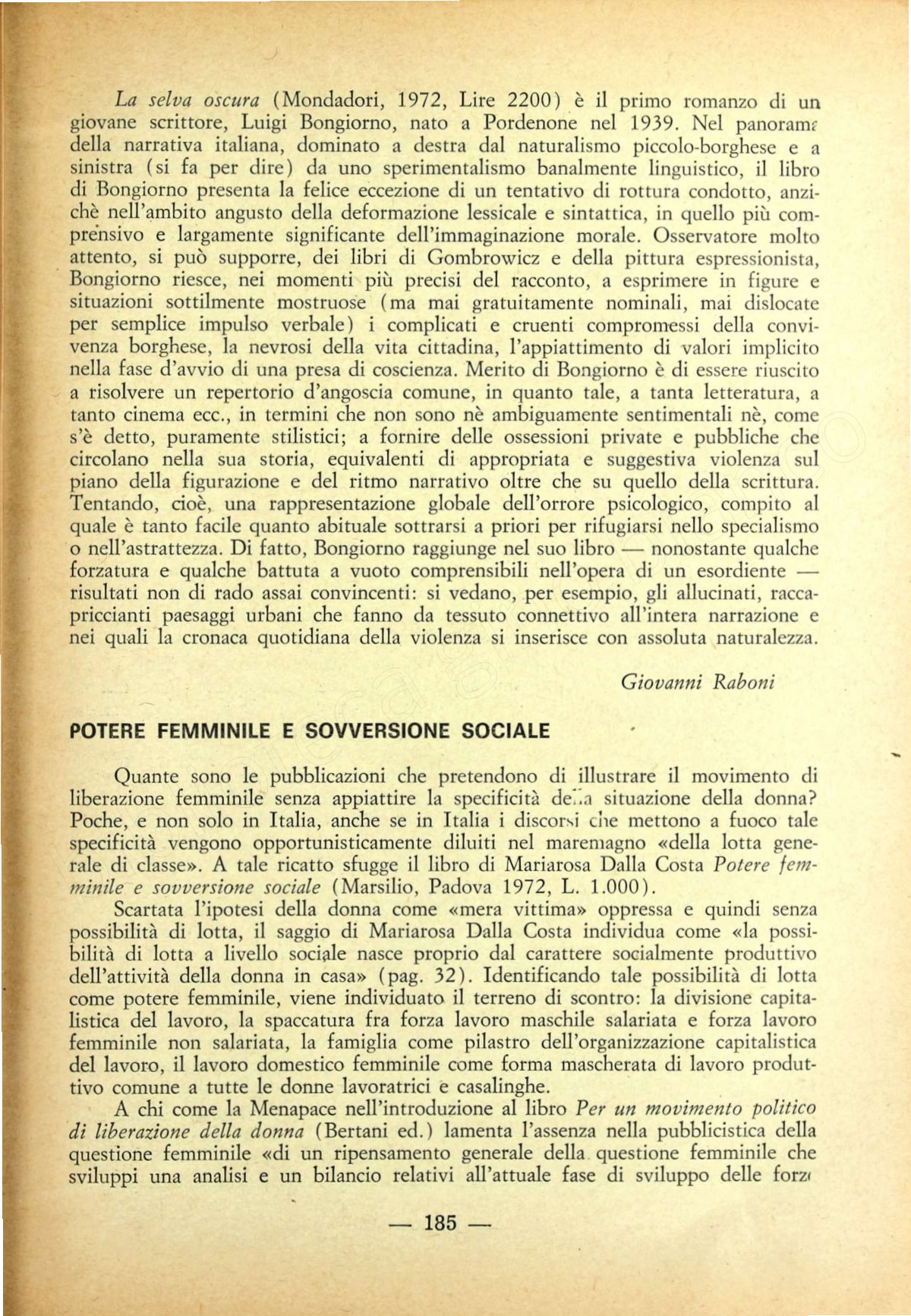
•
L a selva oscura
(Mondadori, 1972, Lire 2200) è i l primo romanzo di un
giovane scrittore, Luigi Bongiorno, nato a Pordenone nel 1939. Nel panoram2
della narrativa italiana, dominato a destra dal naturalismo piccolo-borghese e a
sinistra ( si fa per dire) da uno sperimentalismo banalmente linguistico, i l libro
di Bongiorno presenta la felice eccezione di un tentativo di rottura condotto, anzi-
chènell'ambito angusto della deformazione lessicale e sintattica, in quello più com-
prensivo e largamente significante dell'immaginazione morale. Osservatore molto
attento, si può supporre, dei libri di Gombrowicz e della pittura espressionista,
Bongiorno riesce, nei momenti più precisi del racconto, a esprimere in figure e
situazioni sottilmente mostruose ( mamai gratuitamente nominali, mai dislocate
per semplice impulso verbale) i complicati e cruenti compromessi della convi-
venzaborghese, la nevrosi della vita cittadina, l'appiattimento di valori implicito
nella fase d'avvio di unapresa di coscienza. Merito di Bongiorno è di essere riuscito
_•a risolvere un repertorio d'angoscia comune, in quanto tale, a tanta letteratura, a
tanto cinemaecc., in termini che non sono ne ambiguamente sentimentali ne, come
s'è detto, puramente stilistici, a fornire delle ossessioni private e pubbliche che
circolano nella sua storia, equivalenti di appropriata e suggestiva violenza sul
piano della figurazione e del ritmo narrativo oltre che su quello della scrittura.
Tentando, cioè, una rappresentazione globale dell'orrore psicologico, compito al
quale è tanto facile quanto abituale sottrarsi a priori per rifugiarsi nello specialismo
onell'astrattezza. Di fatto, Bongiorno raggiunge nel suo libro — nonostantequalche
forzatura e qualche battuta a vuoto comprensibili nell'opera di un esordiente
risultati non di rado assai convincenti: si vedano, per esempio, gli allucinati, racca-
priccianti paesaggi urbani che fanno da tessuto connettivo all'intera narrazione e
nei quali la cronaca quotidiana della violenza si inserisce con assolutanaturalezza.
POTEREFEMMINILE E SOVVERSIONESOCIALE
Giovanni Raboni
•
•Quante sono le pubblicazioni che pretendono di illustrare i l movimento di
liberazione femminile senza appiattire la specificità dea situazione della donna?
Poche, e non solo in Italia, anche se in Italia i discorsi che mettono a fuoco tale
specificità vengono opportunisticamente diluiti nel maremagno «della lotta gene-
rale di classe». A tale ricatto sfugge i l libro di Mariarosa Dalla Costa
Potere fem-
minile
e
sovversione sociale
(Marsilio, Padova 1972, L. 1.000).
Scartata l'ipotesi della donna come «mera vittima» oppressa e quindi senza
possibilità di lotta, i l saggio di Mariarosa Dalla Costa individua come «la possi-
bilità di lotta a livello socialenasce proprio dal carattere socialmente produttivo
dell'attività della donna in casa» (pag. 32). Identificando tale possibilità di lotta
comepotere femminile, viene individuato il terreno di scontro: la divisione capita-
listica del lavoro, la spaccatura fra forza lavoro maschile salariata e forza lavoro
femminile non salariata, la famiglia come pilastro dell'organizzazione capitalistica
del lavoro, i l lavoro domestico femminile come formamascherata di lavoro produt-
tivo comune a tutte le donne lavoratrici e casalinghe.
A chi come laMenapace nell'introduzione al libro
Per un movimento politico
di liberazione della donna
(Bertani ed.) lamenta l'assenza nella pubblicistica della
questione femminile «di un ripensamento generale della. questione femminile che
sviluppi una analisi e un bilancio relativi all'attuale fase di sviluppo delle forzi
185
















