
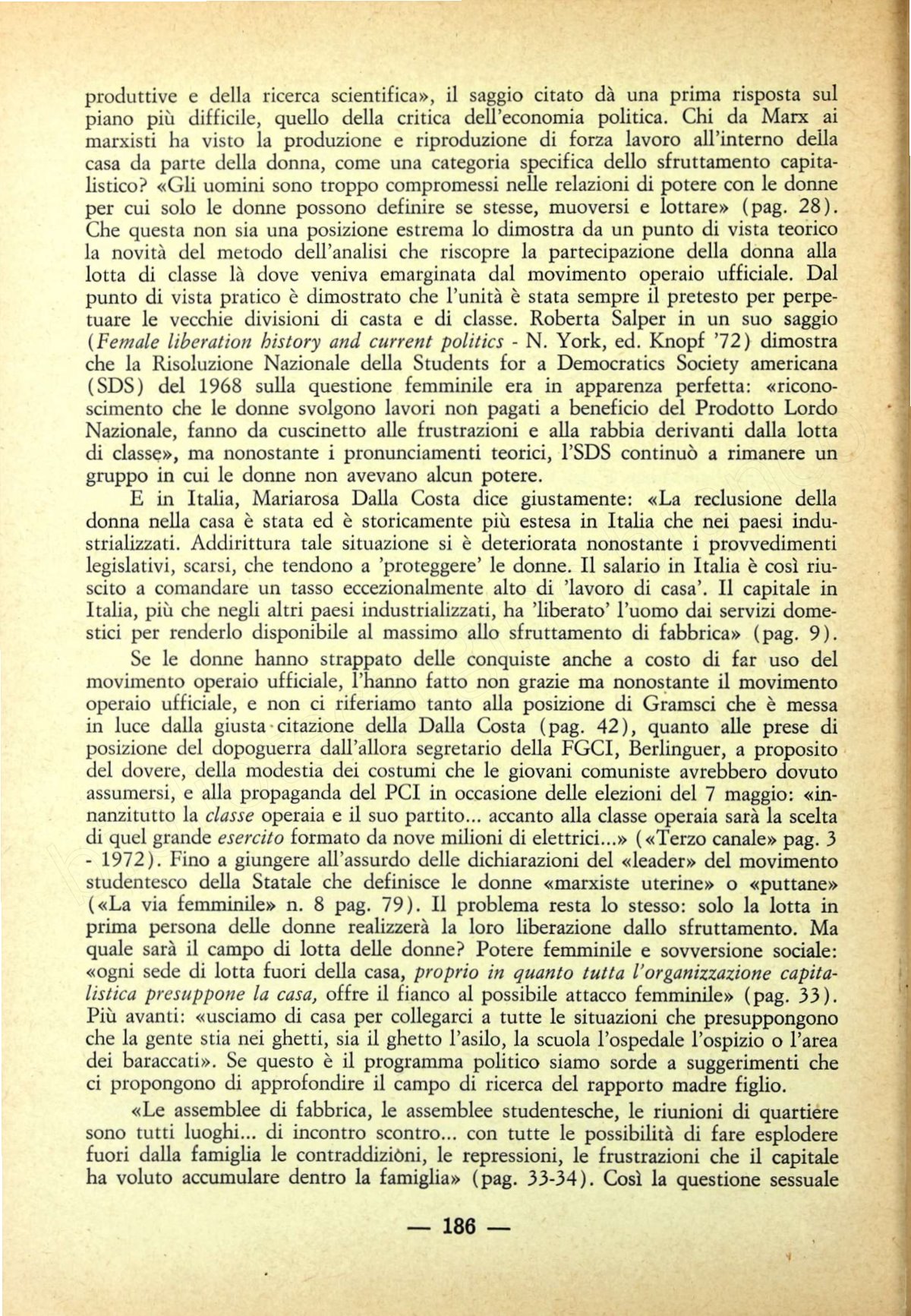
produttive e della ricerca scientifica», i l saggio citato dà una prima risposta sul
piano più difficile, quello della critica dell'economia politica. Chi da Marx ai
marxisti ha visto la produzione e riproduzione di forza lavoro all'interno della
casada parte della donna, come una categoria specifica dello sfruttamento capita-
listico? «Gli uomini sono troppo compromessi nelle relazioni di potere con le donne
per cui solo le donne possono definire se stesse, muoversi e lottare» (pag. 28).
Chequesta non sia una posizioneestrema lo dimostra da un punto di vista teorico
la novità del metodo dell'analisi che riscopre la partecipazione della donna alla
lotta di classe là dove veniva emarginata dal movimento operaio ufficiale. Dal
punto di vista pratico è dimostrato che l'unità è stata sempre il pretesto per perpe-
tuare le vecchie divisioni di casta e di classe. Roberta Salper in un suo saggio
(Female liberation history and current politics - N. York, ed. ICnopf '72) dimostra
che la Risoluzione Nazionale della Students for a Democratics Society americana
(SDS) del 1968 sulla questione femminile era in apparenza perfetta: «ricono-
scimentoche le donne svolgono lavori non pagati a beneficio del Prodotto Lordo
Nazionale, fanno da cuscinetto alle frustrazioni e alla rabbia derivanti dalla lotta
di classe», ma nonostante i pronunciamenti teorici, l'SDS continuò a rimanere un
gruppo in cui le donne non avevano alcun potere.
E in Italia, Mariarosa Dalla Costa dice giustamente: «La reclusione della
donna nella casa è stata ed è storicamente più estesa in Italia che nei paesi indu-
strializzati. Addirittura tale situazione si è deteriorata nonostante i provvedimenti
legislativi, scarsi, che tendono a 'proteggere' le donne. I l salario in Italia è così riu-
scito a comandare un tassoeccezionalmente alto di 'lavoro di casa'. I l capitale in
Italia, più che negli altri paesi industrializzati, ha 'liberato' l'uomo dai servizi dome-
stici per renderlo disponibile al massimo allo sfruttamento di fabbrica» (pag. 9).
Se le donne hanno strappato delle conquiste anche a costo di far uso del
movimento operaio ufficiale, l'hanno fatto non graziema nonostante i l movimento
operaio ufficiale, e non ci riferiamo tanto alla posizione di Gramsci che è messa
in luce dalla giusta citazione della Dalla Costa (pag. 42), quanto alle prese di
posizione del dopoguerra dall'allora segretario della FGCI, Berlinguer, a proposito
del dovere, della modestia dei costumi che le giovani comuniste avrebbero dovuto
assumersi, e alla propaganda del PCI in occasione delle elezioni del 7 maggio: «in-
nanzitutto la
classe
operaia e il suo partito... accanto alla classeoperaiasarà la scelta
di quel grande
esercito
formato danove milioni di elettrici...» («Terzo canale»pag. 3
- 1972). Fino a giungere all'assurdo delle dichiarazioni del «leader» del movimento
studentesco della Statale che definisce le donne «marxiste uterine» o «puttane»
(«La via femminile» n. 8 pag. 79). I l problema resta lo stesso: solo la lotta in
prima persona delle donne realizzerà la loro liberazione dallo sfruttamento. Ma
qualesarà i l campo di lotta delle donne? Potere femminile e sovversione sociale:
«ogni sede di lotta fuori della casa, proprio in quanto tutta l'organizzazione capita-
listica presuppone la casa,
offre il fianco al possibile attacco femminile» (pag. 33).
Più avanti: «usciamo di casa per collegarci a tutte le situazioni chepresuppongono
che la gente stia nei ghetti, sia il ghetto l'asilo, la scuola l'ospedale l'ospizio o l'area
dei baraccati». Se questo è i l programma politico siamo sorde a suggerimenti che
ci propongono di approfondire i l campo di ricerca del rapporto madre figlio.
«Leassemblee di fabbrica, le assembleestudentesche, le riunioni di quartiere
sono tutti luoghi .. di incontro scontro... con tutte le possibilità di fare esplodere
fuori dalla famiglia le contraddiziòni, le repressioni, le frustrazioni che i l capitale
ha voluto accumulare dentro la famiglia» (pag. 33-34). Così la questionesessuale
186
















