
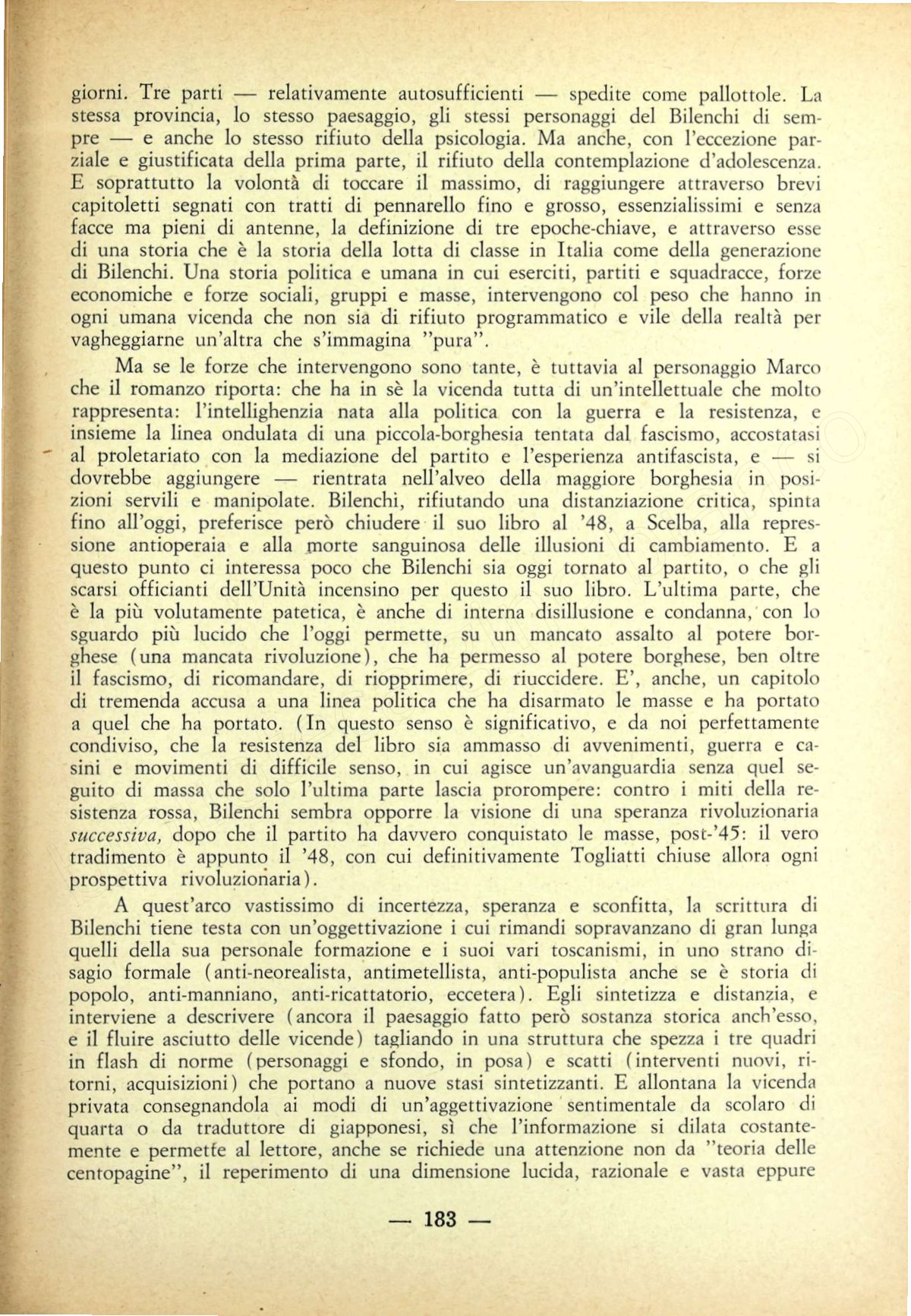
giorni. Tre parti relativamente autosufficienti s ped i t e come pallottole. La
stessaprovincia, lo stesso paesaggio, gl i stessi personaggi del Bilenchi di sem-
pre — e anche lo stesso rifiuto della psicologia. Ma anche, con l'eccezione par-
ziale e giustificata della prima parte, i l rifiuto della contemplazioned'adolescenza.
E soprattutto la volontà di toccare i l massimo, di raggiungere attraverso brevi
capitoletti segnati con tratti di pennarello fino e grosso, essenzialissimi e senza
faccema pieni di antenne, la definizione di tre epoche-chiave, e attraverso esse
di una storia che è la storia della lotta di classe in Italia come della generazione
di Bilenchi. Una storia politica e umana in cui eserciti, partiti e squadracce, forze
economiche e forze sociali, gruppi e masse, intervengono col peso che hanno in
ogni umana vicenda che non sia •di rifiuto programmatico e vile della realtà per
vagheggiarne un'altra che s'immagina "pura".
Mase le forze che intervengono sono tante, è tuttavia al personaggioMarco
che i l romanzo riporta: che ha in sè la vicenda tutta di un'intellettuale che molto
rappresenta: l'intellighenzia nata alla politica con la guerra e la resistenza, e
insieme la linea ondulata di una piccola-borghesia tentata dal fascismo, accostatasi
al proletariato con la mediazione del partito e l'esperienza antifascista, e — si
dovrebbeaggiungere — rientrata nell'alveo della maggiore borghesia i n posi-
zioni servili e manipolate. Bilenchi, rifiutando una distanziazione critica, spinta
fino all'oggi, preferisce però chiudere• il suo libro al '48, a Scelba, alla repres-
sioneantioperaia e alla morte sanguinosa delle illusioni d i cambiamento. E a
questo punto ci interessa poco che Bilenchi sia oggi tornato al partito, o che gli
scarsi officianti dell'Unità incensino per questo i l suo libro. L'ultima parte, che
è la più volutamente patetica, è anche di interna disillusione e condanna,' con lo
sguardo più lucido che l'oggi permette, su un mancato assalto al potere bor-
ghese (una mancata rivoluzione), che ha permesso al potere borghese, ben oltre
il fascismo, di ricomandare, di riopprimere, di riuccidere. E', anche, un capitolo
di tremendaaccusa a una linea politica che ha disarmato le masse e ha portato
aquel che ha portato. ( In questo senso è significativo, e da noi perfettamente
condiviso, che la resistenza del libro sia ammasso di avvenimenti, guerra e ca-
sini e movimenti di difficile senso, in cui agisce un'avanguardia senza quel se-
guito di massa che solo l'ultima parte lascia prorompere: contro i miti della re-
sistenza rossa, Bilenchi sembra opporre la visione di una speranza rivoluzionaria
successiva,
dopo che i l partito ha davvero conquistato le masse, post-'45: i l vero
tradimento è appunto i l '48, con cui definitivamente Togliatti chiuse allora ogni
prospettiva rivoluzionaria).
Aquest'arco vastissimo di incertezza, speranza e sconfitta, la scrittura di
Bilenchi tiene testa con un'oggettivazione i cui rimandi sopravanzano di gran lunga
quelli della sua personale formazione e i suoi vari toscanismi, in uno strano di-
sagio formale ( anti-neorealista, antimetellista, anti-populista anche se è storia di
popolo, anti-manniano, anti-ricattatorio, eccetera). Egli sintetizza e distanzia, e
interviene a descrivere ( ancora i l paesaggio fatto però sostanza storica anch'esso,
e il fluire asciutto delle vicende) tagliando in una struttura chespezza i tre quadri
in flash di norme (personaggi e sfondo, in posa) e scatti (interventi nuovi, ri-
torni, acquisizioni) che portano a nuove stasi sintetizzanti. E allontana la vicenda
privata consegnandola ai modi di un'aggettivazione sentimentale da scolaro di
quarta o da traduttore di giapponesi, sì che l'informazione si dilata costante-
mente e
permetfe
al lettore, anchese richiede una attenzione non da "teoria delle
centopagine", i l reperimento di una dimensione lucida, razionale e vasta eppure
— 183
















