
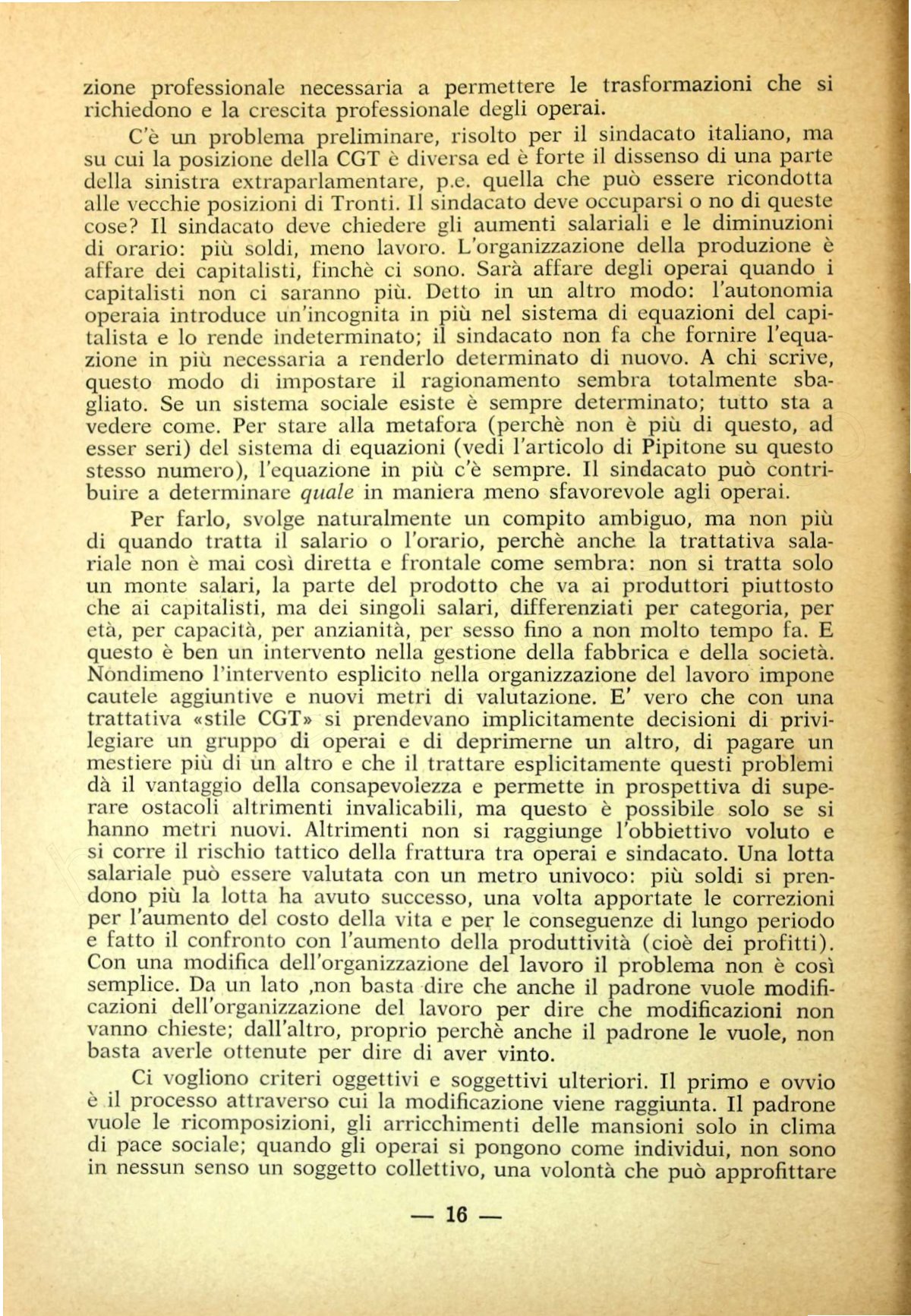
zione professionale necessaria a permettere le trasformazioni che si
richiedono e la crescita professionale degli operai.
C'è un problema preliminare, risolto per il sindacato italiano, ma
sucui la posizione della CGT è diversa ed è forte il dissenso di una parte
della sinistra extraparlamentare, p.e. quella che può essere ricondotta
alle vecchieposizioni di Tronti. Il sindacatodeveoccuparsi o no di queste
cose? I l sindacato deve chiedere gli aumenti salariali e le diminuzioni
di orario: più soldi, meno lavoro. L'organizzazione della produzione è
affare dei capitalisti, finchè ci sono. Sarà affare degli operai quando i
capitalisti non ci saranno più. Detto in un altro modo: l'autonomia
operaia introduce un'incognita in più nel sistema di equazioni del capi-
talista e lo rende indeterminato; i l sindacato non fa che fornire l'equa-
zione in più necessaria a renderlo determinato di nuovo. A chi scrive,
questomodo di impostare i l ragionamento sembra totalmente sba-
gliato. Se un sistema sociale esiste è sempre determinato; tutto sta a
vedere come. Per stare alla metafora (perchè non è più di questo, ad
esser seri) del sistema di equazioni (vedi l'articolo di Pipitone su questo
stessonumero), l'equazione in più c'è sempre. I l sindacato può contri-
buire a determinare
quale
in maniera meno sfavorevole agli operai.
Per farlo, svolge naturalmente un compito ambiguo, ma non più
di quando tratta i l salario o l'orario, perchè anche la trattativa sala-
riale non è mai così diretta e frontale come sembra: non si tratta solo
unmonte salari, la parte del prodotto che va ai produttori piuttosto
che ai capitalisti, ma dei singoli salari, differenziati per categoria, per
età, per capacità, per anzianità, per sesso fino a non molto tempo fa. E
questo è ben un intervento nella gestione della fabbrica e della società.
Nondimeno l'intervento esplicito nella organizzazione del lavoro impone
cautele aggiuntive e nuovi metri di valutazione. E' vero che con una
trattativa «stile CGT» si prendevano implicitamente decisioni di privi-
legiare un gruppo di operai e di deprimerne un altro, di pagare un
mestiere più di un altro e che il trattare esplicitamente questi problemi
dà il vantaggio della consapevolezza e permette in prospettiva di supe-
rare ostacoli altrimenti invalicabili, ma questo è possibile solo se si
hanno metri nuovi. Altrimenti non si raggiunge l'obbiettivo voluto e
si corre il rischio tattico della frattura tra operai e sindacato. Una lotta
salariale può essere valutata con un metro univoco: più soldi si pren-
dono più la lotta ha avuto successo, una volta apportate le correzioni
per l'aumento del costo della vita e per le conseguenze di lungo periodo
e fatto il confronto con l'aumento della produttività (cioè dei profitti).
Conuna modifica dell'organizzazione del lavoro il problema non è così
semplice. Da un lato ,non basta -dire che anche il padrone vuole modifi-
cazioni dell'organizzazione del lavoro per dire che modificazioni non
vannochieste; dall'altro, proprio perchè anche il padrone le vuole, non
basta averle ottenute per dire di aver vinto.
Ci vogliono criteri oggettivi e soggettivi ulteriori. I l primo e ovvio
è il processo attraverso cui la modificazione viene raggiunta. I l padrone
vuole le ricomposizioni, gli arricchimenti delle mansioni solo in clima
di pace sociale; quando gli operai si pongono come individui, non sono
innessunsenso un soggetto collettivo, una volontà che può approfittare
16
















