
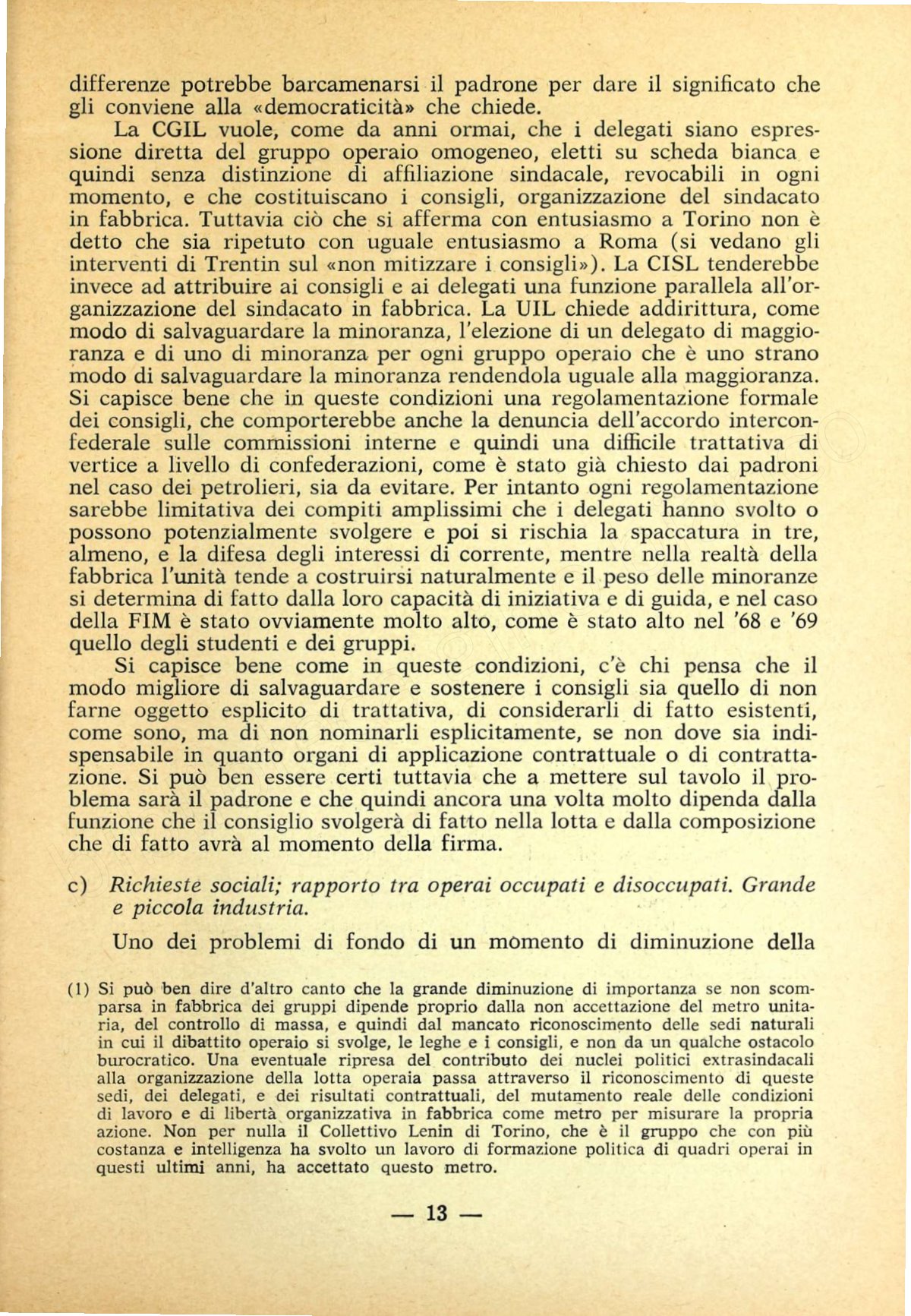
differenze potrebbe barcamenarsi i l padrone per dare i l significato che
gli conviene alla «democraticità» che chiede.
La
CGIL
vuole, come da anni ormai, che i delegati siano espres-
sione diretta del gruppo operaio omogeneo, eletti su scheda bianca e
quindi senza distinzione d i affiliazione sindacale, revocabili i n ogni
momento, e che costituiscano i consigli, organizzazione del sindacato
in fabbrica. Tuttavia ciò che si afferma con entusiasmo a Torino non è
detto che sia ripetuto con uguale entusiasmo a Roma (si vedano gl i
interventi di Trentin sul ((non mitizzare i consigli»). La CISL tenderebbe
invece ad attribuire ai consigli e ai delegati una funzione parallela all'or-
ganizzazione del sindacato in fabbrica. La UIL chiede addirittura, come
modo di salvaguardare la minoranza, l'elezione di un delegato di maggio-
ranza e di uno di minoranza per ogni gruppo operaio che è uno strano
modo di salvaguardare la minoranza rendendola uguale alla maggioranza.
Si capisce bene che in queste condizioni una regolamentazione formale
dei consigli, che comporterebbe anche la denuncia dell'accordo intercon-
federale sulle commissioni interne e quindi una difficile trattativa d i
vertice a livello di confederazioni, come è stato già chiesto dai padroni
nel caso dei petrolieri, sia da evitare. Per intanto ogni regolamentazione
sarebbe limitativa dei compiti amplissimi che i delegati hanno svolto o
possono potenzialmente svolgere e poi si rischia la spaccatura i n tre,
almeno, e la difesa degli interessi di corrente, mentre nella realtà della
fabbrica l'unità tende a costruirsi naturalmente e i l peso delle minoranze
si determina di fatto dalla loro capacità di iniziativa e di guida, e nel caso
della FIM è stato ovviamente molto alto, come è stato alto nel '68 e '69
quello degli studenti e dei gruppi.
Si capisce bene come i n queste condizioni, c'è chi pensa che i l
modo migliore di salvaguardare e sostenere i consigli sia quello di non
farne oggetto esplicito d i trattativa, d i considerarli d i fat to esistenti,
come sono, ma di non nominarli esplicitamente, se non dove sia indi-
spensabile in quanto organi di applicazione contrattuale o di contratta-
zione. Si puo ben essere certi tuttavia che a mettere sul tavolo i l pro-
blema sarà i l padrone e che quindi ancora una volta molto dipenda dalla
funzione che i l consiglio svolgerà di fatto nella lotta e dalla composizione
che di fatto avrà al momento della firma.
c) Richieste sociali; rapporto tra operai occupati e disoccupati. Grande
epiccola industria.
Uno dei problemi d i fondo d i un momento d i diminuzione
della
(1) Si può ben di re d'al t ro canto che la grande diminuzione d i importanza se non scom-
parsa i n fabbrica dei gruppi dipende propr io dal la non accettazione del met ro uni ta-
ria, del control lo d i massa, e quindi da l mancato riconoscimento del le sedi natural i
in cui i l dibat t i to operaio si svolge, le leghe e i consigli, e non da un qualche ostacolo
burocratico. Una eventuale r ipresa de l cont r ibuto de i nuc lei po l i t i c i extrasindacal i
alla organizzazione del la l o t t a operaia passa attraverso i l riconoscimento d i queste
sedi, de i delegati, e •dei r i sul tat i contrat tual i , de l mutamento reale del le condizioni
di lavoro e d i l iber tà organizzativa i n fabbr ica come met ro per misurare l a propr ia
azione. No n p e r nu l l a i l Col let t ivo Lenin d i Tor i no , che è i l gruppo che con p i ù
costanza e intelligenza ha svolto un lavoro d i formazione pol i t ica d i quadr i operai i n
questi u l t imi anni , h a accettato questo met ro.
13
















