
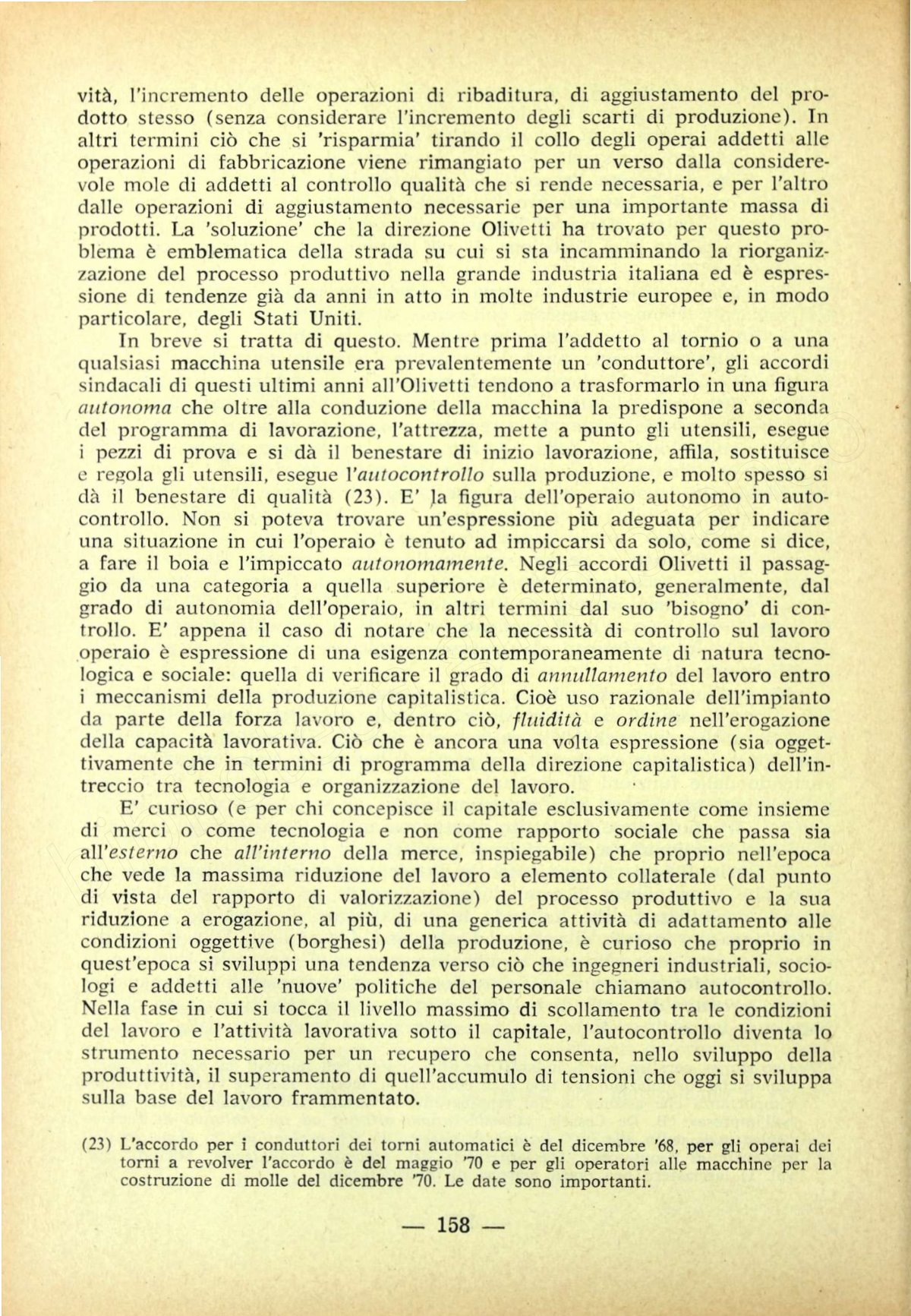
vità, l'incremento delle operazioni di ribaditura, di aggiustamento del pro-
dotto stesso (senza considerare l'incremento degli scarti di produzione). I n
altri termini ciò che si 'risparmia' tirando i l collo degli operai addetti alle
operazioni d i fabbricazione viene rimangiato per un verso dalla considere-
vole mole di addetti al controllo qualità che si rende necessaria, e per l'altro
dalle operazioni di aggiustamento necessarie per una importante massa d i
prodotti. La 'soluzione' che la direzione Olivetti ha trovato per questo pro-
blema è emblematica della strada su cui si sta incamminando la riorganiz-
zazione del processo produttivo nella grande industria italiana ed è espres-
sione di tendenze già da anni in atto in molte industrie europee e, in modo
particolare, degli Stati Uniti.
In breve si tratta di questo. Mentre prima l'addetto al tornio o a una
qualsiasi macchina utensile era prevalentemente un 'conduttore', gli accordi
sindacali di questi ultimi anni all'Olivetti tendono a trasformarlo in una figura
autonoma
che oltre alla conduzione della macchina la predispone a seconda
del programma di lavorazione, l'attrezza, mette a punto gli utensili, esegue
i pezzi di prova e si dà i l benestare di inizio lavorazione, affila, sostituisce
eregola gli utensili, esegue
l'autocontrollo
sulla produzione, e molto spesso si
dà i l benestare di qualità (23). E' ja figura dell'operaio autonomo in auto-
controllo. Non si poteva trovare un'espressione più adeguata per indicare
una situazione in cui l'operaio è tenuto ad impiccarsi da solo, come si dice,
a fare il boia e l'impiccato
autonomamente.
Negli accordi Olivetti i l passag-
gio da una categoria a quella superiore è determinato, generalmente, dal
grado di autonomia dell'operaio, in altri termini dal suo 'bisogno' di con-
trollo. E ' appena i l caso di notare che la necessità di controllo sul lavoro
.operaio è espressione di una esigenza contemporaneamente di natura tecno-
logica e sociale: quella di verificare il grado di
annullamento
del lavoro entro
i meccanismi della produzione capitalistica. Cioè uso razionale dell'impianto
da parte della forza lavoro e, dentro dò,
fluidità
e
ordine
nell'erogazione
della capacità lavorativa. Ciò che è ancora una volta espressione (sia ogget-
tivamente che in termini di programma della direzione capitalistica) dell'in-
treccio tra tecnologia e organizzazione del lavoro.
E' curioso (e per chi concepisce il capitale esclusivamente come insieme
di merci o come tecnologia e non come rapporto sociale che passa sia
all'esterno
che
all'interno
della merce, inspiegabile) che proprio nell'epoca
che vede la massima riduzione del lavoro a elemento collaterale (dal punto
di vista del rapporto di valorizzazione) del processo produttivo e l a sua
riduzione a erogazione, al più, di una generica attività di adattamento alle
condizioni oggettive (borghesi) della produzione, è curioso che proprio in
quest'epoca si sviluppi una tendenza verso ciò che ingegneri industriali, socio-
logi e addetti alle 'nuove' politiche del personale chiamano autocontrollo.
Nella fase in cui si tocca il livello massimo di scollamento tra le condizioni
del lavoro e l'attività lavorativa sotto i l capitale, l'autocontrollo diventa lo
strumento necessario per un recupero che consenta, nello sviluppo della
produttività, il superamento di quell'accumulo di tensioni che oggi si sviluppa
sulla base del lavoro frammentato.
(23) L'accordo per i conduttori dei torni automatici è del dicembre '68, per gli operai dei
torni a revolver l'accordo è del maggio '70 e per gli operatori alle macchine per la
costruzione di molle del dicembre '70. Le date sono importanti.
- 158
















