
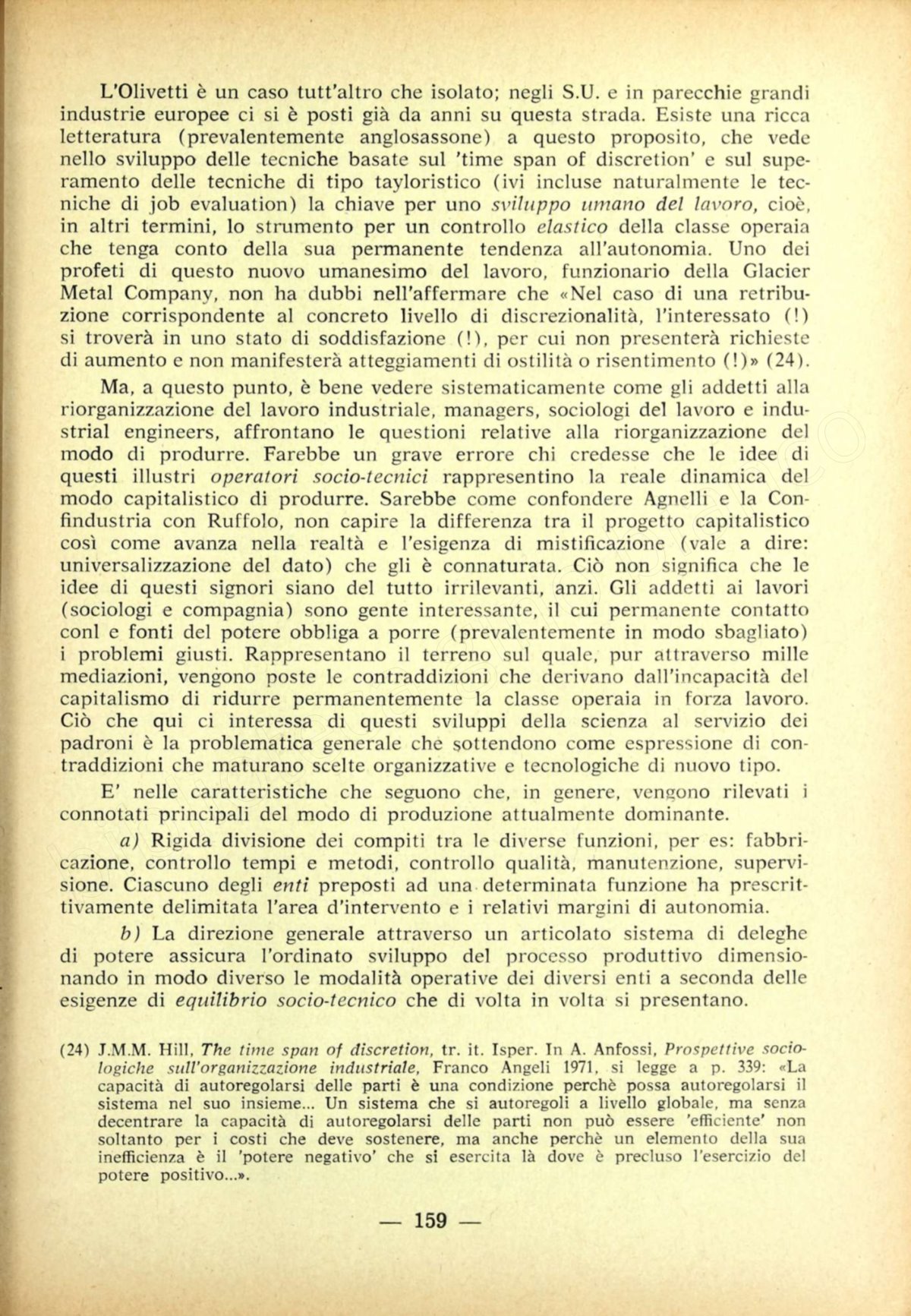
L'Olivetti è un caso tutt'altro che isolato; negli S.U. e in parecchie grandi
industrie europee ci si è posti già da anni su questa strada. Esiste una ricca
letteratura (prevalentemente anglosassone) a questo proposito, che vede
nello sviluppo delle tecniche basate sul 'time span of discretion' e sul supe-
ramento delle tecniche di tipo tayloristico ( ivi incluse naturalmente le tec-
niche di job evaluation) la chiave per uno
sviluppo umano del lavoro,
cioè,
in altri termini, lo strumento per un controllo
elastico
della classe operaia
che tenga conto della sua permanente tendenza all'autonomia. Uno dei
profeti d i questo nuovo umanesimo del lavoro, funzionario della Glacier
Metal Company, non ha dubbi nell'affermare che «Nel caso di una retribu-
zione corrispondente al concreto livello di discrezionalità, l'interessato ( ! )
si troverà in uno stato di soddisfazione ( ! ) , per cui non presenterà richieste
di aumento e non manifesterà atteggiamenti di ostilità o risentimento (!)» (24).
Ma, a questo punto, è bene vedere sistematicamente come gli addetti alla
riorganizzazione del lavoro industriale, managers, sociologi del lavoro e indu-
strial engineers, affrontano l e questioni relative al la riorganizzazione del
modo d i produrre. Farebbe un grave errore chi credesse che l e idee d i
questi illustri
operatori socio-tecnici
rappresentino l a reale dinamica del
modo capitalistico di produrre. Sarebbe come confondere Agnelli e la Con-
findustria con Ruffolo, non capire la differenza tra i l progetto capitalistico
così come avanza nella realtà e l'esigenza d i mistificazione (vale a dire:
universalizzazione del dato) che gli è connaturata. Ciò non significa che le
idee di questi signori siano del tutto irrilevanti, anzi. Gl i addetti ai lavori
(sociologi e compagnia) sono gente interessante, i l cui permanente contatto
coni e fonti del potere obbliga a porre (prevalentemente in modo sbagliato)
i problemi giusti. Rappresentano i l terreno sul quale, pur attraverso mille
mediazioni, vengono poste le contraddizioni che derivano dall'incapacità del
capitalismo d i ridurre permanentemente l a classe operaia in forza lavoro.
Ciò che qui c i interessa d i questi sviluppi della scienza a l servizio dei
padroni è la problematica generale che sottendono come espressione di con-
traddizioni che maturano scelte organizzative e tecnologiche di nuovo tipo.
E' nelle caratteristiche che seguono che, in genere, vengono rilevati i
connotati principali del modo di produzione attualmente dominante.
a)
Rigida divisione dei compiti tra le diverse funzioni, per es: fabbri-
cazione, controllo tempi e metodi, controllo qualità, manutenzione, supervi-
sione. Ciascuno degli
enti
preposti ad una. determinata funzione ha prescrit-
tivamente delimitata l'area d'intervento e i relativi margini di autonomia.
b)
La direzione generale attraverso un articolato sistema di deleghe
di potere assicura l'ordinato sviluppo del processo produttivo dimensio-
nando in modo diverso le modalità operative dei diversi enti a seconda delle
esigenze di
equilibrio socio-tecnico
che di volta in volta si presentano.
(24) J.M.M. T h e tinte span of discretion, tr. it. Isper. In A. Anfossi, Prospettive socio-
logiche sull'organizzazione industriale,
Franco Angeli 1971, s i legge a p. 339: «La
capacità di autoregolarsi delle parti è una condizione perché possa autoregolarsi i l
sistema nel suo insieme... Un sistema che si autoregoli a livello globale, ma senza
decentrare l a capacità d i autoregolarsi delle parti non può essere 'efficiente' non
soltanto per i costi che deve sostenere, ma anche perché un elemento della sua
inefficienza è i l 'potere negativo' che si esercita là dove è precluso l'esercizio del
potere positivo...».
159
















