
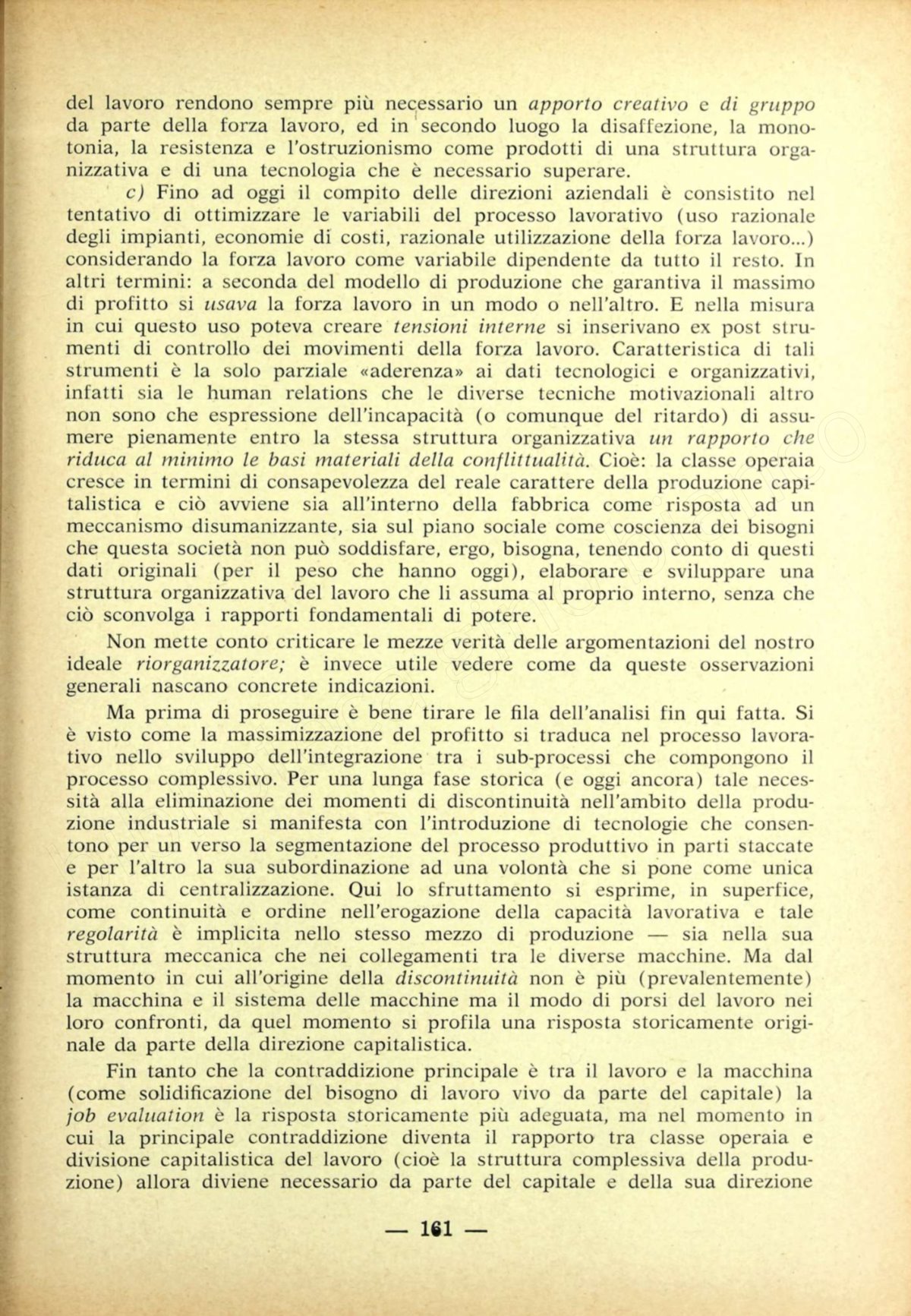
del lavoro rendono sempre p i ù necessario un
apporto creativo
e
d i gruppo
da parte del la forza lavoro, ed i n I secondo luogo l a disaffezione, l a mono-
tonia, l a resistenza e l'ostruzionismo come prodot t i d i una st rut tura orga-
nizzativa e d i una tecnologia che è necessario superare.
'
c )
Fino ad oggi i l compi to del le direzioni aziendali è consistito nel
tentativo d i ottimizzare l e var iabi l i del processo lavorativo (uso razionale
degli impianti, economie di costi, razionale utilizzazione della forza lavoro...)
considerando la forza lavoro come variabile dipendente da tut to i l resto. I n
altri termini : a seconda del modello d i produzione che garantiva i l massimo
di prof i t to s i
usava
la forza lavoro i n un modo o nell'altro. E nel la misura
in cui questo uso poteva creare•
tensioni interne
si inserivano ex post stru-
menti d i control lo dei moviment i del la forza lavoro. Caratteristica d i t a l i
strumenti è l a solo parziale «aderenza» a i dat i tecnologici e organizzativi,
infatti s ia l e human relations che l e diverse tecniche motivazionali a l t ro
non sono che espressione dell'incapacità ( o comunque del r i tardo) d i assu-
mere pienamente ent ro l a stessa st rut tura organizzativa
u n rappor to che
riduca al minimo le basi materiali della conflittualità. Cioè: la classe operaia
cresce in termini di consapevolezza del reale carattere della produzione capi-
talistica e c i ò avviene sia al l ' interno del la fabbr ica come risposta ad u n
meccanismo disumanizzante, sia sul piano sociale come coscienza dei bisogni
che questa società non può soddisfare, ergo, bisogna, tenendo conto di questi
dati or iginal i ( p e r i l peso che hanno oggi ) , elaborare e svi luppare una
struttura organizzativa del lavoro che l i assuma al proprio interno, senza che
ciò sconvolga i rapport i fondamentali d i potere.
• N o n mette conto criticare le mezze verità delle argomentazioni del nostro
ideale
riorganizzatore;
è invece ut i l e vedere come da queste osservazioni
generali nascano concrete indicazioni.
Ma pr ima d i proseguire è bene t irare le f i la dell'analisi f i n qu i fatta. Si
è visto come la massimizzazione del prof i t to s i traduca nel processo lavora-
tivo nel lo svi luppo dell'integrazione t r a i sub-processi che compongono i l
processo complessivo. Per una lunga fase storica (e oggi ancora) tale neces-
sità al la eliminazione dei momenti d i discontinuità nell 'ambito della produ-
zione industriale s i manifesta con l ' introduzione d i tecnologie che consen-
tono per un verso la segmentazione del processo produttivo in part i staccate
e per l 'al tro l a sua subordinazione ad una volontà che si Pone come unica
istanza d i centralizzazione. Qu i l o sfruttamento s i esprime, i n superfice,
come cont inui tà e ordine nell'erogazione del la capacità lavorativa e ta l e
regolarità
è impl ici ta nel lo stesso mezzo d i produzione — s ia nel la sua
struttura meccanica che nei collegamenti t r a l e diverse macchine. Ma dal
momento i n cui all 'origine del la
discontinuità
non è p i ù (prevalentemente)
la macchina e i l sistema delle macchine ma i l modo d i porsi del lavoro nei
loro confronti, da quel momento si prof i la una risposta storicamente origi-
nale da parte della direzione capitalistica.
Fin tanto che la contraddizione principale è t ra i l lavoro e la macchina
(come solidificazione de l bisogno d i lavoro vivo da parte del capitale) l a
job evaluation
è l a risposta storicamente più adeguata, ma nel momento i n
cui l a principale contraddizione diventa i l rappor to t r a classe operaia e
divisione capitalistica del lavoro (cioè la strut tura complessiva della produ-
zione) al lora diviene necessario da parte del capitale e del la sua direzione
















