
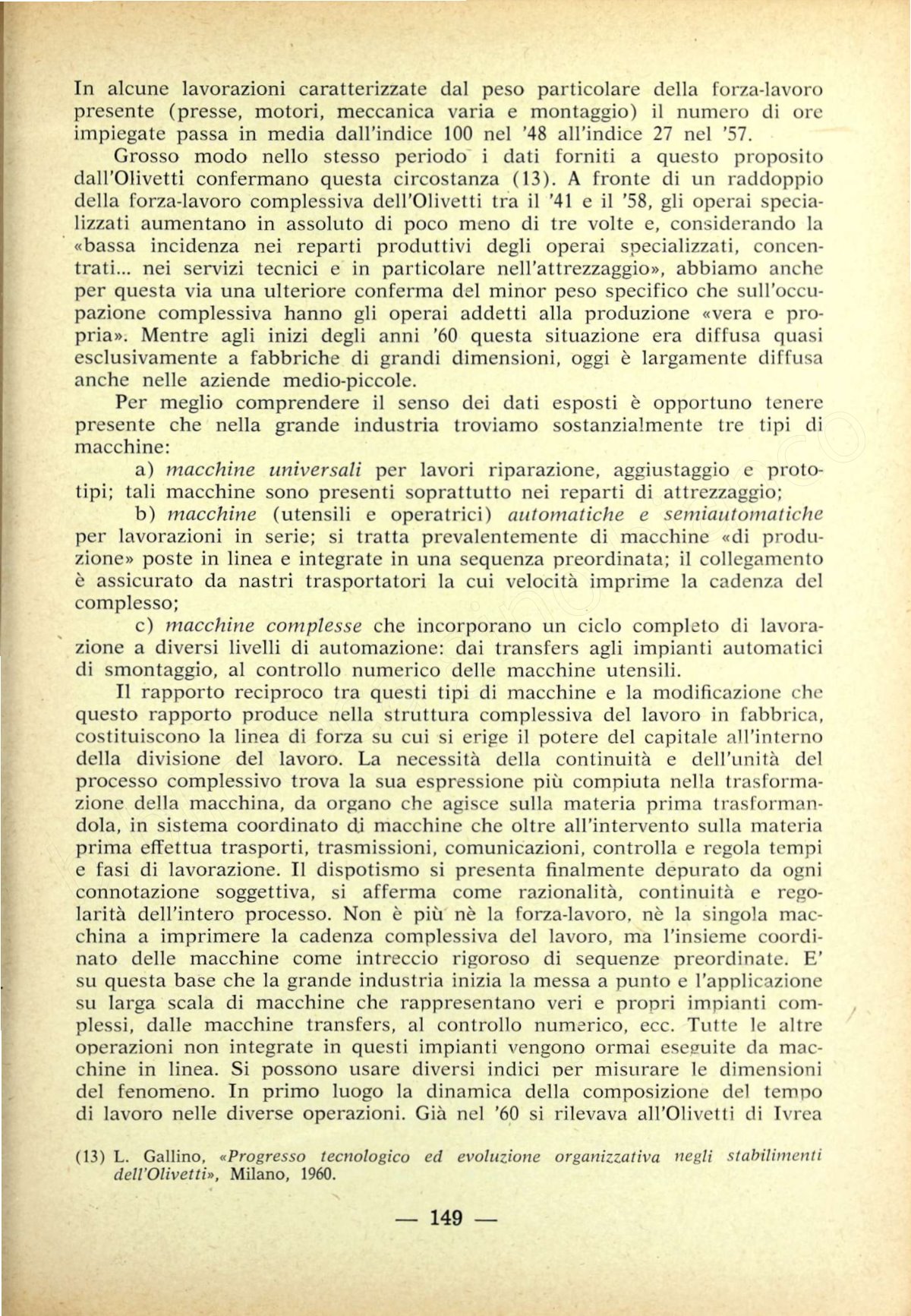
In alcune lavorazioni caratterizzate dal peso particolare della forza-lavoro
presente (presse, motori, meccanica varia e montaggio) i l numero d i ore
impiegate passa in media dall'indice 100 nel '48 all'indice 27 nel '57.
Grosso modo nello stesso periodo- i dat i forniti a questo proposito
dall'Olivetti confermano questa circostanza (13). A fronte di un raddoppio
della forza-lavoro complessiva dell'Olivetti fra il '41 e il '58, gli operai specia-
lizzati aumentano in assoluto di poco meno di tre volte e, considerando la
«bassa incidenza nei reparti produttivi degli operai specializzati, concen-
trati... nei servizi tecnici e in particolare nell'attrezzaggio», abbiamo anche
per questa via una ulteriore conferma del minor peso specifico che sull'occu-
pazione complessiva hanno gli operai addetti alla produzione «vera e pro-
pria». Mentre agli inizi degli anni '60 questa situazione era diffusa quasi
esclusivamente a fabbriche di grandi dimensioni, oggi è largamente diffusa
anche nelle aziende medio-piccole.
Per meglio comprendere i l senso dei dati esposti è opportuno tenere
presente che nella grande industria troviamo sostanzialmente t re t ipi d i
macchine:
a)
macchine universali
per lavori riparazione, aggiustaggio e proto-
tipi; tal i macchine sono presenti soprattutto nei reparti di attrezzaggio;
b) macchine (utensili e operatrici) automatiche e semiautomatiche
per lavorazioni in serie; si tratta prevalentemente di macchine «di produ-
zione» poste in linea e integrate in una sequenza preordinata; i l collegamento
è assicurato da nastri trasportatori la cui velocità imprime la cadenza del
complesso;
c)
macchine complesse
che incorporano un ciclo completo di lavora-
zione a diversi livelli di automazione: dai transfers agli impianti automatici
di smontaggio, al controllo numerico delle macchine utensili.
Il rapporto reciproco tra questi tipi di macchine e la modificazione che
questo rapporto produce nella struttura complessiva del lavoro in fabbrica,
costituiscono la linea di forza su cui si erige il potere del capitale all'interno
della divisione del lavoro. L a necessità della continuità e dell'unità del
processo complessivo trova la sua espressione più compiuta nella trasforma-
zione della macchina, da organo che agisce sulla materia prima trasforman-
dola, in sistema coordinato di macchine che oltre all'intervento sulla materia
prima effettua trasporti, trasmissioni, comunicazioni, controlla e regola tempi
e fasi di lavorazione. I l dispotismo si presenta finalmente depurato da ogni
connotazione soggettiva, s i afferma come razionalità, continuità e rego-
larità dell'intero processo. Non è più nè la forza-lavoro, nè la singola mac-
china a imprimere la cadenza complessiva del lavoro, ma l'insieme coordi-
nato delle macchine come intreccio rigoroso d i sequenze preordinate. E '
su questa base che la grande industria inizia la messa a punto e l'applicazione
su larga scala di macchine che rappresentano veri e propri impianti com-
plessi, dalle macchine transfers, al controllo numerico, ecc. Tutte le altre
operazioni non integrate in questi impianti vengono ormai eseguite da mac-
chine in linea. Si possono usare diversi indici per misurare le dimensioni
del fenomeno. I n primo luogo la dinamica della composizione del tempo
di lavoro nelle diverse operazioni. Già nel '60 si rilevava all'Olivetti di Ivrea
(13) L. Gallino, «Progresso tecnologico e d evoluzione organizzativa negl i stabilimenti
dell'Olivetti», Milano, 1960.
149
















