
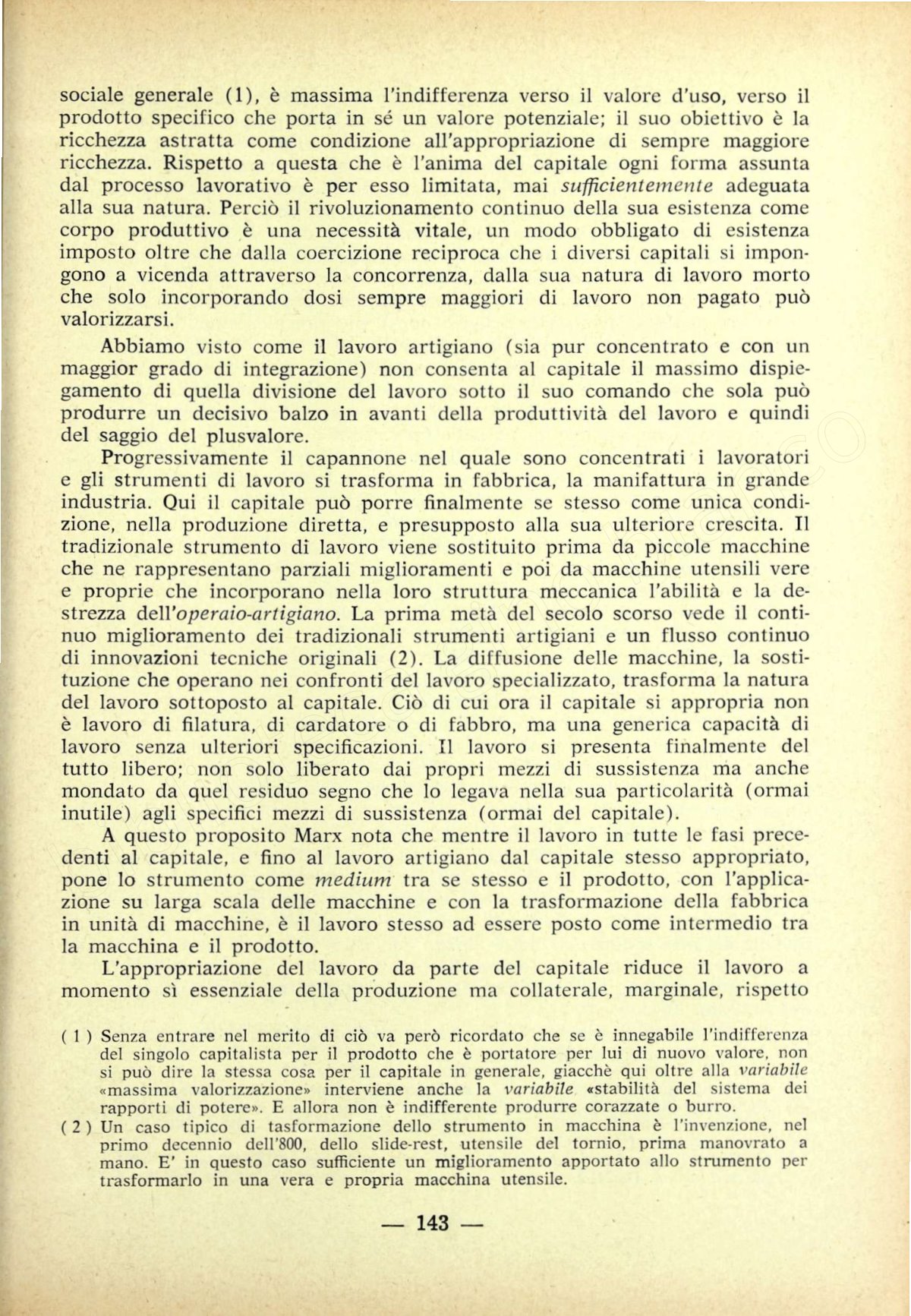
sociale generale (1) , è massima l'indifferenza verso i l valore d'uso, verso i l
prodotto specifico che porta in sé un valore potenziale; i l suo obiettivo è la
ricchezza astratta come condizione all'appropriazione d i sempre maggiore
ricchezza. Rispetto a questa che è l'anima del capitale ogni forma assunta
dal processo lavorativo è per esso limitata, mai
sufficientemente
adeguata
alla sua natura. Perciò il rivoluzionamento continuo della sua esistenza come
corpo produttivo è una necessità vitale, un modo obbligato d i esistenza
imposto oltre che dalla coercizione reciproca che i diversi capitali si impon-
gono a vicenda attraverso la concorrenza, dalla sua natura di lavoro morto
che solo incorporando dosi sempre maggiori d i lavoro non pagato può
valorizzarsi.
Abbiamo visto come i l lavoro artigiano (sia pur concentrato e con un
maggior grado di integrazione) non consenta al capitale i l massimo dispie-
gamento di quella divisione del lavoro sotto i l suo comando che sola può
produrre un decisivo balzo in avanti della produttività del lavoro e quindi
del saggio del plusvalore.
Progressivamente i l capannone nel quale sono concentrati i lavoratori
e gli strumenti di lavoro si trasforma in fabbrica, la manifattura in grande
industria. Qui i l capitale può porre finalmente se stesso come unica condi-
zione, nella produzione diretta, e presupposto alla sua ulteriore crescita. I l
tradizionale strumento di lavoro viene sostituito prima da piccole macchine
che ne rappresentano parziali miglioramenti e poi da macchine utensili vere
e proprie che incorporano nella loro struttura meccanica l'abilità e la de-
strezza
dell'operaio-artigiano.
La prima metà del secolo scorso vede i l conti-
nuo miglioramento dei tradizionali strumenti artigiani e un flusso continuo
di innovazioni tecniche originali (2) . La diffusione delle macchine, la sosti-
tuzione che operano nei confronti del lavoro specializzato, trasforma la natura
del lavoro sottoposto al capitale. Ciò di cui ora i l capitale si appropria non
è lavoro di filatura, di cardatore o di fabbro, ma una generica capacità di
lavoro senza ulteriori specificazioni. I l lavoro s i presenta finalmente del
tutto libero; non solo liberato dai propri mezzi d i sussistenza ma anche
mondato da quel residuo segno che lo legava nella sua particolarità (ormai
inutile) agli specifici mezzi di sussistenza (ormai del capitale).
Aquesto proposito Marx nota che mentre il lavoro in tutte le fasi prece-
denti al capitale, e fino al lavoro artigiano dal capitale stesso appropriato,
pone lo strumento come
medium
tra se stesso e i l prodotto, con l'applica-
zione su larga scala delle macchine e con la trasformazione della fabbrica
in unità di macchine, è i l lavoro stesso ad essere posto come intermedio tra
la macchina e i l prodotto.
L'appropriazione del lavoro da parte del capitale riduce i l lavoro a
momento sì essenziale della produzione ma collaterale, marginale, rispetto
( 1 ) Senza entrare nel merito di ciò va però ricordato che se è innegabile l'indifferenza
del singolo capitalista per i l prodotto che è portatore per lui di nuovo valore, non
si può dire la stessa cosa per il capitale in generale, giacchè qui oltre alla
variabile
«massima valorizzazione» interviene anche l a
variabile
«stabilità del sistema dei
rapporti di potere». E allora non è indifferente produrre corazzate o burro.
( 2 ) Un caso tipico d i tasformazione dello strumento i n macchina è l'invenzione, nel
primo decennio dell'800, dello slide-rest, utensile del tornio, prima manovrato a
mano. E ' in questo caso sufficiente un miglioramento apportato allo strumento per
trasformarlo in una vera e propria macchina utensile.
143
















