
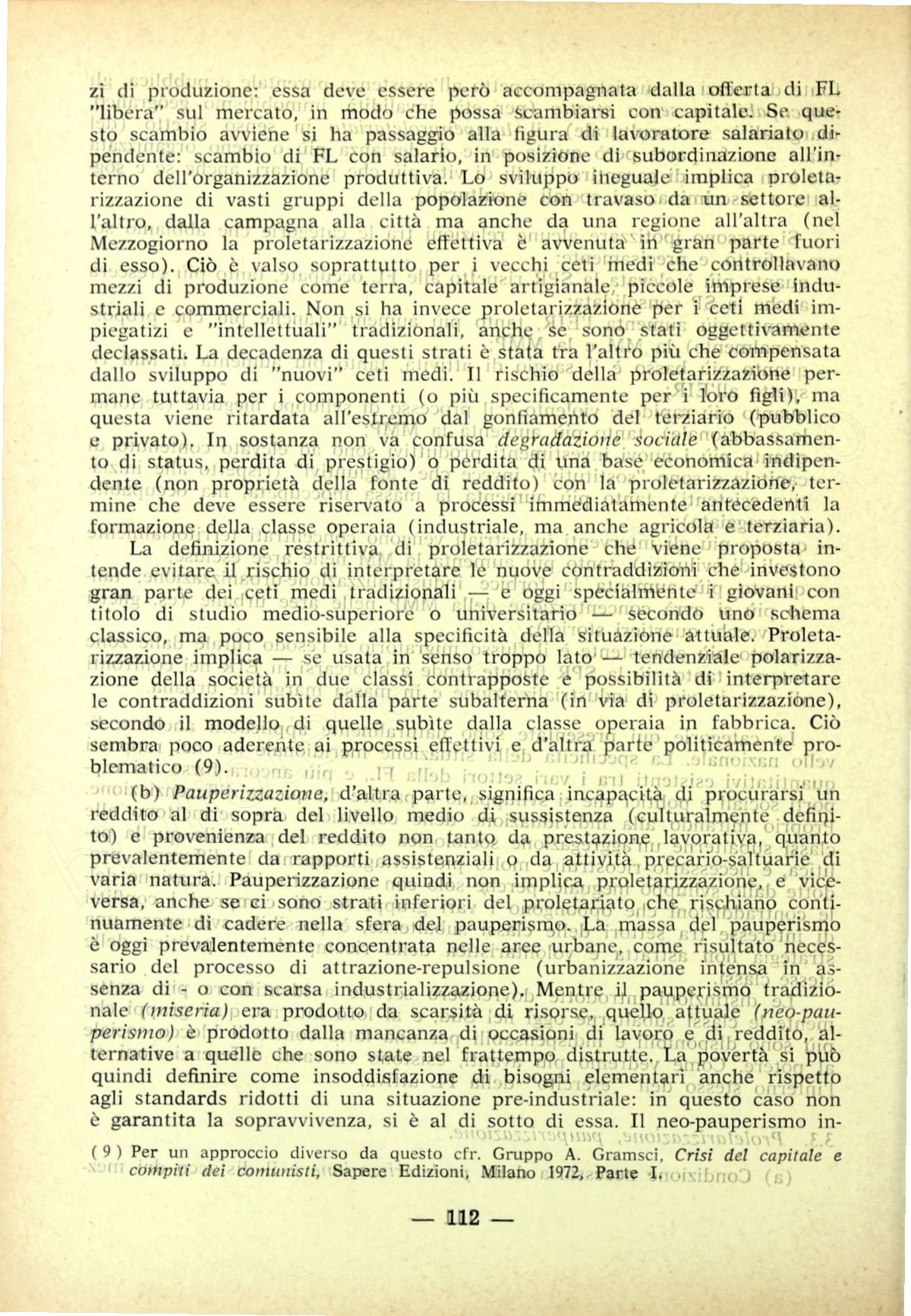
zi d i produzione: essa deve essere però accompagnata dal la !offerta , di FL
"libera" sul mercato, i n Modo Che possa Sdambiarsi con capital&oSe. 'que-
sto ' scarnbio avviene 'Si ha passaggio al la !figura d i latroratore salariato;idi.-
pendente: scambio 'di FL con salario, i n posizione d l subordinazione al l ' in-
terno dell'organizzazione produtt iva. L o sviltiripo ihegualeibimplica I proietti-
rizzazione d i vast i gruppi del la popolaiione t or i travaso illitinún-settore! fal,
l'altro,„ dalla campagna al la c i t tà ma anche da una regione al l 'al t ra ( ne l
Mezzogiorno l a proletarizzazioné effettiva' é anenu t a i i imgran par te f uo r i
di esso). Ciò è valso, soprattutto; per i vecchi cet i Medi Che controllavano
mezzi d i produziOne come terra, capiiale artigianale, piccole ihtprese indu-
striali e 9ommerci.a1i. Non si ha invece proletarizZaZiOne per i: céeti Medi im-
piegatizi e "intel let tual i". tradizionali, anOe se .sonó stat i : oggettivantente
declassati. La decadenza di questi strati è Stata tra l 'altro più 'Che coMpensata
dallo sviluppo d i 'nuovi ' ) cet i Medi . I l r ischio -della' piadletatiZzazione per-
mane tuttavia per i icomponenti ( o più specificamente per ' i! 10 io figii);, ma
questa viene r i tardata all'estremo da l gonfiamento de l terziar io (pubbl ico
e privato). I n sostanza non va confusa
degradazione sociale
1(abbassarnen-
to d i status, perdita d i prestigio) o perdi ta -4(i una base eéonditicaisithdipen-
dente (non propr ietà del la fonte d i reddi to) 'con l a prolétariZzazidift,. •ter-
mine che deve essere riservato a Processinifnritédiatànente; rantecédentl l a
formazione della classe operaia (industriale, ma anche agricola ei-terziatia).
La definizione rèst r i t t iva d i proletariZzazione chèmv i t ie proposta i in-
tende evitare i l „rischio di interpretare le nt faid dontraddi t iat i Chetiiiùzestono
, .
gran parte dei cet i medi tradizional i — è NgiEkpeCialffiénte i giovanir con
titolo d i studio medio-superiore o uniirdrersitatidn11-» SécorirdO uno schema
classico, ma poco sensibile al la specificità cfOla kithazioneJattúble. Proleta-
rizzazione impl ica .-:-. sé usata i n senso troppo lato! — ten'dentliale polarizza-
zione del la società i n due ' classi contrapPoSte -e..Possibilità', di:! interpretare
le contraddizioni subite dal la parte' subalterha ( i n 4i'a di) proletarizzazitne),
secondo i l modello, d i quel le ,subìte (dalla classe operaia i n fabbrica. Ci ò
sembra, poco aderente ai processi eff?t_tiVi,,e, ci•Jdi i i;l icialVphl itlaiténtei pro-
... i i i : _,I.) r i l ' i l l l I n C V . E t i . f i l i 3 f l O I N L A I U l l i n
blematico (9)., : . , , i r r t f, • i :
' 4 , " i : ' , ' i » r i w i , • ' ; : • • ' , ,
•(b.)
Pauperizzazio-ne,
d'al tra . parte, , significa incaEgcita, di procurarsi un
reddito a l d i sopra. del l ivel lo medio dri ,sussistenza (ctiitiut;almente defini-
to) e provenienza; del reddito non, tanto da, prestazione laxprativa, Oan t o
prevalentemente da rappor t i assistenziali o da a t t i v i 4 t..precari6-saltuatie l p
varia natura. Pa.Uperizzazione quindi non impl ica pr91 etarizzazió4ef'í e' vide-
versa, anche, serei 'sono strat i , 'inferiori det,proletariato che riSgbyiano contk
nuamente . di cadere nel la sfera del; ,pauperismo. La massa del -pbuperktrio
è oggi prevalentemente conoentrata pelle aree urbapei, c o r k risultato neq0-
safio . del processo d i attrazione-repulsione (urbanizzazione intensa i n d-s-
sénza dir - o con scarsa industnalizzazione). Mentre i lri auperismo t radbio-
,
i
nale
i
(miseria)
era prodotto da scarsità d i risorse, eine a t t u a l e Grzenau-
ternative a 'quelle che sono state nel 'frattempo distrutte. d i f t 6 'Ai-
pover r()às i né ; ) i i s VI; r
perismo)
è prodotto dal la mancanzaH4ppcasioni di: liatirof e d i r e
quindi def inire come insoddisfazione d i bisogni elementari 'anche r isi le fp
agli standards r i dot t i d i una situazione pre-industriale: i n questo Caso non
è garantita la sopravvivenza, si è a l d i sot to d i essa. I l neo-pauperismo in-
( 9 ) Per un approccio diverso da questo c f r. Gruppo A . Gramsci,
Crisi del capitale
e
i
compivi
dei
dornimisti, .Sapere
Edizioni, Affilane
1.1972,Parte
IcoixtbnoD ( s )
112 —
















