
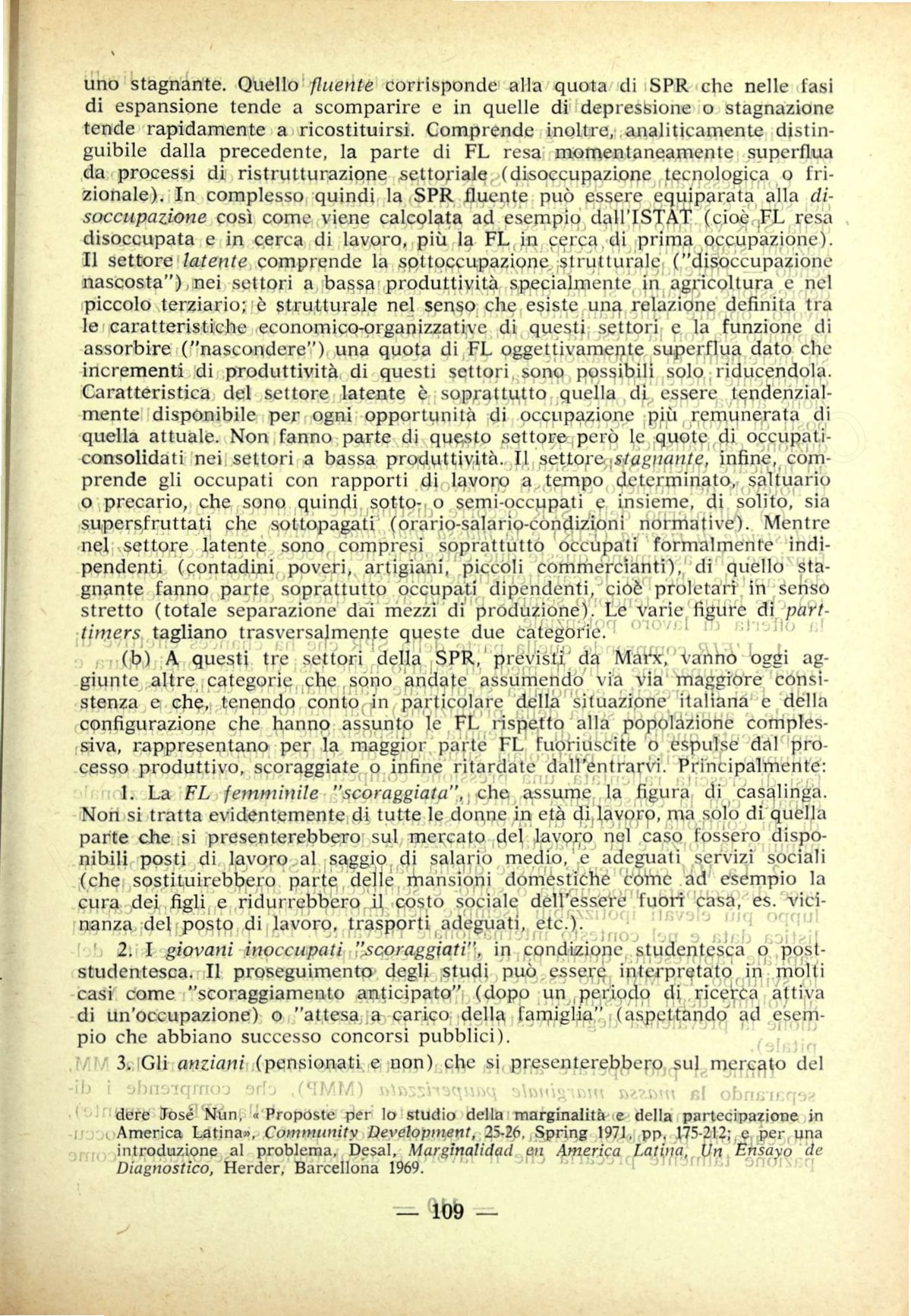
uno stagnante. Quello •
fluente
corrisponde al la quota d i SPR che nelle fasi
di espansione tende a scomparire e i n quelle d i depressione o stagnazione
tende rapidamente a ricostituirsi. Comprende inoltre, analiticamente distin-
guibile dal la precedente, l a par te d i F L resa momentaneamente superflua
da processi d i ristrutturazione .settoriale, (disoccupazione tecnologica o f r i -
zionale). I n complesso quindi l a SPR fluente può essere equiparata al la
di -
soccupazione
così come viene calcolata ad esempio dal l ' ISTAT (cioè ,FL resa
disoccupata e i n eerca d i lavoro, più la FL i n ce r a , di pr ima occupazione).
I l settore i
latente
comprende la sottoccupazione strutturale ("disoccupazione
nascosta"), nei settori a bassa produtt ivi tà specialmente, in agi icoltura e nel
piccolo terziario; .è strutturale nel senso che esiste una relazione definita t ra
le caratteristiche economico-organizzative d i questi settori e l a funzione d i
assorbire ("nascondere") una quota di FL oggettivamente superflua dato che
incrementi d i produt t ivi tà d i questi settori, sono p9ssibi l i solo riducendola.
Caratteristica del settore latente è soprattutto quel la d i essere tendenzial-
mente disponibile per ogni opportuni tà d i occupazione p i ù remunerata d i
quella attuale. Non fanno parte di questo settore però le quote ,di occupati-
consolidati nei, settori a bassa produttività. I l
settore,;sitcigizante;
infine, com-
prende g l i occupati con rappor t i d i lavoro a tempo determinato, saltuario
o precario, che sono quindi sotto-, o semi-occupati e insieme, d i solito, sia
supersfruttati che sottopagati (orar io-salario-condizioni n o i -i-native). Ment re
nel settore latente sono, compresi soprat tut to occupati formalmente i nd i -
pendenti (contadini, ,poveri, art igiani , piccol i cornniercianti), d i quel lo sta-
gnante fanno parte soprattutto occupati dipendenti, cióè proletari i n senso
stretto (totale separazione dai níezi t di produzione). Le varie figure
d i part-
timers
tagliano trasversalmente queste due categorie.
(li) A quest i t r e set tor i del la ISPR,1 previsti da Marx, -Canho oggi ag-
giunte al t re categorie che sono andate assumendo v ia Via' maggiore consi-
stenza e ché, tenendo conto i n particolare del la i i tuai ione ital iana e del la
configurazione che hanno assunto le r t , rispetto al la popolazione corriples-
siva, rappresentano per la maggior parte FL fubriuscité 'o esPulsé dal pro-
cesso produttivo, scoraggiate o infine ri tardate dall'entrarVi. Principalmente:
1.
L a
F L femmini le "scoraggiata",,
che assume l a f igura d i casalinga.
Non si tratta evidentemente di tutte le donne in età diflavoro, ma solo di quella
parte che si presenterebbero sul mercato del lavorio nel Caso fosSero dispo-
nibi l i post i
d i
lavoro a l saggio d i salario medio, ' e adeguati servizi sociali
(che sostituirebbero parte del le Mansioni domestiche 'C'Orne i d esemp* io l a
cura dei f igl i e ridurrebbero i l co.sto sociale dell'essere fuor i casa, es. vici-
nanza del posto d i lavoro, trasport i adeguati, etc.)..
, •
2. I
giovani inoccupati "scoraggiati",
i n condizione studentesea o post-
studentesca. I l proseguimento' degli studi può essere interpretato, in mo l t i
casi come "scoraggiamento anticipato" (dopo un , periodo d i ricerca at t iva
di un'occupazione) o "attesa a carico del la famigl ia" (aspettando" ad esem-
pio che abbiano successo concorsi pubbl ici).
,MIVI 3. Gl i
anziani
(pensionati e non) che si presenterebbero sul mercato del
i s i n-1gram 9(4, , •
I
.(f.)intiere ThaPNun, « Proposte per l a studio del la rtriarginalità te del la partecipazione i n
- rmeAmer ica Latina»,
Communi ty Deyelopment,
25 , 2 f i , pr i ng 1971, pp, 175-212; e per una
,iffro. introduzione a l problema, Desal, Margit?aliipgd,,pn, America Lat ina, U n t hsayo d e
Diagnostico,
Herder, 13arcellona 1969.
















