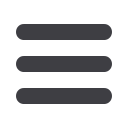
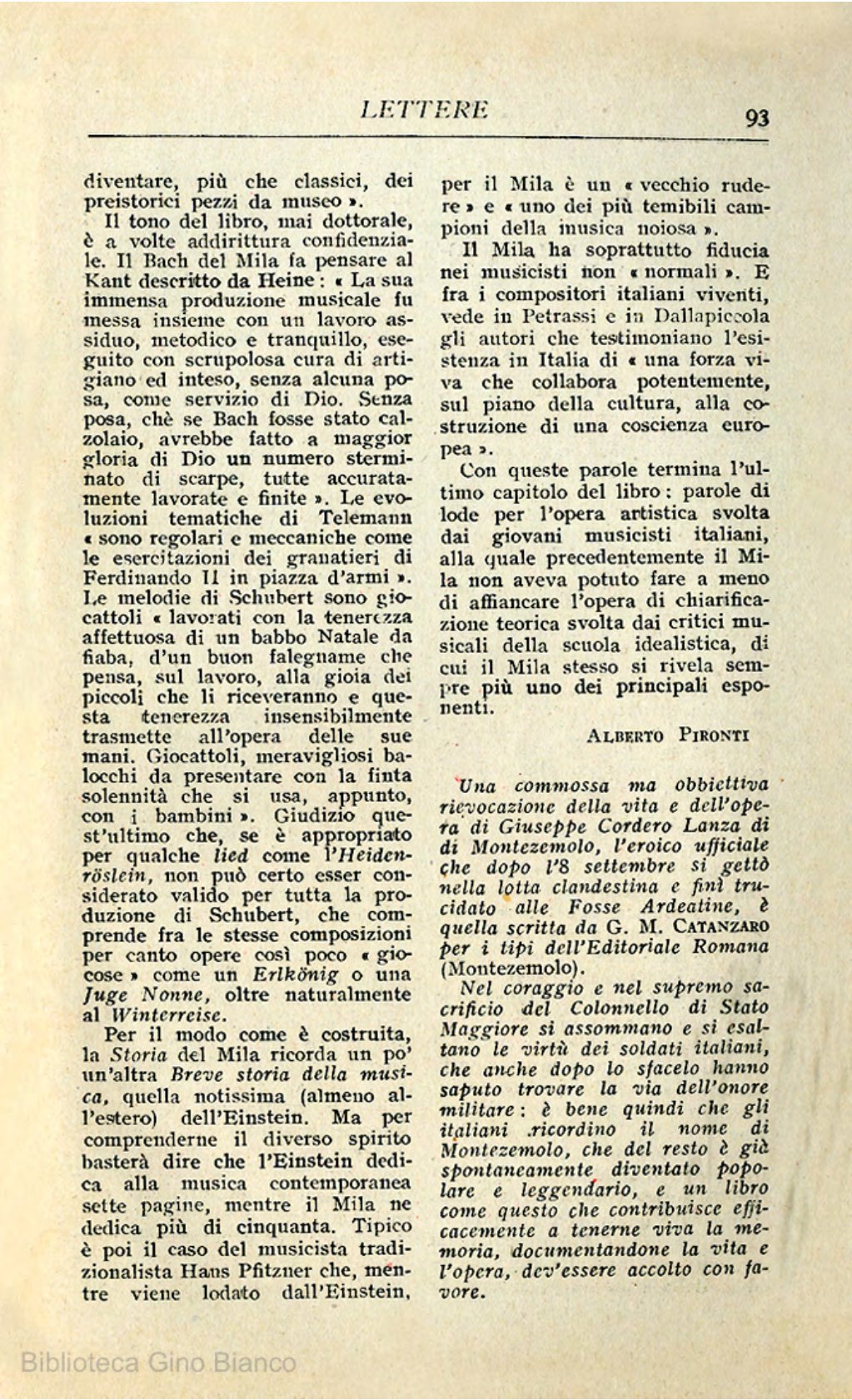
LET'/"ENE
93
rll\'~nt:l~c!
più
che classici,
dei
prc1stonc1 peni
da
musco •-
Il
tono
del libro, mai dottoral e,
è
a ,-olle addirittura
confidcu:da–
lc. 11 Hach del Mila fa pensare al
!{a11t
dcs
<'ritto da He ine : • La
sua
1mmen~a
produ:r.ioncmusicale
fu
me~sa 111s1cmccon un la,,oro n!'i–
sid_uo, metodico e tranqui llo, cse–
g111to con
scrupolosa
cura
di
arti–
gi:mo ed int
f$0, scm:a alcun a
po–
s.:a,
come
:i;
crvi7.iodi
Dio. Sc:nu
posa, chè
~
Bach fosse stato cal–
zolaio,
:wrebbe
fatto a
n1aggior
gloria di Dio un numero stermi–
nato
di
scarpe,
tutte
atturata–
mentc l:l\'orate e finite •-
Le
evo–
lmdoni
tematiche
di Tclem:mn
• :sono regolari e mcccanicbe come
le C'll!rcitazioni dei grnna tieri di
Fcrdimmdo 11 in piaua d'arm i ,.
I.e melodie 1i Schubert sono
~!0-
catto li • lavorati oon la tent!ruza
affett uosa
di
un babbo Natale da
linba, d'un buon falegname che
J)elll'la,
~ul
ln\'oro, alla gioia
cld
pitt01i che
li
ri~,·eranno
e que–
sta
tc11crc1.1,.'\ inS(>nsibilmente
trasmette
a.Il
'opera
delle
sue
mani . Giocattoli, mcra\'igliosi
ba•
loechi
da presentare
con la fiuta
AOlennità
che
si
usa,
appunto,
con
i
bambini •· Giud izJO
quc-
~••~\:ich~b~,ic;e
c!n!Pf.~~r~::
;fJ!~~~
n:,'\~l
0
uòpt~r~:t~ki!
:~
duzione
di Schubert,
che
com·
prende fra le st~se
composizion i
pcr canto opere
<'OSl poco
• gio–
cose • come un
Erlkèmig
o unn
Juge No1U1e,
oltre nat uralmente
al
1Vintr.rrt/$c,
Per il modo oome
è
costruita,
In
Storia
del Mila ricorda un
po'
un'altra
Brr Je storia della musl–
€a,
quella noli !t!ima
(almeno
al–
l'e!lt.cro)
dell'Ein stein. Ma
per
comprenderne
il
dh·ttSO
spirito
basterà dire
che l'Einste in
dtdi–
~
alla
nmsic.a. contcmpornnca
~ttc
pagine,
mentre
il Mila ne
dedica più di cinqua nta. Tipico
è
poi
il
caso del musicis ta trad i-
7,ionali:,;taHa11sPfitzner che, men–
tre
,•ieuc
lodnto
dall 'Eins tein,
per
il
Mila
è
un • ,·ttehio
rude–
re • e • uno dei più temibili cam–
pioni della inusica noios.a •·
Il Mila ha soprattutto
fiducia
nei m111:licistinon
, normali •·
B
fra
i
compos itori italiani
\'Ì\'cnti ,
,·c<lc.
iu
l'etra ssi
e
in Dallapicro la
gli nutori
clic
testi11101iano l'csi–
!ltcuza in Italia di .-una forza
,,j.
va
c~c
collabora
potcn tcmc-ntc,
sul piano
della
cultura,
alla
ce>–
struzione
di
una
coscienza
cun>
pea •·
Con qnc."le parole term ina l'u l•
timo capitol
o dellibro: parole di
locJc
per
l'
ope.raartistica
svolt a
dai
giovani
mus icisti
italiani ,
alla
(Jt1alc
prcc«lentcm ente il Mi·
la
uon
ave\'a
potuto fare
a
meno
di
affiancare l'opera
di
chi:ui fica–
:r.ionc teorica S\'olta dai critici
mu–
sicali
della scuola
idealistica, di
cui il Mih1 !'tesso si rivela sem–
pre più uno
dei
prin cipali espo–
nenti.
ALBERTO
P1ROSTI
·u"a
,om mossa
ma obbidtl-va
rir:-.:oca:ioncdella vita e ddl'ope–
ra
di
Ghueppe Cordero Lan:a
di
di
Mo,1tezemolo,
l'eroico ufficiale
,he
dopo
l'8
seUembre
si gettb
nella lotta clandesthia
e fini
tn4•
e/dato
nlle Fosse
Ardeatine,
i
q11ella s,r itta da
G.
M. CATASZARO
per
i
tipi dell'Edito riale Romana
(MontczemoloJ.
Nel
coraggio e nei sup remo sa•
crilicio
41cl
Colonnello
di
Stato
.~111.r:giore si assommano
e
si
rs11I~
iano
le
'tlìrh')
dei soldati
italiani,
che a11die dopo
lo
sfacelo ham 10
saputo
trcrJare la
':lia
dell'ono re
militar e:
i
bc11c quindi
che
gli
itpliani
.ricordi110
il
nome
di
l\lo11tr:emolo, che del reslo
~
già
:te
111
:"~:;;:,:d'a,1!~";
17:c:;,
come questo
Glie
contribuisce
effl–
caccme11te
a
tenerne
vi-va
la me•
,noria, doc11me11tandone
la
-vila e
l'opera, dc"J'essere accolto co11fa-
-vore.
·
















