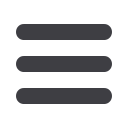
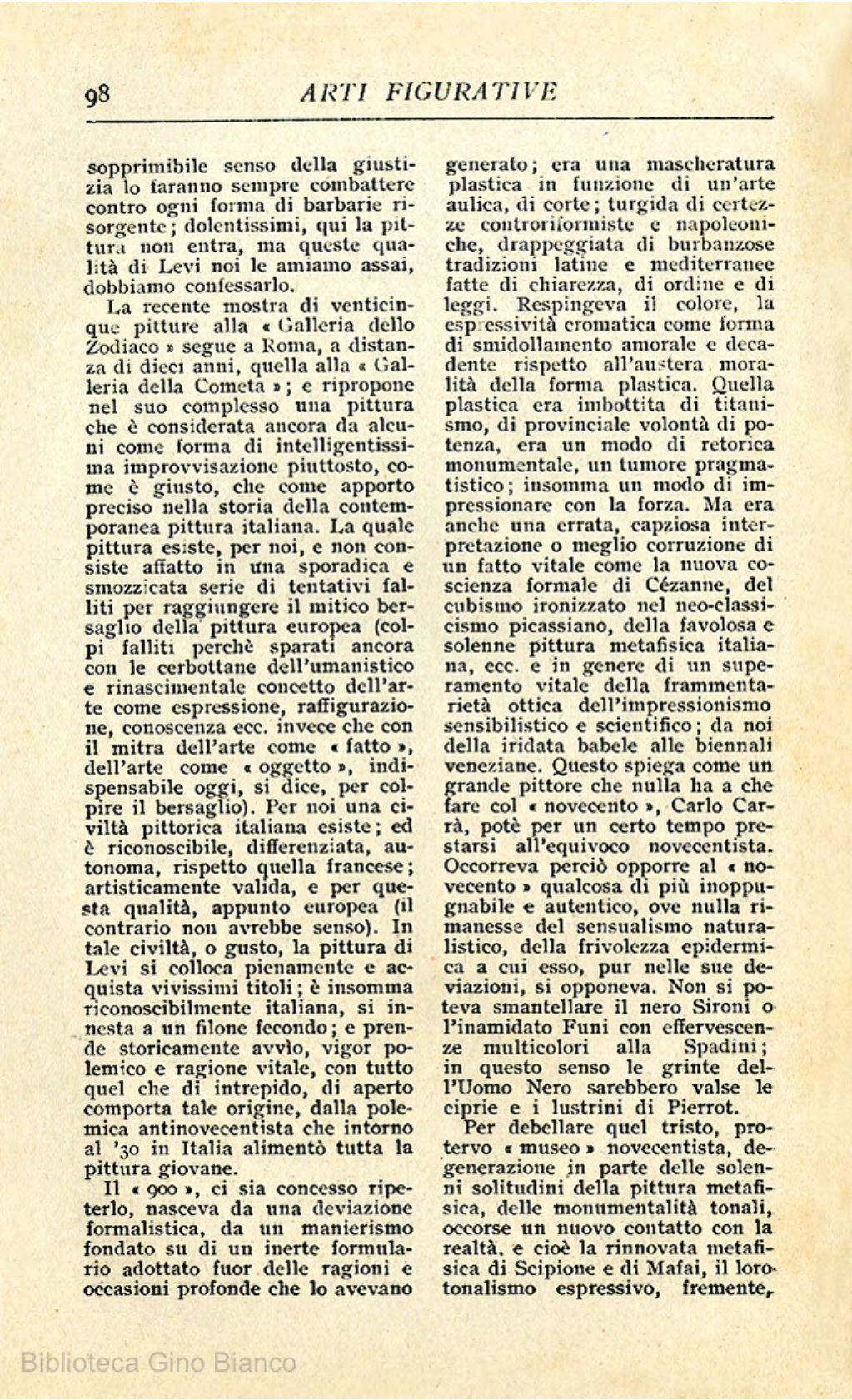
98
AR"fl FIGURATIVE
sopprimibile
senso della giust i–
zia lo faranno
s1:111prc
combath:rc
contro ogni forma
dì
barbarie ri–
sorgente; dolcntissimi, qui la pit–
htf.l
11011
entra, ma queste qua –
lità di Levi noi le amiamo :tSsai,
dobbiamo confessar lo.
La rcC'Cntc mostra di venticin–
que pitture alla • Vallcria dello
Zodiaco• segue a Roma, a distan–
za
di
dicci
ann i,
quella alla • Ual–
leria della Cometa •; e nproponc
nel suo romplesso una pittura
che
è
considerata ancora da alcu–
ni come forma di intcUigcntissi–
ma impron ·isazionc piuttosto,
co–
me
è
giusto, che romc apporto
prceiso ndla storia
della
contem–
poranea pittura it.'lli:ma. I.a qua le
pittu ra
esiste,
per noi, e non con–
siste affatto in una sporadica e
smozz icata serie
di
tentativi
fal-
!~~lror
d~Ìf.,jJ~\~~~;.!
!
1
u ~
(~~=
pi
falliti
pcrcbè
sp:m1t 1 ancora
con le cerbottane dell'umanistico
e rinascimentole concetto dell'ar–
te come espressio ne, ralligurazio-
11e,conoscenza
ccc.
invctt che con
il
mitra dell'arte
come •
fatto ,,
dell'arte come •oggetto,,
indi-
;fr:~fb~~s~fi~).5~:ric1~~i
~~a
~t
viltà pittor ica italiana esiste;
ed
è
riconoscibile, differenziata, au–
tonoma, rispetto ~ne lla francese;
artisticamente vah cla, e per que–
!lta
qualità,
appunto europea (il
contrario non a,•rcbbe senso). In
tale civiltà, o gusto,
la
pittura di
Levi si colloca pienamente e ac–
q,_uista ,•ivissimi tit oli;
è
insomma
nronoscibi lmente il:\li:ma, si in–
nesta a un filone fecondo; e pren–
de storicam ente avvio, vigor
po–
lemico e ragione ,,italc,
con
tutto
quel che di intrepido, tli aperto
comporta tale origine, dalla pole•
mica antinovecentista
c.heintorno
al
1
30 in Italia alimentò tutta la
pittura giovane.
Il •
goo •,
ci sia concesso ripe –
terlo, nasce\'a eia una dc,•iazione
formalistica,
da un
manierismo
fonda to su
di
un inerte formnb.–
rio adott ato fuor delle ragioni
e
ON'asioni profond e che lo avevano
gen1.!rato; era un a mascl1cratura
plastica in funz ione di un'arte
aulica,
di
corte; tur gida
tli
« rtez-
7.C
.;-ontr orifonnistc e napoleon i–
che, drappegi;iata
di burb au1.0se
tradiziom lat111e e medik rran (.'(!
fatte di chiar cz1-'l., di ordiuc e di
leggi. Resp ingeva
il
colore,
la
esp e!/.Sività eròmatk a come forma
di smidollamcnto amorale e deca–
dente rispetto all'au ,-tera mor :i–
lità della forma plastica.
Q,nclla
plastica era imbottita di t:tani–
smo,
di
pro,•incialc volontà di
l_>O–
tenza, era un modo di retorica
monum entale, 11ntumore praima–
tistico; insomma
liii
modo
d1
im–
pressionare
con
la fori:a. i\la era
anche una errata, capziosa inter–
pret.'lzione o meglio corruzione di
un
fatto ,•italc come la 1110,·aco–
scienza formale di Cézanne, del
cubismo ironi zi:ato
nel
ne<K:lassi–
cisnto picassiano, della favolosa e
solenne pittura metafisica italia–
na,
c:cc.
e in gene re di
1111
su))(!•
ramento ,·ital<: clel1a frammenta–
rietà ottica dell'impressionismo
sensibilistico e scient ifico; da noi
della iridata babele alle biennali
vcnc1.ianc. Qu1.!stospiega come un
grande pittore che nulla ha a
cl1c
fare col • novecento, , Carlo Car-
~f~rfit~l)'~~i~-~rt~~!:!'~'t{s~!:
Occorreva perciò OpJ?Orrcal • no–
vecento • qnalcosa
d1
pili
inoppu–
gnabile
e
autentico, ove nulla ri–
manesse del sensnalis.1110natura–
listico , della fri,· olcn a epidermi–
ca a cui esso, pur nelle sue de•
viazioni, si opponeva. Non si
po–
teva smantellare il nero Sirom o•
l'inamidato Funi con effervescen –
ze nmltic olori
alla
Spadini;
in qucsto senso le grinte del–
l'Uomo Nero sarebbero valse
le
ciç,r~: :Ìe~H:r~i;!1 c~i
t~f:~~tPro-
_tcrvo • museo » novecentista,
de–
gcnera~ione jn parte delle solen –
ni solitudini dc11a pittura mctafi –
!!iica, delle monum entalità tonali,
0tt0rse
un nuovo
contatto
con la
realtà.
e
cioè la rinnovata metafi–
sica di Scipione e
tli
Mafai, il loro.
ton alismo esp ressi vo, fremente.,
















