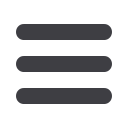
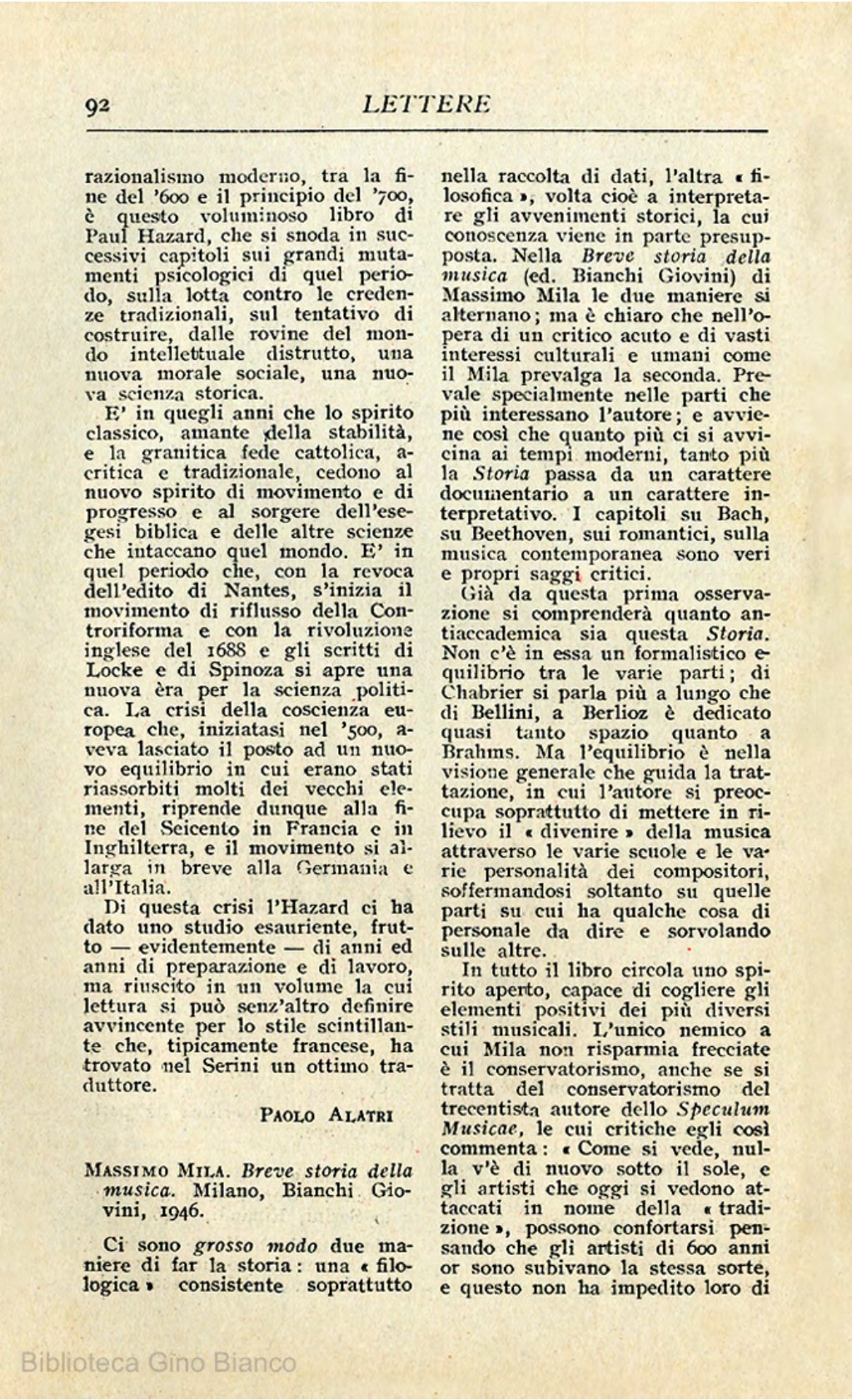
LETTE RE
ra1.ionalismo moderno,
tra la
fi–
ne
del
'6oo e
il
pr indp io
del
•;oo,
f•au1u:;:~~nì:°~!~
1
~iO:od~i~~ suf
C'C$."i\'
i capito li . s_ui rrnn,li
nm~a–
mcuti 1>s1rolog1c1 d1 que l f)(!nO--
~•t;~!i'i~~~\t.
~:1tr~e1!:a1i~:lcdi
costruire,
dalle
ro,•inc del mon•
do
inte llettuale
distru tto,
u11a
11uo,·a
mora le
sociale,
una
nuO;"
va SC'
icnl'~1storica.
F.'
in quegli anni che lo s1>irito
ch ssiro, amante della stabilità,
e
l:l
grani tica. fede cattolica, a–
critica
e trndizionak , cedono al
nuo,·o spirito di movimento e di
propei.soe
a1
sorgere
dcll'ese-–
gl ~ 1
biblica e delle altre
scicnM"
c~1~l
i~=o :t:~I
~:
nr:· r::~:
~cll'ed ito di Nan tcs, s'i
ni1.iail
movimento
<li
rifht"°
de
lla Con–
tror iforma e con
la rivolur.ion:?
ini;:le!'c del 1688 e gli scritt i di
Locke e di Spin oza ai apre un a
1110,·a èra
{>t'T
la
.sdc01 ..
1.
_pol it.i–
ca.
I.a crisi della coscienza eu–
ropea d1c, iniziatai~.i nel
',soo,
a–
\'<°\·alar.ciato il posto ad un nuo–
vo ~uilibri
o in cui erano
st.-iti
ri:issorbi ti molti dei
veccl1i
clc-–
m~nti , riprende dunq ue all:1
fi.
ne ilei Scicenlo in Francia e in
lnghilt crrn, e
il
movimento
~i
al•
lnrJ,!'n in breve alla ncr mani a e
all' It:ilfa.
Di questa crisi l'Hazard ci ba
dato uno stud io esau riente, frut–
to -
evidente mente -
di anni
ed
ann i di preparn7Jonc
e
di la,·oro,
ma rim1cfto in un volume
la cui
lettura
~i
può scn:t'altro
dc6ni re
aN,•in«' nte per lo stile scintilla n•
te che, tip1camcnlc franct~c , ha
t rovato ,nel Serin i un otti mo tra-
1l11ttorc.
P AOLO ALATAI
MASSIMO Mr u.
Bre-.ie SIOria della
m 11sica.
Milano, Bianchi
Gio–
vini, 1946.
Ci sono
grosso modo
due ma–
niere di far la storia:
una • 6)o–
togica.•
consistente
sopra ttutto
nella raccoll..
'I
di dati, l'altra •
fi–
losofica •• ,
1
olta cioè a interpretn–
re gli avvenimenti stor ici, la cui
conoscc111~'l.
\'ÌCllCin parte presup–
posta. Nclln Bre·.;c
storia della
111usicn
(~.
Bianchi Gio" ini) di
MRS$i1no Mila le due maniere
&i
altcr11ano; ma
è
chiaro che nell'o–
pera di uu critico acuto
e
di "asti
mtc ressi cultura li
e
umani
come
il
Mila
prew,lga la se-conda.
Pt'c–
,·ale specia lmente nelle parli che
pi,) intcrcss.1110 l'autore ;
e a",•ic–
nc cosl che C\uanto più ci si avvi–
cina aì tc111>1moderni , tanto più
la
Stcwio
pa.~a da un carattere
docume ntario
a
1111
carattere
in–
t«p relativo. I capitoli su Jlach,
su DcethO\'Cn, sui romantici, sulla
musica contempo ranea sono veri
e
prop ri
uggi
('ritici.
t.:ià da
questa prima osserva–
zione si comprenderà qunnto an–
tiaccademica
sia
questa
Storia.
Non c'è in essa un formalist ico
e–
quilibrio trn.
le
varie
parti ; di
Chabrier si parla più a lungo <'he
di Dellin i, a Dcrlim
è
dedicato
quas i
t;1nto
spaz io
quanto
a
Brahm s.
Ma
l'equilib rio
è
nella
,,isionc genera le che guid a la trat–
tazione, in c-11il'autore
si
preoc-–
cnpa ~
rattutto di mettere in
ri –
lievo
il •
di"c nire • della musica
attravcr110le \':tric scuole e le
w1•
rie pcrso11a\ità
dei compositori,
i-offcrnmndO!'.i soltanto su quelle
part i su cui ha qualche cosa dì
perso nale tln dire
e sorvola ndo
sulle altre.
In tutto il libro
circol:1.unospi –
rito apt.rto, capac
e di cogliere gli
clementi po<ih,•i dei più dh·c ri-i
i-tili musicali. !,'unico nemico a
cui Mila
110! 1
risparmia
frettin tc
è
il ('QtlServatorismo, anche se si
trntta
del
conservator ismo
c\el
trCC<'
nti M:i aut ore dC'1lo
Spt.c1dum
Musicnt.,
le cui critiche egli coel
comme nta:
• Come si vede, nul–
la v•~
t1i
nuo,·o 50tto il ~ole, e
gli art isti che oggi si vedono at–
taccati
in
nome
della
• trad i–
zione •• po$!i0no confort arsi pen·
sando eh~ gli artisti di
6oo
anni
or ~ no subivnno la stessa sorte,
e
questo non ba impc(lito loro di
















