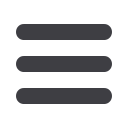
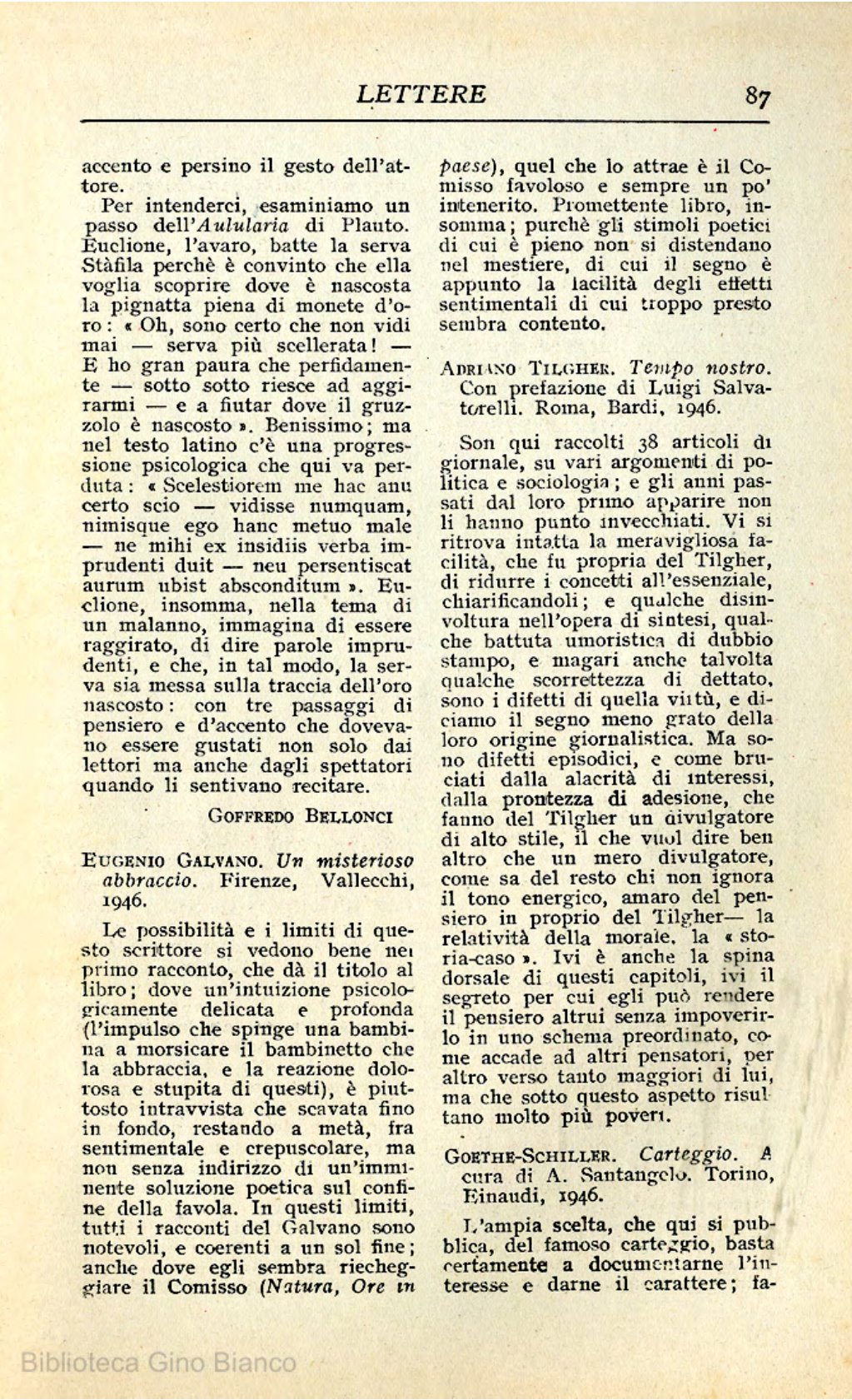
LETTERE
att<:nto e persino
il
gesto dell'at –
tore.
Per intenderci, esaminiamo un
passo
dell'A-ulula ria
di
Pianto.
Euclione, l'avaro, batte la serva
Stàfila
percl1è
è
convinto
che cl1a
voglia scoprire dove
è
nascosta
la pignatta piena di monete d'o–
ro : •
Oh,
sono certo che non vidi
mai - serva
più
sccl1crata
! -
E ho gran paura che perfidamen–
te - sotto sotto ricsc-e ad aggi–
rarmi - e a fintar dove. il gruz.-
~;~\0
t!sfo
35
bti~
0
0
1
C•r~~~~
1
~ ~~r s~
sionc psicologica che qui va per–
duta : • Scelestior,:-m me hac atrn
~rt<:, scio - vidìsse numquarn,
nnmsque ego han c mctuo male
- ne mihi ex insidiis vcrba im–
prudenti duit - ncu pcrscnt iscat
aun1m ubist abscond itum •· Eu–
<:lionc, insomma, nella tema di
un n_i.alanno~in!magina di essere
raggirat o,
dt
dire parole impru–
dent i, e che, in tal modo,
la ser–
va sia messa sulla traccia dell'oro
nascosto: con tre passaggi
di
pensiero e d'accento che doveva–
no essere gustat i non solo dai
kttori
ma anche dagli spettatori
quando
li
sentivano recitare.
GOFFREDO BF.LLONCI
E UGEN IO GAL \'ASO.
Un misterioso
abbraccio.
Firenze,
Vallecchi,
1946.
k
possibilità
e
i
limiti dique–
sto scrit tore si vedono bene
nei
primo racconto, che
dà
il titolo
al
libro ; dove m1'i11t11izionepsieolo–
ckamente
delicata
~
profon da
(l'impulso che spi-nge una bambi•
na a morsica re il bambinetto che
la abbraecia.
e la
reazi<me dolo–
msa e stup ita di que91.i),
è
piut –
tosto intravvista che scavata fino
in fondo, restando
a
metà,
fra
sentimenta le e crepuscolare., ma
non sen za indirizzo d1 un'1mm1-
nente soluzione poetira sul confi–
ne della favola. In questi limiti,
tutt.i
i
racconti del Galvano oono
notevoli, e coerenti a un sol fine;
ancl1c
dove egli Sf'.mbra riecheg–
giare
il
Comisso
(N:itwra,
Ore
,n
paese),
quel che lo attrae
è
il
Co–
misso favoloso e semp re un po'
~~~: !
1
t;11:;1~.;i;:ite;~~~1~:~
di cui
è
pieno non si diste ndano
nel
mestiere,
d\
cui
il
~egno
è
app11nto la 1ac11ità degli etlett1
sentimentali
ùi cui
troppo
prcs.tosembra contento.
A11R11:--0 T tu au:~.
1'ciiipo nostro.
Con prefazione di ~,uigi Salva –
tc,relh . Roma, Bard:, 1946.
Son qui racrolti 38 articoli d1
giornale, su vari argom<'nli di
po–
litica e sociologi a; e gli anni pas–
sati
dal
loro pruno ap.iarire
11011
li ha1110 punto mvecchiali. Vi s1
ritrova int,,tta la meravi gliosi
fa.
c:ilità, che fu propria del Tilgher,
di
ridurre
i
concett i
ali
'essenziale,
chiarificandoli;
e
qu.i.lchc dism –
\'oltnra nell'opera di sia tesi, qual–
che
battuL"\ 11moristlc1
di
dubbio
stampo, e magari anche talvolta
ouak hc scorret tezza di dettato .
SOno
i
difetti
di quella vi1tù , e di–
ciamo il segno meno j!t.'.\lo della
loro origine giornali~t ica. Ma so–
no difetti cp1sodici,
<:
come brn•
dati dalla alacrità di tntercssi,
dalla prontezza
di
adesion e, che
~~
11
~Uoll!!i{~:
1
n
11
~f1/!u~;v :Nl/~:
altro che un mero divul~atore,
come sa del resto chi non 1gnora
il tono energico, amaro del pen–
~iero in proprio del Tilg·her- la
relati vità della morale. la • sto–
ria-<:aso
1.
lvi
è
anch~ la spina
dorsale di questi capitoli, ivi
il
segreto
per
cui egli può re11dere
il
pensiero altrui senza impoverir–
lo
in
uno schema preorclinato,
co–
me accade ad altri pensatori, 9C-r
alt ro verso tanto maggiori di lui,
ma che sotto questo aspetto risul
tano molto più. poveri,
GOl!THlt-ScHIL LF.R.
Carteggio .
,,_
curn di A. Rantang<'l.... Torino,
Einaudi, 1946.
T
.'ampia scelta, che qui si
p11b–
blica,
del famoso carlt>,:Jlio,basta
.-erfamente a docume:1!tarne
J'i11-
teresse e darne il ~arattcre; fa.
















