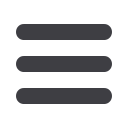
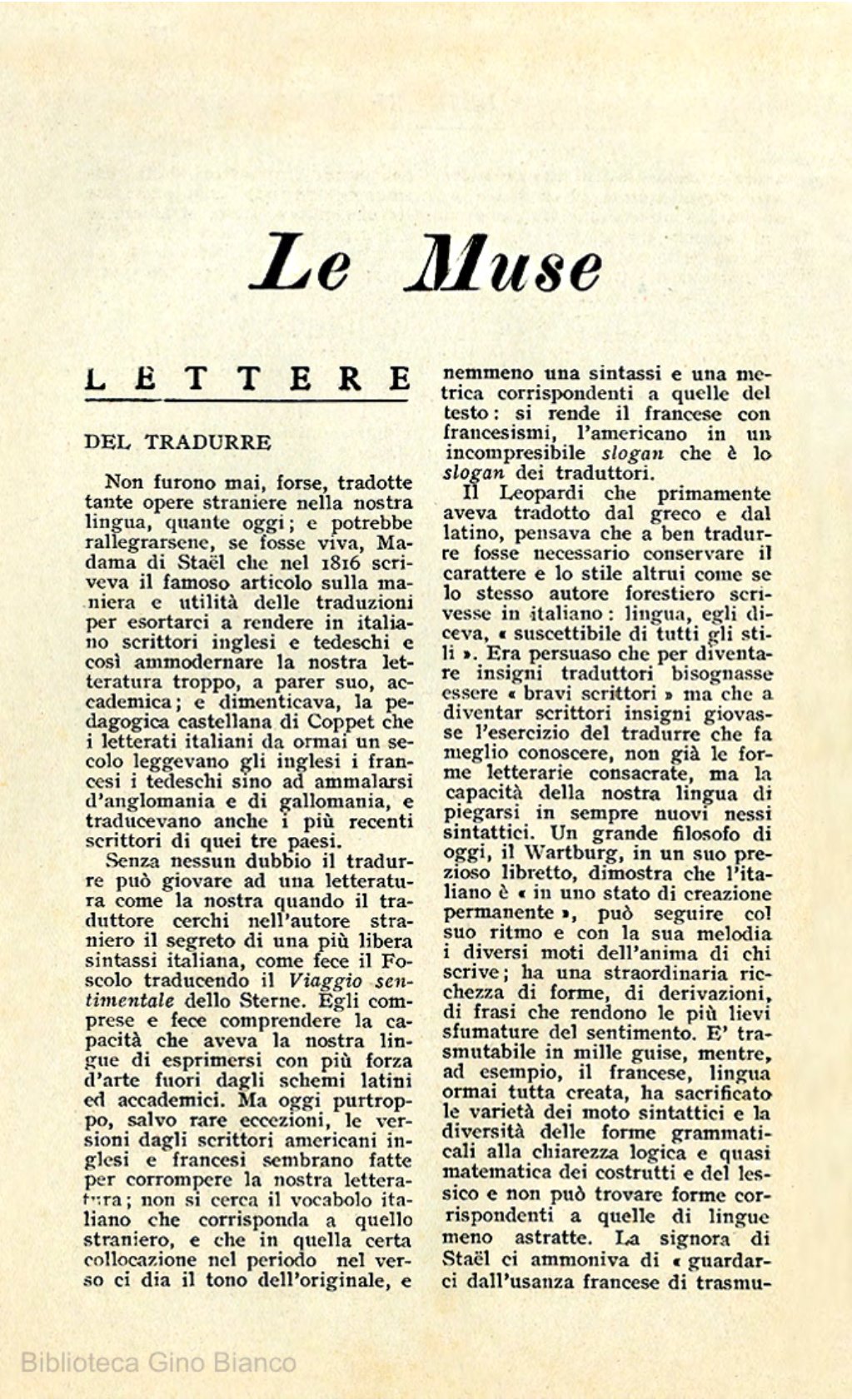
Le
Muse
L E T T E R E
DEL TRAD URRE
Non furono mai, Ione
tradotte
l:lnt.e opere straniere
ncÙa
nostra
~:ifc;~:!c~te
se,~ e
:,e:t:.
dama di Staél che nel 1816 scri–
veva il famoso artirolo sulla ma–
uiern e
utilità
delle
tradu1.ioni
per
esorta rci a rendere in italia–
no scrittori
inglesi e tcdcKhi
e
l'OSI
ao1modcmare
la
nostra
let–
teratura
troppo,
a
parer suo
ac–
cadcn1ic.a
; e diD1Cnticava
1~
pc–
daS"ogica
castc:lla.nadi
eoi,pet
che
i
letterati
italiani daonna1 un
se–
coli?Jegge\•an?
sti
inglesi
i
fran–
ttl
l I
t«tdC'ht
1100
ad
amm alarsi
d'angl omania
e
di
gallomania,
e
tra~luceya~o an~be
I
piò rettoli
~ nttor1
d1
quei tre paesi.
Scnut nessun dubbio
il tradur–
re può giovare
ad
una lcltcratu-
:1~,t= e
~i!T't1:e11~~~!~e
ila!~=
:i~:s!:
~=~~.d~~
n~
~ lo traducendo
il
Viaggio
un –
hnmdale
tkllo
Sterne.
Egli
com–
pr~
e fttecomprentleR
la ca–
pacità
e.bea,·eva b
noetra
lin~
~ne
di csprimfl'Si con piò fona
d'n rtc fuori
tlagli , c11emi latini
t<\
acc:adcmki. Ma Ojit"gipurtro p–
po, salvo
rare e«"Cz.toni, le ,·er–
sioni dagli sc.rittori americani in–
glesi
e
francesi
$Cntbnno
fatte:
per corrompere
la nostra
lettcra-
1•1rn;
non
~1
tttta
il \"OC:tbolo ita–
liano che
corrisponda
•
quello
11trnniero,
e che
in quella
c<:rt..
'l
C'nlloc."11.ione nel f>('riodo nel w r-
110ci dia il tono tlcll'origina le, e
nemmeno una sintassi e una me-–
trica corrispo11dcuti a quclk: del
t.csto:
•i
ttndc
il
fn.ncnc
con
francesismi,
l'americano
in un
inoompr c:sibile
slogan
che
l
lo
sl~f 0 "~~du~t~ri.
prim.in,ente
•~va
tradotto dal
grtt0
e dal
latino, pensava che a ben tradur–
re fOflsc necessario
conscrv:r.rcil
carattere e
lo
stile a
ltrui comesc
lo stca&o autore forestiero
scri–
vesse
i11
italiano:
lingua,
egli
di–
ctva , • suscettibil e di tutti
~li
sti–
li •·.
E~a ~rs uaso che per thvc11ta•
re rns1gm
traduttori
bisogna..uc
~sere
• bravi scrittori • ma <"hc a
dl\·c
ntor 1oCri
ttori
insigni giovu–
se.
l
'de.rc:izio del tradurre che fa
n1cg
lio conQ6Cerc, non
già le
for–
me ~tteraric
eonsacnte, ma
L'I
~pac1~
<ldla nostra
linJUa
di
p_1cga"!1. in sempre
nuovi
nessi
••n~t~m ••Un grande
filOl'Ofo di
~g1,
1!
\\•11,
rtbur_g, in un
,mo
prc--
7.JOSO
l1br~Uo, dimostra elle
l'ita–
liano
è •
m uno sla to
di cre:uionc
~r-ma.ncntc •• può M'guire
col
suo nt mo e
con
la
sua melodia
i
d.h~rsi moti «kll'anim a di chi
scrive;
h_a uru
straordinaria.
ric–
c.~zza .d1 forme, di derivazioni,
d1
frMt
che
tt:ndono le piò lievi
sfumRlJ!re _del sent imento.
E'
tra–
smutab ile
.in
~illc
guise, mentre,
ad ~e mpio, d
fran~,
lingua
r;~:~!~~t:
er!:c!t';;
:i~t!~ft~f~a
d1\-~n11tà
™;lle
forme
~ammati–
cah
alla
.ch1nr~
logie.a
e quasi
tt?-3lcmahca
de1costrutt i e del lc.1l–
•1co e non può trovare forme ror–
rispondcnti
a quelle di
lin~
meno
astra tte.
La
ai~nora
di
StaCI ci
ammoniva di • 5tuordar–
ci da11'usanu
franccs,c di tna.smu-
















