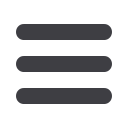
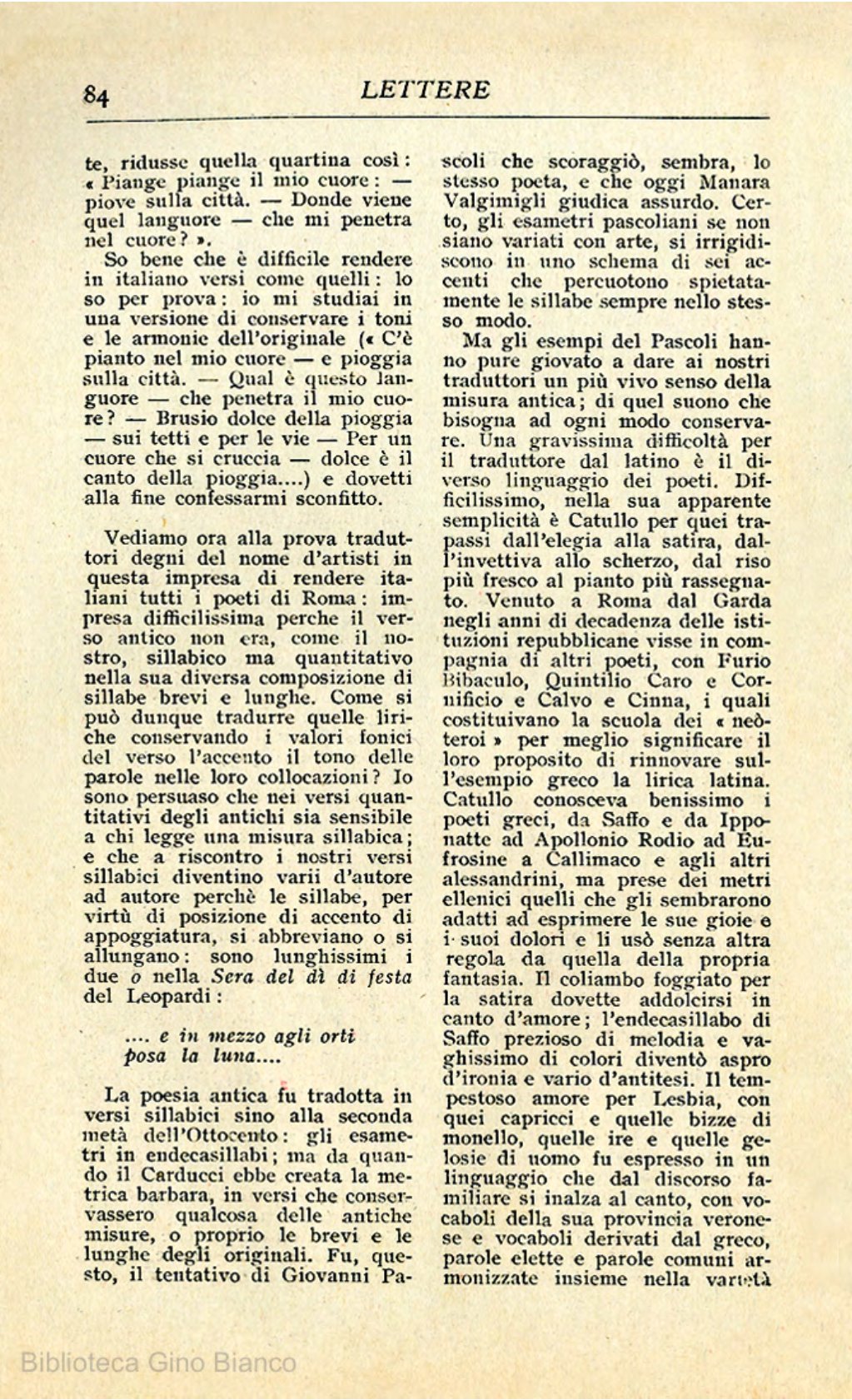
LE J"TERE
tt,
ridusse. quel~
qu:1rtì11a
cosi:
;,i~!~
11
~~1/~
1
~if~.
11 ~
11
tio~1d':~ic;;
quel
lauguore
-
che mi penetra
nel cuore? •·
So
bene che
i:
difficile rendere
in italiano
,·cn;i come
c1uelli:
lo
so per pro,·a:
io mi studiai
in
una ,·ersione
di
con:.erva re
i
toni
e le armonie dell
'origino.le(• C'è
pi3nto nel mio c
uore - epioggia
~~!!e
c~\1;;
1~::::
,i
il'
1~:ti
~~;
re? -
Brusio dolce della pioggia
-
sui tett i e per le vie -
Per un
cuore che si cruccia -
dolce
è
il
~~Ì:-tofi~:
1
~nf~~-i--~~~
1fitf;~tti
Vediamo ora alla prova tradut–
tori degni del nome d' artisti
in
questa
impresa
di
rendere
ita–
hani
tutti
i poeti
di Roma:
im–
presa difficilissima
pcrche
il ,·cr–
so m1lico non
<'f:-t,
come
il
no–
stro,
sillabico ma
quan tit ativo
nella sua diversa coru1>03i1donedi
si11nbe bre,•i e lunghe. Come si
r~:
~l~~~:a!~odurr~-a1~ri
ll~o i~i
del verso
l'atte:ito
il tono delle
parole nelle loro collocazioni?
Io
sono persuaso d1e nei \'e~i quan–
titath•i degli antichi sia sensibile
:,,chi legge una misura sillnbk a;
e clic a riscontro
i
nostri \'ersi
sillab ici dl\•cntino
,·Mii d'a utore
ad autore perd1è
le sillabe, per
virtt'l di posizione di ac,c,cnto di
:ri~r:~~r.,~!~
:,
~ ~~i:st~
s:
due o nella
Sera
dd dl
di festa
del Leopardi:
....
e
fo
me::o
agli
orti.
posa
la
lum:1 •.,.
La poesia antica
fu
tradotta
in
versi silfo.bici sino alla
sewnda
metà dcll'OttOCt-nlo:
gli esame–
tri in cndcc:asillabi:
111:,.
da quan–
do il Carducci ebbe creata la me–
trica barbara,
in vcf!òi
cbe consci"•
,•assero
qualcosa
dell
e antiche
Ì::;h~•
d~gf[°~
~;iu1
!1i.bl":::
:u~~
llt0, il tcntafo ·o di Giovanni Pa-
!~~~o
c~~~~~a~~~
1\gs;:n:
r:;1a:
~
Valgim,gli
giudica asstll"do,
Ccl"•
to, gli es::unctl"i pascoliani se
11011
siano Yi1dati
con
arte,
si
irriJCidi–
seono
in
11110
schema di
~1
:,c–
ceuti
che
percuotono
spict:ita–
mentc le ~illabe sempre nello
stes–
so
modo.
M:i
gli e5empi del Pascoli han•
:it!:::~
~rf~~~~~ì
~-i~·~r:c~~
n~:~
misura antica; di
quel
suono che
bisogna ad
<>Jlli
modo conserva–
re. Uua grav1ss inrn.
diffic<>ltà
per
il
traduttore
d:il
lat11lo
è
il di–
verso
linguaggio
dei poeti. Dif–
ficilissimo,
nella
sua
apparente
semplicità
!
Catu llo
per
9uci tra-
~~t~~!'e~W~a
:~~~~t~bi ~!~
pitì
frCKO al
pianto più
na.~scgna–
to. V.:nuto
a Roma dal Garda
negli anni di decadenza delle isti–
t111,io11
i repubblicane
\'isse
in com-
J~f,f~~it~1;~1
Q~1\~!t
if::
1
~a~n e
Fc~ìi
nificio e Cah-o e Cinna,
ì
quali
costituivano
la scuola dei •
n~
tcroi • per meglio
significare
il
loro proposito
di
rinnovare
sul–
l'cscmpio
vero
la
lirica
fatina.
Catullo
con05ce,-a
benissimo
i
poeti greci, da Saffo e da Ippo-
f~~l~1~"da
'~':Uf.:~~
R i:g1r
11~\~
alcs!\auclrini, ma prese dei metri
ellenici quell i che gli sembrar ono
ad:itti ad esprime re le sue gioie e
i•
suoi dolon e li usò senza altra
regola
da
quella
della propria
fantasfa.
n
roliambo fogg-iato per
la
satira
do\'ette
addolcirl'i
in
canto d'11more; l'c11dccasìllabo dì
Saffo prezioso di melodfa e va-
~~~~~:~0e
<!.~rio
1
d~~1 ~~!~~c\1~
pestoso
amore per
J..csbia,
con
quei
capricci
e quelle
bir.1.c di
monello, quelle ire e quelle ge–
losie di uomo
fu
espr~,o
in un
linguaggio
che dal
cliscot"!'O
fa.
miliare 11i inah.a al canto, con vo–
caboli della sua provin cfa. ,·cronc–
se e Yocaboli derivati
d.,I greco,
parole elette e parole comuni
11r–
mo11iz1.alc insieme nclfa
\'.lrt•:ll.
















