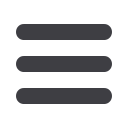
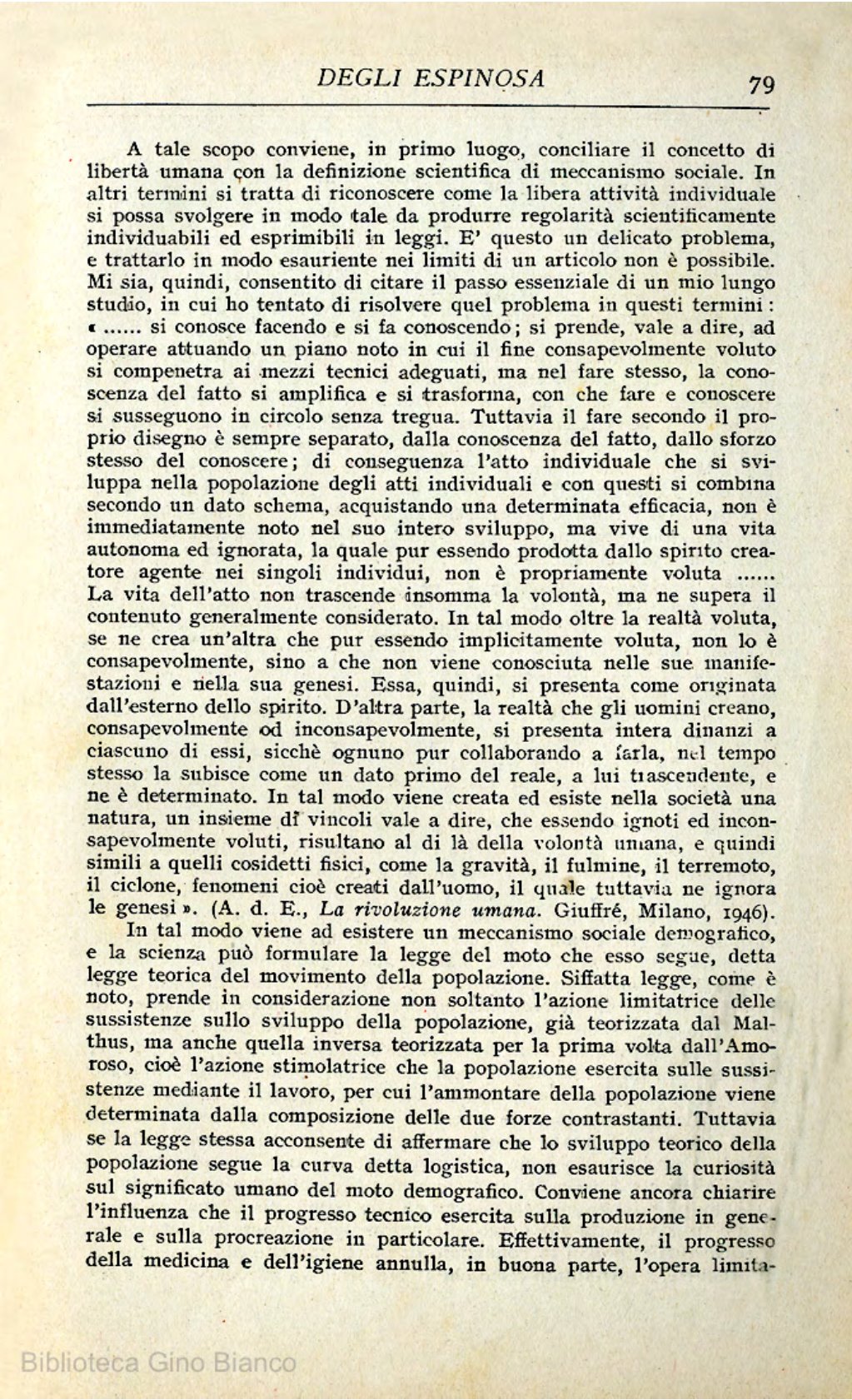
DEGLI ESPINOSA
79
A tale scopo conviene, in
Primo
luo go, conciliare
il
concet to di
· libertà umana çon la definizione scienlifica di mecranismo sociale. In
altri termini si tratta
di
riconoscere come la libera attività individuale
si possa svolgere in modo tale da produrre regolarità scientificamente
individu abil i ed esprimibili in leggi. E' questo un delicato problema,
e trattarlo in modo esauriente nei limiti di un art icolo non
è
possibile .
Mi
sia,
quindi, consentito di citar e il passo essenziale di un mio lungo
studio, in cui ho trntato di riM>lvcre quel problema in questi term ini:
• ...... si conosce facendo e si
fa
conoscendo; si prende, vale a dire, ad
operar e attuando un piano noto in cui
il
fine consapevolmente voluto
si compenetra ai .mezzi tecnici adegua ti, ma ne1 fare stesso, la cono–
scenza del fatto si amplifica e si trai.fonn a, con che fare e conOSC<:r(:
si susseguono in circolo senza tregua. Tuttavia
il
fare secondo
il
pro–
prio disegno
è
sempre separato, dalla conoscenza del fatto, dallo sforzo
stesso del conoscere; di rouscguenza l'atto individuale che si svi–
luppa nella popola1.ionc degli atti indivi duali e con questi si combma
secondo un dato schema, acquistando una determinata dficacia, non
è
immediatamente noto nel suo intero sviluppo , ma vive di una vita
autonoma
ed
ignorata, la quale pur essendo prodotta dallo spinto crea–
tore agente nei siugoli indi\·idui , non
è
propriament e voluta ....
La vita dell'atto non trascende insomma
la
volontà, ma ne supera
il
contenuto generalmente considera to. In tal mocJooltre la realtà. voluta,
se ne crea. un'altra che pur essendo impl icitamente voluta, non Io
è
consapevolmente , sino a che non viene conosciuta nelle sue manifc–
st.uioni e tiella sua genesi. Essa, quindi, si presenta come on;,!inata
dall'esterno dello spirito . D'altra parte, la realtà che gli uomini creano,
consapevolmente
od
inconsapevolmente, si presenta intera di11anzi a
ciascuno di essi, sicchè ognuno pur collaborando a farla, nd tempo
stesso la subisce come un dato primo del reale, a lui tla.S(em!eutc, e
ne
è
determinato. In tal modo viene creata
ed
esiste nella società una
natura, un insieme df vincoli vale a dire, che essendo ignoti
e<l
incoo–
sapevohnen te volut i,
risu.lt.'lno al di là della n,lontà
11111nnn,
e quimli
simili a quelli cosidetti fisici, come la gravità,
il
fulmine,
il
terremoto ,
il
ciclone, fenomeni cioè creati dall'uomo, il (1.11.lle tutt avia ne ignora
le genesi •· (A. d. E.,
La rfvoluzione umana .
Giuflré, Milano, 1946).
In tal modo viene ad esistere
1111
meccanismo sociale demografico,
e
la
scicn1,,_'l può formulare
la
legge del moto che esso segac, detta
legge teorica del movimento della popolazione. Siffatta legge, comt:"
è
noto, prende in considerazione non soltanto l'a zione limitatrice delle
suss istenze sullo sviluppo della J)Opolazione, già teorizzata dal Mal–
th us, ma anche quella inversa teorizzata per la prima volta dall'A mo–
roso, cioè l'a zione stirp.olatrice che la popola1.ione esercita sulle sussi–
stenze mediante il lavoro, per cui l'ammontare della popolazione viene
determinata dalla composizione delle due forze contrastanti. Tuttav ia
se la legge stessa acconsente di affermare che lo sviluppo teorico de.Ila
popolazione segue la curva detta logistica, non esaurisce
L'l
curio,;ità
sul significato umano del moto demografico. Conv,iene ancora chiarire
l'infl uenza che
il
progresso tecnico esercita sulla produ1.ione in gen<>–
rale e sulla procreazione iu particolare. Effettivamente, il progrcs.c:o
della medicina e dell'igiene annulla, in buona parte, l'opera
lim1t:,-
















