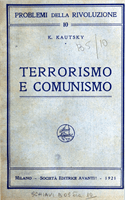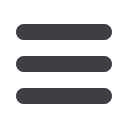
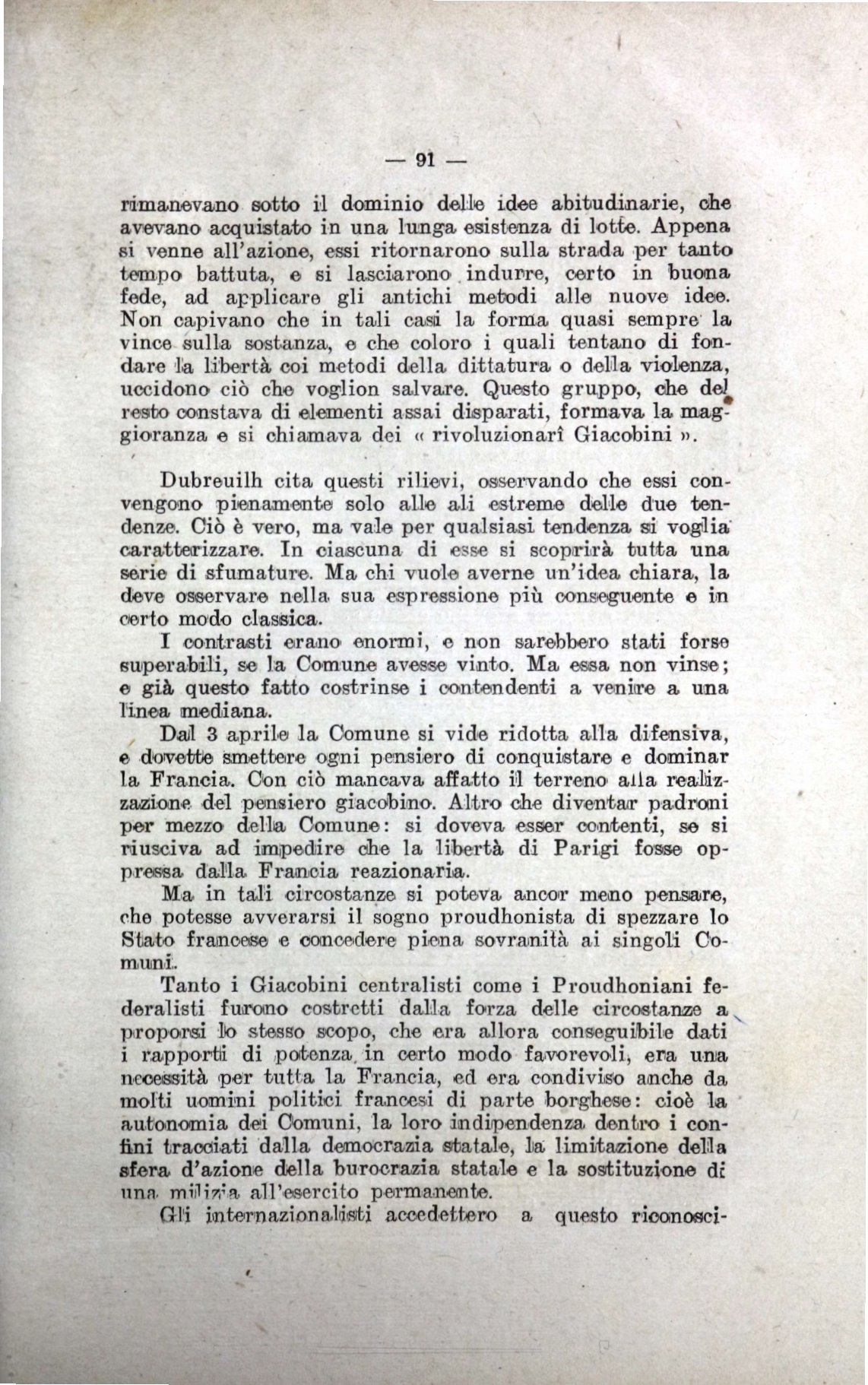
rimanevano sotto i l dominio delle idee abitudinarie, che
avevano acquistato in una lunga esistenza di lotte. Appena
si venne all'azione, essi ritornarono sulla strada per tanto
tempo battuta, e s i lasciarono indurre, certo i n buona
fede, a d applicare g l i ant ichi metodi a l l e nuove idee.
Non capivano che i n t a l i casi l a forma quasi sempre l a
vince sulla sostanza, e che coloro i quash tentano d i fon-
dare la libertà coi metodi della dittatura o della violenza,
uccidono cif?) che voglion salvare. Questo gruppo, che del
resto constava di elementi assai disparati, formava la mag-
gioranza e si chiamava dei «rivoluzionari Giacobini ».
Dubreuilh ci ta questi r i l ievi , osservando che essi con-
vengono pienamente solo al le al i estreme dielle due ten-
denze. Ciò è vero, ma vale per qualsiasi tendenza si voglia
caratterizzare. I n ciascuna d i esse si scoprirk tut ta una
serie di sfumature. Ma chi vuole averne un'idea chiara, la
deve oseervare nella sua espressione più conseguente e i n
certo modo classics.
I contrasti erano enormi, e non sarebbero stati forse
superabili, se la Comune avesse vinto. Ma essa non vinse;
e già questo fatto costrinse i contendenti a venire a una
linea mediana.
Dal 3 aprile la Comune si vide ridotta al la difensiva,
e dovette smettere ogni pensiero di conquistare e dominar
la Francia. Con ebb mancava affatto i l terreno alla realäz-
zazione del pensiero giacobino. Al t ro che diventair padroni
per mezzo della Comune: s i doveva esser contenti,
se
si
riusciva ad impedire che l a libertà, d i Par igi fosse op-
pressa dal la Francia reazionaria.
Ma in tal i circostanze si poteva armor meno pensare,
che potesse avverarsi i l sogno proudhonista di spezzare lo
Stato franose e concedere plena sovranità a i singoll Co-
Tanto i Giacobini centralisti come i Proudhoniani fe-
deralisti forano costretti dal la forza delle circostanze a ,
proporsi M stesse scopo, che era al lora conseguibile dat i
i rapport-ti d i potenza, in certo modo favorevoli, era una
necessia per tut ta la Francia, ed era condivise anche da
molti uomini pol i t ici francesi d i parte borghese: cioè l a
autonomia dei Comuni, l a loro indipendenza dentro i con-
fini traociiati *dalla democrazia statale, la limitazione della
sfera d'azione della burocrazia statale e la sostituzione di
una, m idi &a all'esercito permanente.
Gli internazionalisti accedettero a questo riconosci-