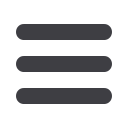
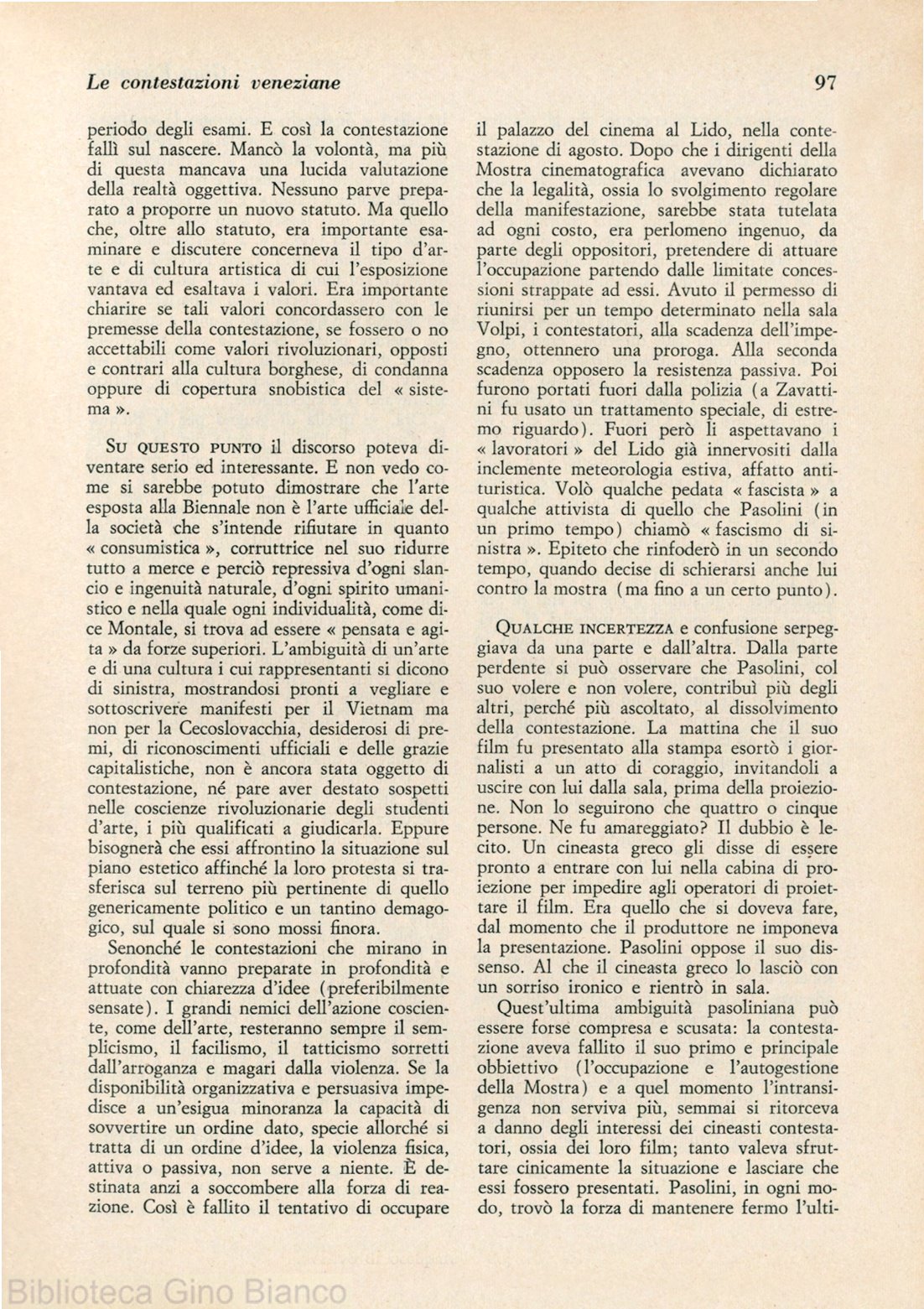
Le contestazio,,.i veneziane
periodo degli esami. E cosl la contestazione
falli sul nascere. Mancò la volontà, ma più
di questa mancava una lucida valutazione
della realtà oggettiva . Nessuno parve prepa–
rato a proporre un nuovo statuto. Ma quello
che, oltre allo statuto, era importante esa–
minare e discutere concerneva
il
tipo d'ar–
te e di cultura artistica di cui l'esposizione
vantava ed esaltava i valori. Era importante
chiarire se tali valori concordassero con le
premesse della contestazione, se fossero o no
accettabili come valori rivoluzionar i, opposti
e contrari alla cultu ra borghese, di condanna
oppure di copertura snobistica del
«
siste–
ma».
Su QUESTOPUNTOil discorso poteva di–
ventare serio ed interessa nte. E non vedo co–
me si sarebbe potuto dimostrare che l'arte
esposta alla Biennale non
è
l'arte ufficiale del–
la società che s'inte nde rifiutare in quanto
«
consumistica
»,
corruttrice nel suo ridurre
tutto a merce e perciò repressiva d'ogni slan–
cio e ingenuità naturale, d'ogni spirito umani–
stico e nella quale ogni individualità, come di–
ce Monta le, si trova ad essere
«
pensata e agi–
ta
»
da forze superiori. L'ambiguità di un'arte
e di una cultura i cui rappresentanti si dicono
di sinist ra, mostrandos i pronti a vegliare e
sottoscriveie manifesti per
il
Viet nam ma
non per la Cecoslovacchia, desiderosi di pre–
mi, di riconoscimenti ufficiali e delle grazie
capitalistiche, non
è
ancora stata oggetto di
contestazione, né pare aver destato sospetti
nelle coscienze rivoluz ionarie degli studenti
d'arte, i più qualificaù a giudicarla. Eppure
bisognerà che essi affrontino la situazione sul
piano estetico affinché la loro protesta si tra–
sferisca sul terreno più pertinente di quello
genericamente politico e un tantino demago–
gico,
sul
quale si sono mossi fìnora .
Senonché le contesrazioni che mirano in
profondità vanno preparate in profondità e
attuate con chiarezza d'idee (preferibilmente
sensate) . I grandi nemici dell'azione coscien–
te, come dell'arte, resterann o sempre
il
sem–
plicismo,
il
facilismo, il tatti cismo sorrett i
dall'arroganza e magari dalla violenza . Se la
disponibilità organizzativa e persuasiva impe–
disce a un'esigua minoranza la capacità di
sovvertire un ordine dato, specie allorché si
tratta
di
un ordine d'idee, la violenza fisica,
attiva o passiva, non serve a niente.
È
de–
stinata anzi a soccombere alla forza di rea–
zione. Cosl
è
fallito il tentativo di occupare
97
il palazzo del cinema al Lido, nella conte–
stazione di agosto. Dopo che i dirigenti della
Mostra cinematografica avevano dichiarato
che la legalità, ossia Io svolgimento regolare
della manifestazione, sarebbe stata tutelata
ad ogni costo, era perlomeno ingenuo, da
parte degli oppositori, pretendere di attuare
l'occupazione partendo dalle limitate conces–
sioni strappate ad essi. Avuto
il
permesso di
riunirsi per un tempo determinato nella sala
Volpi, i contestatori, alla scadenza dell'impe–
gno, ottennero una proroga . Alla seconda
scadenza opposero la resistenza passiva. Poi
furono portati fuori dalla polizia (a Zavatti–
ni
fu
usato un trattamento speciale, di estre–
mo riguardo). Fuori però
li
aspettavano i
«
lavoratori
»
del Lido già innervositi dalla
indemente meteorologia estiva, affatto anci–
turistica. Volò qualche pedata
«
fascista
»
a
qualche attivista di quello che Pasolini ( in
un primo tempo) chiamò
«
fascismo di si–
nistra
».
Epiteto che rinfoderò in un secondo
tempo, quando decise
di
schierarsi anche lui
contro la mostra (ma fino a un certo punto).
QUALCHE INCERTEZZA e confusione serpeg–
giava da una parte e dall'altra. Dalla parte
perdente si può osservare che Pasolini, col
suo volere e non volere, contribul più degli
altri, perché più ascoltato, al dissolvimento
della contestaz ione. La mattina che
il
suo
film
fu
presentato alla stampa esortò i gior–
nalisti a un atto di coraggio, invitandoli a
uscire con lui dalla sala, prima della proiezio–
ne. Non lo seguirono che quattro o cinque
persone. Ne fu amareggiato? Il dubbio
è
le–
cito . Un cineasta greco gli disse di es~ere
pronto a entrare con lui nella cabina di pro–
iezione per impedire agli operatoti di proiet–
tare il film. Era quello che si doveva fare,
dal momento che
il
produttore ne imponeva
la presentazione. Pasolini oppose
il
suo dis–
senso. Al che il cineasta greco lo lasciò con
un sorriso ironico e rientrò in sala.
Quest'ultima ambiguità pasoliniana può
essere forse compresa e scusata: la contesta–
zione aveva fallito
il
suo primo e principale
obbiettivo (l'occupazione e l'autogestione
della Mostra) e a quel momento l'intransi–
genza non serviva più, semmai si ritorceva
a danno degli interessi dei cineasti contesta–
tori, ossia dei loro film; tanto valeva sfrut–
tare cinicamente la situazione e lasciare che
essi fossero presentati. Pasolini, in ogni mo–
do, trovò la forza di mantenere fermo l'u!ti-
















