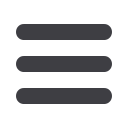

96
a prestarsi alle critiche e alle proteste
1
che
cosa resterà da contestarle? Evidentemente
i
risultat i che darà nelle varie discipline . -Il
guaio
è
che allora tali risuJtati dipenderanno
in gran parte da uno statuto non più inerte
e trascurabile, al contrario attuale e vinco–
lante. Sarà molto più difficile da parte degli
artisti e dei cineasti parlare ancora di
«
au–
togestione
»,
di
«
occupazione pacifica
»,
di
«
assemblea costituente», invocando la
rifor–
ma
di
struttu re
già
riformate grazie appunto
alle contestazioni di giugno e di agosto. Per–
ché, se non
è
certo,
è
verosim ile e probabi le
che se ne terrà conto anche se hanno dato
spettacoli ambigui e penosi, e prodotto ef–
fetti tutt'altro che concludenti; essendo sta–
te, anzi, un vero fallimento.
LA CONTESTAZIONE di giugno alla Bienna–
le d'arte
falli
non tanto per lo spiegamento
delle forze di polizia, senz'altr o abnor me, ma
per la mancanza di chiarezza di chi protesta–
va (artisti, studenti delJ'Accademia e di archi–
tettura). Il loro discorso era essenzialmente
politico ma con argomenti deboli. Volevano
impossessarsi della Biennale, considerata dai
giovani rivoluzionari una delle « malattie del
capitalismo
». (
Gli artisti che parlano di po–
litica sarebbe bene non starli a sentire. La po–
litica
è
un'arte o una scienza che non tollera
candori e ingenuità. Neppure quelli ~ a livello
utopistico, dei pensatori della nuova sinistra
come Marcuse. Basta leggere la sua recente
«
prefazione politica
»
a
Eros e civiltà
per
rendersi conto come del senso politico lo scrit–
tore mostri di avere una nozione alquanto im–
propria). Contestare la Biennale in quanto
istituzione del sistema borghese sarebbe sta–
to un attegg iamento abbastanza chiaro se
portato razionalmente e coerentemente fino
in fondo. Si fermò invece a metà strada e
qui si confuse con un'altra questione, quella
della polizia mobilitata dall'auto rità per im–
pedire eventuali danni soprattutto ai padi–
glioni ester i, e quindi il sorgere di incident i
diplomatici. La presenza dei poliziotti ai Giar–
dini suscitò l'indignaiionc di molti art isti,
in piccola parte anche stranieri ,
i
quali stac–
carono i loro quadri dalle pareti, li appog–
giarono rivoltati ai piedi dei muri, coprirono
le loro sculture con carta d'imballaggio , sbar–
rarono l'ingres so alle sale d'esposizion e, ap–
pesero cartelli con scritte come : « Via la
polizia
»,
« Polizia fascista
»,
«
Non accettia–
mo di esporre in queste condizioni
»
eccetera.
Gino Visentini
La protesta contro la polizia, comincia–
ta all'interno della Biennale
il
primo giorno
della «vernice», si estese due giorn i dopo in
piazza san Marco, dove per tutto un pome–
riggio, fino a notte alta, si assisté a uno stra–
no balletto che si potrebbe chiamar e
«
della
fisarmonica ».
I
poliziotti stavano sotto
iJ
portico delle Procuratie nuove , tra il cam–
panile e il caffè Florian.
I
dimosttanti , un
gruppo comprendente artisti rifiutati dalla
Biennale , studenti anarchici e maoisti, attivi–
sti di partito, stavano di fronte ad essi dal–
l'altra parte della piazza. Avanzando prude n–
temente di un passo alla volta, agitavano il
braccio col pugno chiuso gridando e iteran–
do
slogans
di dileggio e di sfida. Quando
la distanza tra dimostranti e poliziotti si ac–
corciava (a opinfone
di
questi) un po' trop–
po, i poliziotti scendevano i gradini del por–
tico e si schieravano sulla piazza. A questo
semplice movimento di reazione, i dimo–
stranti arre travano precipitos amente . Ma po–
co dopo si ricomponevano e ricominciavano
ad avanzare rincarando la dose delle invetti–
ve. Fino a che, giudicando eccessive le pro–
vocazioni, I'ufficiaJe che comandava il ploto–
ne dava l'ordine di caricare. E allora i po–
liziotti
si
scatenavano alla caccia dei dimo–
stranti , che prendevano la fuga in ogni di–
rezione e cercavano di salvarsi disperdendosi
nell'intrico delle calli. Passava un po' di
tempo, tornava la calma. Poi il balletto ri–
prendeva da capo. S'andò avanti così per
ore e ore. Naturalmente le orchestrine del
Florian e del Quadri tacevano, i negozi ave–
vano abbassato le serrande e ]a piazza s'era
trasfortl)ata in un'arena . Segnarono la fine
dello spettaco lo i dodici rintocchi battuti dai
Mori sulla campana delJ'Orologio. Era du–
rato anche troppo e non era stato neppure
divertente.
La contestazione aveva deviato nella pro–
testa di piazza contro la polizia, sospendendo
il giudizio sul motivo di fondo: la Biennale
come istituto d'una cultura borgh ese, stru–
mentalizzata dal sistema capitalistico. Non era
possibile occupare
i
padiglioni , ma avviare un
dibattito fuori dei Giardini , ad esempio al–
l'Accademia di belJe arti, bloccata dagli stu–
denti che la occupavano da mesi, era invece
possibilissimo. L'impressione che gli studen–
ti fossero delusi dalle piazzate non tardò
ad apparire chiara. E tuttavia, invece di or–
ganizzare una discussione contestativa, pochi
giorn i dopo tolsero il blocco. Era venuto
il
















