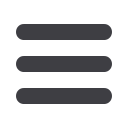
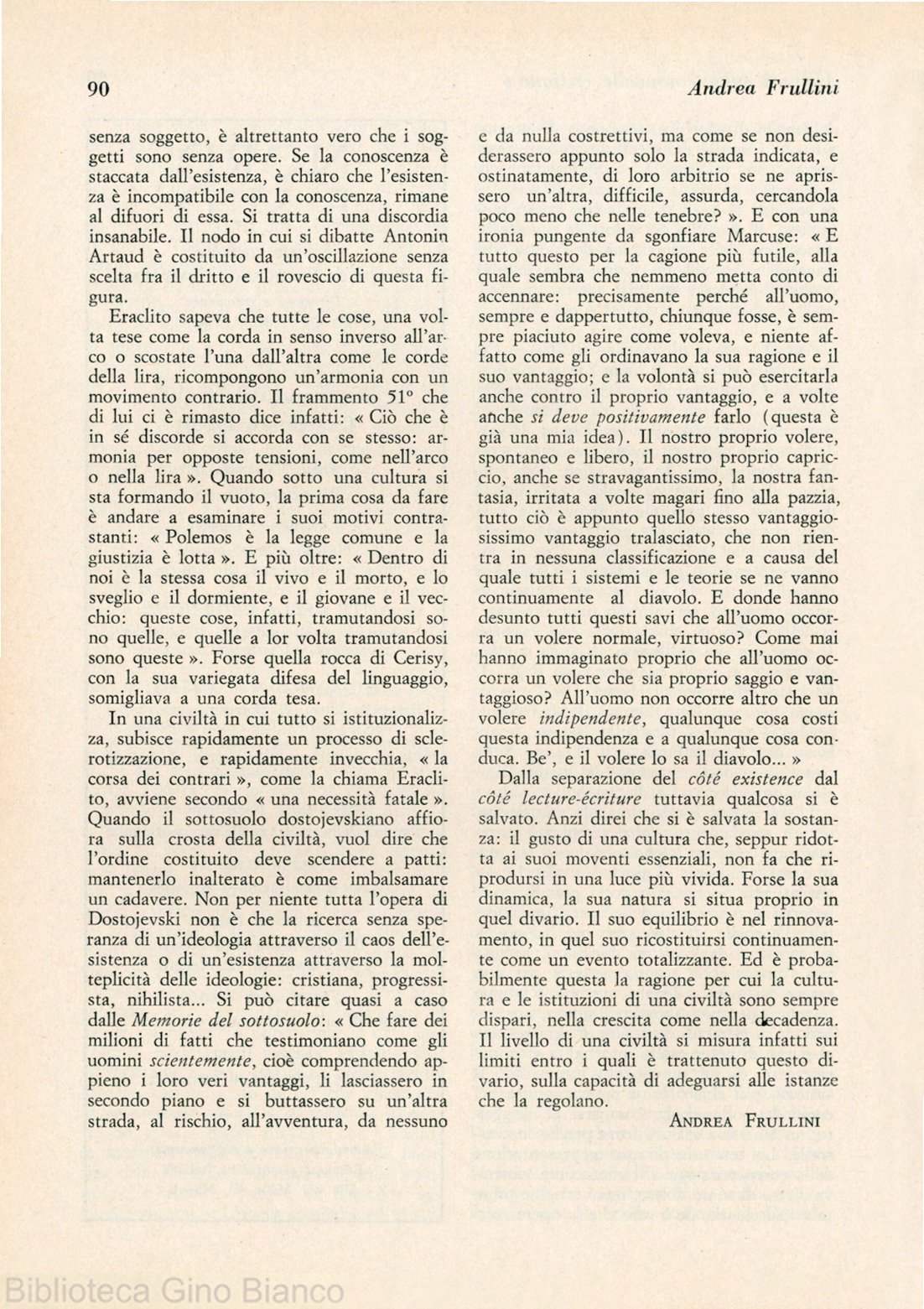
90
senza soggetto,
è
altrettanto vero che
i
sog–
getti sono senza opere. Se la conoscenza
è
staccata dall'esistenza,
è
chiaro che l'esisten–
za
è
incompatibile con la conoscenza, rimane
al difuori di essa. Si tratta di una discordia
insanabile. Il nodo in cui si dibatte Antoni~
Artaud
è
costituito da un'oscillazione senza
scelta fra il dritto e il rovesc io di questa fi–
gura.
Eraclito sapeva che tutte le cose, una vol–
ta tese come la corda in senso inverso all'ar –
co o scosta te l'una dall'altra come le corde
della lira, ricompo ngono un'armonia con un
movimento contrario.
Il
frammento
51°
che
di lui ci
è
rimasto dice infatti:
«
Ciò che
è
in sé discorde si accorda con se stesso: ar–
monia per opposte tensioni, come nell'arco
o nella lira ». Quando sotto una cultura si
sta formando il vuoto, la prima cosa da fare
è
andare a esaminare
i
suoi motivi contra–
stanti:
«
Polemos
è
la legge comune e la
giustizia
è
lotta
».
E più oltre:
«
Dentro di
noi
è
la stessa cosa il vivo e
il
morto, e Io
sveglio e il dormient e, e
il
giovane e il vec–
chio: queste cose, infatti, tramutandosi so–
no quelle , e quelle a lor volta tramutand osi
sono queste
».
Forse que lla rocca di Cer isy,
con la sua variegata difesa del linguaggio,
somigliava a una corda tesa.
In una civiltà in cui tutto si istituzionaJiz–
za, subisce rapidamente un processo di scle–
roti zzazione, e rapidamente invecchia,
«
la
corsa dei contrari
»,
come la chiama Eracli–
to, avviene secondo
«
una necessità fatale
».
Quando il sottosuo lo dostojevskiano affio–
ra sulla crosta della civiltà, vuol dire che
l'ordin e costi tuito deve scendere a patti :
mantenerlo inalterato
è
come imbalsamare
un cadavere. Non per niente tutta l'opera di
Doscojevski non
è
che la ricerca senza spe–
ranza di un'ideologia attraverso
il
caos dell'e–
sistenza o di un'esistenza attraverso la mol–
tep licità delle ideologie : cristiana, progressi–
sta, nihi.lista.. Si può citare quasi a caso
dalle
Memorie del sottosuolo:
«
Che fare dei
milioni di fatti che testimoniano come gli
uomini
scie11teme11te,
cioè comprendendo ap–
pieno
i
loro veri vantaggi,
li
lasciassero in
secondo piano e si butta ssero su un'altra
strada, al rischio, all'avventura, da nessuno
And rea Frullini
e da nulla costrettivi, ma come se non desi–
derassero appunto solo la strada indicata, e
ostinatamente, di loro arbitrio se ne apris–
sero un 'altra , difficile , assurda , cercandola
poco meno che
nel.letenebre?
».
E con una
ironia pungente da sgonfiare Marcuse:
«
E
tutto questo per la cagione più futile , alla
quale sembra che nemmeno metta conto di
accennare : precisamente perché all'uomo,
sempre e dappertutto, chiunque fosse, è sem–
pre piaciuto agire come voleva, e niente af–
fatto come gli ordinavano la sua ragion e e
il
suo vantaggio; e la volontà si può esercitarla
anche contro il proprio vantaggio , e a volte
anche
si deve positivamente
farlo (questa
è
già una mia idea). Il nostro proprio volere,
spontaneo e libero, il nostro proprio capric–
cio, anche se stravagantissimo, la nostra fan–
tasia, irritata a volte magari fino alla pazzia,
rutto ciò
è
appunto quello stesso vantaggio–
sissimo vantaggio tralasciato , che non rien–
tra in nessuna classificazione e a causa del
quale tutti i sistem i e le teorie se ne vanno
continuam ente al diavolo. E donde hanno
desunto tutti questi savi che all'uomo occor–
ra un volere normale, virtuoso? Come mai
hanno immaginato proprio che all'uomo oc–
corra un volere che sia propr io saggio e van–
taggioso? All'uomo non occorre altro che un
volere
indipendente,
qualunqu e cosa costi
questa indipendenza e a qualunque cosa con –
duca. Be' , e il volere lo sa il diavolo ...
»
Dalla separazio ne del
c6té existe11ce
dal
c6té lecture-écriture
tuttavia qualcosa si
è
salvato . Anzi direi che si
è
salvata la sostan–
za: il gusto di una cultu ra che, seppur ridot–
ra ai suoi moventi essenziali, non
fa
che
ri–
produr si in una luce più vivida . Forse la sua
dinamica, la sua natura si situa proprio in
quel divario. Il suo equilibrio
è
nel rinnova–
mento , in quel suo ricostituir si continuamen–
te come un evento totalizzante. Ed
è
proba–
bilmente questa
la
ragione per cui la cultu–
ra e le ist ituzioni di una civiltà sono sempre
dispar i, nella crescita come nella decadenza.
Il livello di una civiltà si misura infatti sui
limiti enrro i qual i
è
tratt enuto questo di–
vario, sulla capacità di adeguarsi alle istanze
che la regolano.
ANDREA FRULLINI
















