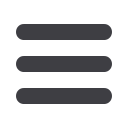
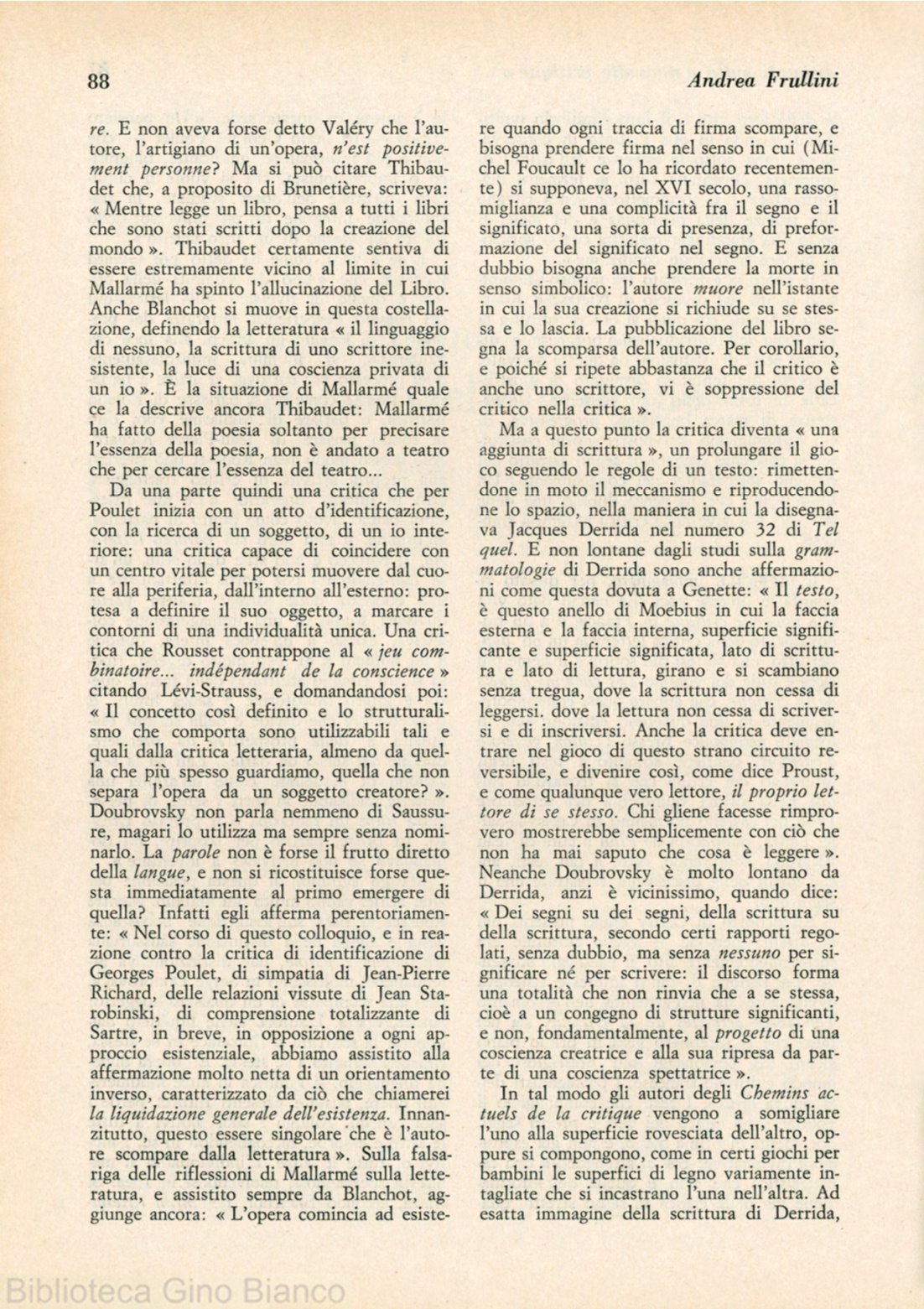
88
re.
E non aveva forse detto Valéry che l'au–
tore, l'artigiano
di
un'opera,
n'est positive–
meni personne?
Ma si può citare Thibau–
det che, a proposito di Brunetière, scriveva :
«
Mentre legge un libro, pensa a tutti i libri
che sono stati scritti dopo la creazione del
mondo
».
Thibaudet certame nte sentiva di
essere estremamente vicino al limite in cui
Mallarmé ha spinto l'allucinazione del Libro.
Anche Blanchot si muove in questa costella–
zione, definendo la letteratura
«
il
linguaggio
di
nessuno,
la serittura di uno scrittore ine–
sistente, la
luce
di una coscienza privata di
un io
». È
la situazione di Mallarmé quale
ce la descrive ancora Thibaudet: Mallarmé
ha fatto della poesia soltanto per precisare
l'essenza della poesia, non
è
andato a teatro
che per cercare l'essenza del teatro ...
Da una parte quindi una critica che per
Poulet inizia con un atto d'identificazione,
con
1a
ricerca
di
un soggetto,
di
un io inte–
riore : una critica capace
di
coincidere con
un centro vitale per potersi muovere dal cuo–
re alla periferia, dall'interno all'esterno: pro–
tesa a definire
il
suo oggetto, a marcare i
contorn i di una individualità unica. Una cri–
tica che Rousset contrappone al
«
jeu com–
binatoire.. indépendant de la conscience
»
citando Lévi-Strauss, e domandandosi poi:
«
Il concetto cosl definito e lo strutturali–
smo che comporta sono utilizzabili tali e
quali dalla critica letterar ia, almeno da quel–
la che più spesso guardiamo, quella che non
separa l'opera da un soggetto creatore?».
Doubrovsky non parla nemmeno di Saussu–
re, magari
lo
utilizza ma sempre senza nomi–
narlo. La
parole
non
è
forse il frutto diretto
deUa
langue,
e non si ricostituisce forse que–
sta immediatamente al primo emergere di
quella? Infatti egli afferma perentoriamen–
te:
«
Nel corso di questo colloquio, e in rea–
zione contro la critica di identificazione di
Georges Poulet, di simpatia di Jean-Pierre
Richard, delle relazioni vissute di Jean Sta–
robinski, di comprensio ne totalizzante di
Sartre, in breve, in opposiz ione a ogni ap–
proccio esistenziale, abbiamo assistito alla
affermazione molto netta di un orientamento
inverso, caratterizzato da ciò che chiamerei
la liquidazfone generale dell'esistenza.
Innan–
zitutto, questo essere singolare ·che è l'auto–
re scompare dalla letteratura
».
Sulla falsa–
riga delle riflessioni
cli
Mallarmé sulla lette–
ratura, e assistito sempre da Blanchot, ag–
giunge ancora:
«
L'opera comincia ad esiste-
Andrea Frullini
re quando ogni traccia di firma scompare, e
bisogna prendere firma nel senso in cui (
Mi–
che! Foucault ce lo ha ricordato recentemen–
te) si supponeva, nel XVI secolo, una rasso–
miglianza e una complicità fra
il
segno e
il
significato , una sorta di presenza, di prefor–
mazione del significato nel segno. E senza
dubbio bisogna anche prendere la morte in
senso simbolico: l'autore
muore
nell'istante
in cui la sua creazione si richiude su se stes–
sa e lo lascia. La pubb licazione del libro se–
gna la scomparsa dell'autore . Per corollario,
e poiché si ripete abbastanza che
il
critico
è
anche uno scrittore, vi è soppressione del
critico nella critica
».
Ma a questo punto la critica diventa
«
una
aggiunta di scrittura», un prolungare il gio–
co seguendo le regole di un testo: rimetten–
done in moto il meccanismo e riproducendo–
ne lo spazio, nella maniera in cui la disegna–
va Jacques Derrida nel numero 32 di
Te/
quel.
E non lontane dagli studi sulla
gram–
matologie
di Derrida sono anche affermazio–
ni come questa dovuta a Genette:
«
Il
testo,
è
questo anello di Moebius in cui la faccia
esterna e
la
faccia interna, superficie signifi–
cante e superficie significata, Iato di scrittu–
ra e lato di lettura, girano e si scambiano
senza tregua, dove la scrittura non cessa di
leggersi. dove la lettura non cessa di scriver–
si e di inscriversi. Anche la critica deve en–
trare nel gioco di questo strano circuito re–
versibile, e divenire cosl, come dice Proust,
e come qualunque vero lettore,
il
proprio let•
tare di se stesso.
Chi gliene facesse rimpro–
vero mostrerebbe semplicemente con ciò che
non ha mai saputo che cosa
è
leggere
».
Neanche Doubrovsky
è
molto lontano da
Derrida, anzi è vicinissimo, quando dke :
«
Dei segni su dei segni, della scrittura su
della scrittura, secondo certi rapporti rego•
lati, senza dubbio, ma senza
nessuno
per si–
gnificare né per scrivere:
il
discorso forma
una totalità che non rinvia che a se stessa,
cioè a un congegno di strutture significanti,
e non, fondamentalmente, al
progetto
di una
coscienza creatrice e alla sua ripresa da par–
te di una coscienza spettatrice
».
In tal modo gli autori degli
Chemins ac–
tuels de la critique
vengono a somigliare
l'uno alla superficie rovesciata dell'altro, op–
pure si compongono, come in certi giochi per
bambini le superfic i di legno variamente in–
tagliate che si incastrano l'una nell'altra. Ad
esatta immagine della scrittura di Derrida,
















