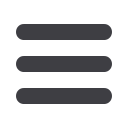
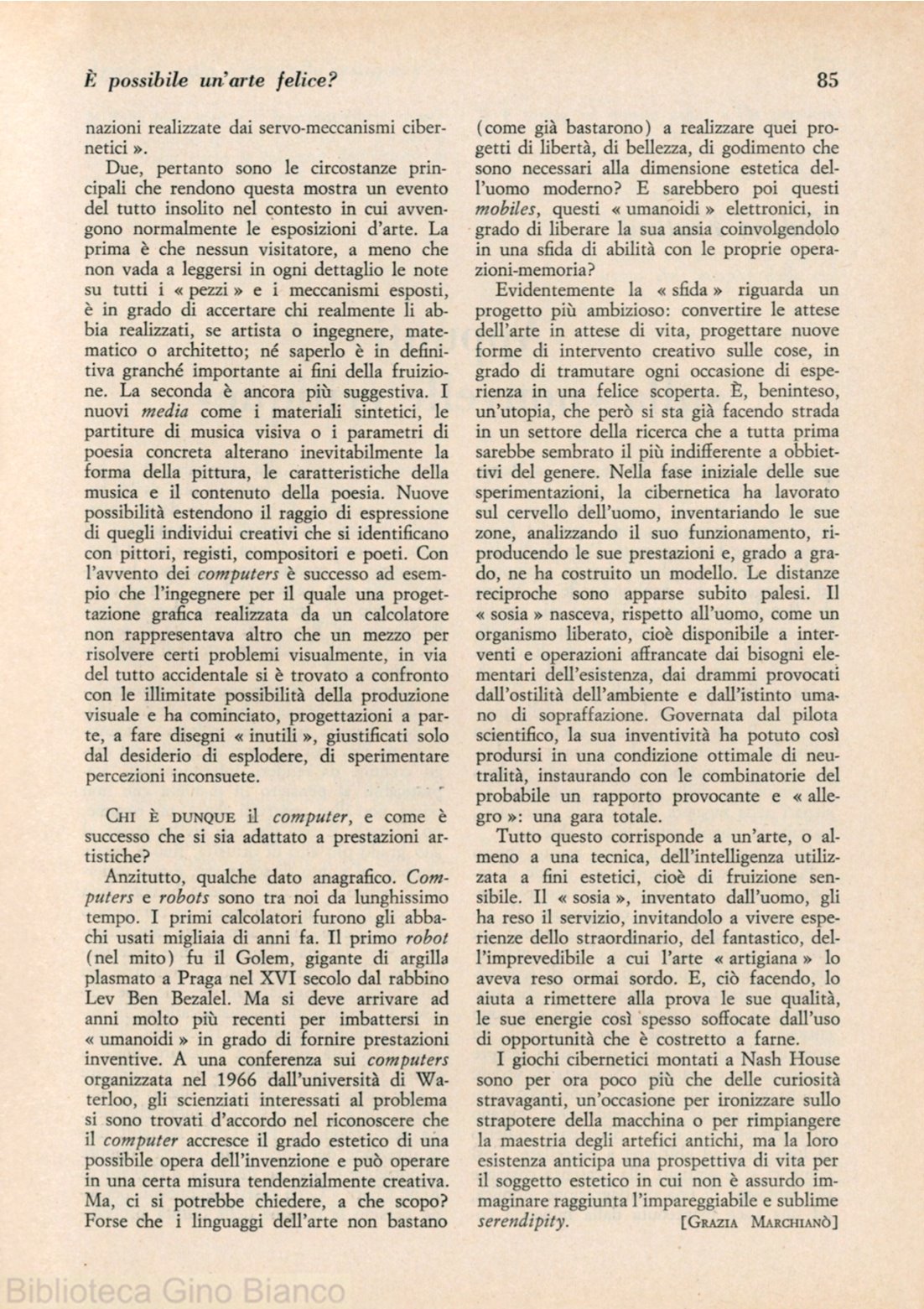
È
possibile un'arte felice?
nazioni realizzate dai servo-meccanismi ciber–
netici».
Due, pertanto sono le circostanze prin–
cipali che rendono questa mostra un evento
del tutto insolito nel contesto in cui avven–
gono normalmente le
esposizioni
d'arte. La
prima
è
che nessun visitatore, a meno che
non vada a leggersi in ogni dettaglio le note
su tutti
i
«
pezzi
»
e
i
meccanismi esposti,
è
in grado di accertare chi realmente li ab–
bia realizzati, se artista o ingegnere, mate–
matico o architetto; né saperlo
è
in defini–
tiva granché importante ai fini della fruizio–
ne. La seconda è ancora più suggestiva. I
nuovi
media
come
i
materiali sintetici, le
partiture
di
musica visiva o i parametri
di
poesia concreta alterano inevitabilmente la
forma della pittura, le caratteristiche della
musica e
il
contenuto della poesia. Nuove
possibilità estendono il raggio di espressione
di quegli individui creativi che si identificano
con pittori, registi, compositori e poeti. Con
l'avvento dei
computers
è successo ad esem–
pio che l'ingegnere per il quale una proget–
tazione grafica realizzata da un calcolatore
non rappresentava altro che un mezzo per
risolvere certi problemi visualmente, in via
del tutto accidentale si è trovato a confronto
con le illimitate possibilità della produzione
visuale e ha cominciato, progettazioni a par–
te, a fare disegni « inutili
»,
giustificati solo
dal desiderio di esplodere, di sperimentare
percezioni inconsuete.
Ctu
È
DUNQUE
il
computer,
e come è
successo che si sia adattato a prestazioni ar–
tistiche?
Anzitutto, qualche dato anagrafico.
Com–
puters
e
robots
sono tra noi da lunghissimo
tempo. I primi calcolatori furono gli abba–
chi usati migliaia di anni fa. Il primo
robot
(nel mito) fu il Golem, gigante di argilla
plasmato a Praga nel XVI secolo dal rabbino
Lev Ben Bezalel.
Ma si
deve arrivare ad
anni molto più recenti per imbattersi in
«
umanoidi
»
in grado di fornire prestazioni
inventive. A una conferenza sui
computers
organizzata nel 1966 dall'università di Wa–
terloo, gli scienziati interessati al problema
si sono trovati d'accordo nel riconoscere che
il
computer
accresce il grado estetico di una
possibile opera dell'invenzione e può operare
in una certa misura tendenzialmente creativa.
Ma, ci si potrebbe chiedere, a che scopo?
Forse che i linguaggi dell'arte non bastano
85
(come già bastarono) a realizzare quei pro–
getti di libertà, di bellezza, di godimento che
sono necessari alla dimensione estetica del–
l'uomo moderno? E sarebbero poi questi
mobiles,
questi «umanoidi» elettronici, in
grado di liberare la sua ansia coinvolgendolo
in una sfida di abilità con le proprie opera–
zioni-memoria?
Evidentemente la « sfida » riguarda un
progetto più ambizioso: convertire le attese
dell'arte in attese di vita, progettare nuove
forme di intervento creativo sulle cose, in
grado di tramutare ogni occasione
di
espe–
rienza in una felice scoperta.
È,
beninteso,
un'utopia, che però si sta già facendo strada
in un settore della ricerca che a tutta prima
sarebbe sembrato
il
più indifferente a obbiet–
tivi del genere. Nella fase iniziale delle sue
sperimentazioni,
la
cibernetica ha lavorato
sul cervello dell'uomo, inventariando le sue
zone, analizzando
il
suo funzionamento, ri–
producendo le sue prestazioni e, grado a gra–
do, ne ha costruito un modello. Le distanze
reciproche sono apparse subito palesi. Il
«
sosia » nasceva, rispetto all'uomo, come un
organismo liberato, cioè disponibile a inter–
venti e operazioni affrancate dai bisogni ele–
mentari dell'esistenza, dai drammi provocatÌ
dall'ostilità dell'ambiente e dall'istinto uma–
no di sopraffazione. Governata dal pilota
scientifico, la sua inventività ha potuto cosl
prodursi in una condizione ottimale di neu–
tralità, instaurando con le combinatorie del
probabile un rapporto provocante e
«
alle–
gro »: una gara totale.
Tutto questo corrisponde a un'arte, o al–
meno a una tecnica, dell'intelligenza utiliz–
zata a
fini
estetici, cioè di fruizione sen–
sibile.
Il
«
sosia
»,
inventato dall'uomo, gli
ha reso
il
servizio, invitandolo a vivere espe–
rienze deUo straordinario, del fantastico, del–
l'imprevedibile a cui l'arte
«
artigiana » lo
aveva reso ormai sordo. E,
ciò
facendo, lo
aiuta a rimettere alla prova le sue qualità,
le sue energie cosl spesso soffocate dall'uso
di opportunità che è costretto a farne.
I giochi cibernetici montati a Nash House
sono per ora poco più che delle curiosità
stravaganti, un'occasione per ironizzare sullo
strapotere della macchina o per rimpiangere
la maestria degli artefici antichi, ma la loro
esistenza anticipa una prospettiva di vita per
il soggetto estetico in cui non
è
assurdo im–
maginare raggiunta l'impareggiabile e sublime
serendipity.
[GRAZIA MARCHIANÒ]
















