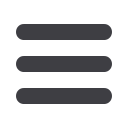
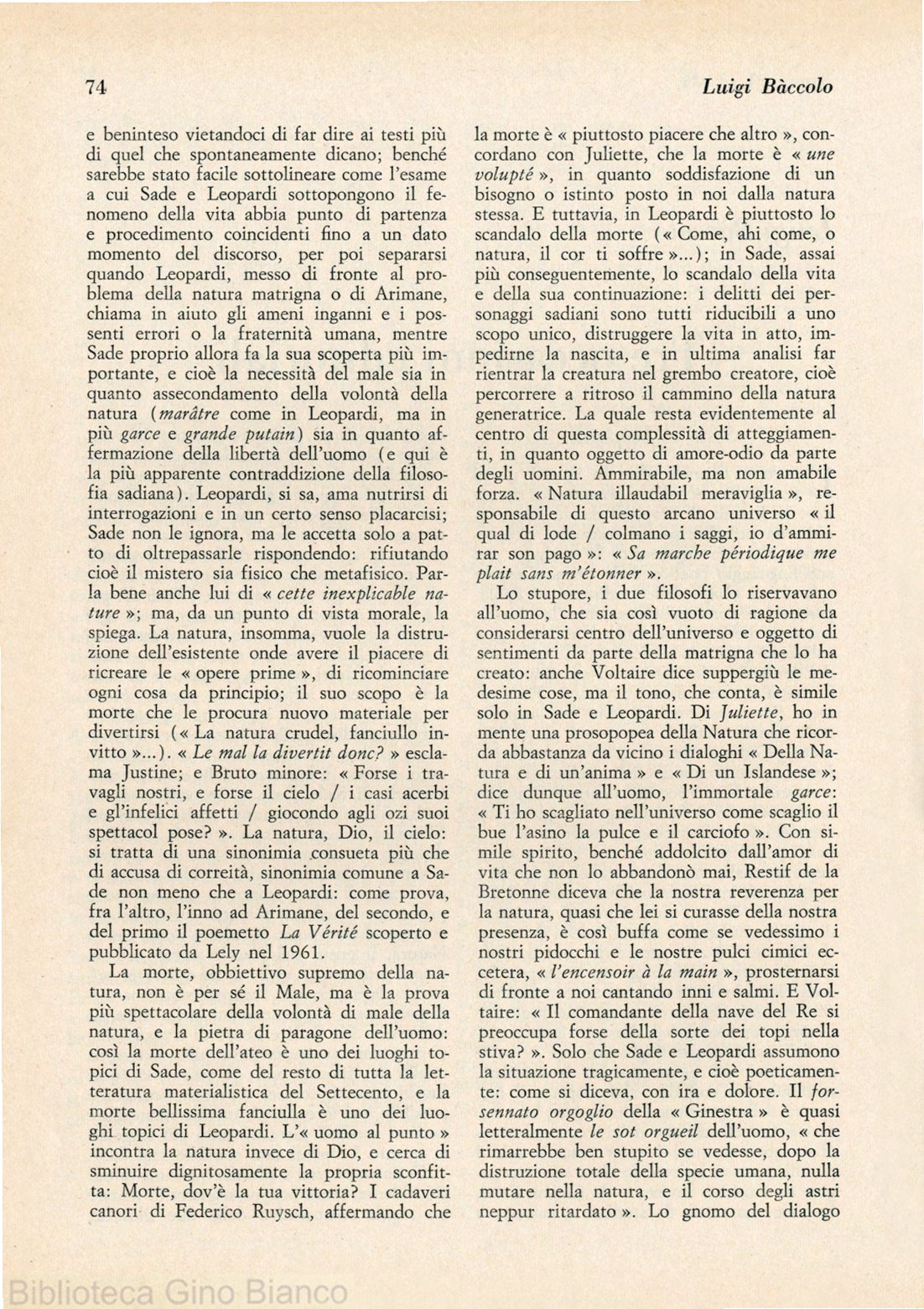
74
e beninteso vietandoci di far dire ai testi
più
di quel che spontaneamente dicano; benché
sarebbe stato facile sottolineare come l'esame
a cui Sade e Leopardi sottopongono il fe–
nomeno della vita abbia punto di partenza
e procedimento coincidenti fino a un dato
momento
del
discorso, per poi separarsi
quando Leopardi, messo di fronte al pro–
blema della natura matrigna o di Arimane ,
chiama
in
aiuto gli ameni inganni e
i
pos–
senti errori o la fraternità umana, mentre
Sade proprio allora
fa
la sua scoperta più im–
portante, e cioè la necessità del male sia in
quanto assecondamento della volontà della
natura
(mardtre
come in Leopardi, ma in
più
garce
e
grande putain)
sia
in
quanto af–
fermazione della libertà dell'uomo (e qui
è
In
più apparente contraddizione della filoso–
fia sadiana). Leopardi, si sa, ama nutrirsi di
interrogazioni e
in
un certo senso placarcisi;
Sade non
le
ignora, ma le accetta solo a pat–
to di oltrepassarle rispondendo: rifiutando
cioè
il
mistero sia fisico che metafi sico. Par–
la bene anche lui di
«
celte i11explicable 11a–
ture
»; ma, da un punto di vista morale, la
spiega. La natura, insomma, vuole la distru–
zione dell'esistent e onde avere
il
piacere di
ricreare le
«
opere prime». di ricominciare
ogni cosa da principio;
il
suo scopo è la
morte che le procura nuovo materiale per
divertirsi
(
«
La natura crudel, fanciullo in–
vitto »...).
«
Le
mal la divertii donc?
»
escla–
ma Justine; e Bruto minore:
«
Forse i tra–
vagli nostri, e forse il cielo / i casi acerbi
e gl'infelici affetti / giocondo agli ozi suoi
spettacol pose?
».
La natura, Dio ,
il
cielo:
si tratta di una sinonimia .consueta più che
di accusa di correità, sinonimia comune a Sa–
de non meno che a Leopardi: come prova,
fra l'altro, l'inno ad Arimane, del secondo, e
del primo il poemetto
La
Vérité
scoperto e
pubblicato da Lely nel 1961.
La morte , obbiettivo supremo della na–
tura, non è per sé
il
Male, ma è la prova
più spettacolare della volontà
di
male della
natura, e la pietra di paragone dell'uomo:
cosi la morte dell'ateo
è
uno dei luoghi to–
pici di Sade, come del resto di tutta la let–
teratura materialistica del Settecento , e la
morte bellissima fanciulla
è
uno dei luo–
ghi topici di Leopardi. L'« uomo al punto»
incontra la natura invece di Dio , e cerca di
sminuire dignitosamente la propria sconfit–
ta: Morte, dov'è la tua vittoria? I cadaveri
canori di Federico Ruysch, affermando che
Luigi Bàccolo
la morte è« piuttosto piacere che altro», con–
cordano con Juliette, che la morte è
«
une
volupté
»,
in quanto soddisfazione di un
bisogno o istinto posto in noi dalla natura
stessa. E tuttavia, in Leopardi
è
piuttosto lo
scandalo della morte (
«
Come, ahi come, o
natura,
il
cor ti soffre» ... ); in Sade, assai
più conseguentemente, lo scandalo della vita
e della sua continuazione: i delitti dei per–
sonaggi sadiani sono tutti riducibili a uno
scopo unico, distruggere la vita in atto, im–
pedirne la nascita, e in ultima analisi far
rientrar la creatura nel grembo creatore, cioè
percorrere a ritroso
il
cammino della natura
generatrice. La quale resta evidentemente al
centro
di
questa complessità di atteggiamen–
ti, in quanto oggetto di amore-odio da parte
degli uomini. Ammirabile, ma non amabile
fotta.
«
Natura illaudabil meraviglia
»,
re–
sponsabile di questo arcano universo
«
il
qual di lode / colmano i saggi, io d'ammi–
rar son pago
»:
«
Sa marche périodique me
plait sans m'étonner
».
Lo
stupore, i due filosofi lo riservavano
all'uomo, che sia cosl vuoto di ragione da
considerarsi centro dell'universo e oggetto di
sentimenti da parte della matrigna che ]o ha
creato: anche Voltaire dice suppergiù le me–
desime cose, ma
il
tono, che conta ,
è
simile
solo in Sade e Leopardi. Di
Juliette ,
ho in
mente una prosopopea della Natura che ricor–
da abbastanza da vicino i dialoghi
«
Della Na–
tura e
di
un'anima » e
«
Di un Islandese
»;
dice dunque all'uomo, l'immortale
garce:
«
Ti ho scagliato nell'universo come scaglio il
bue l'asino la pulce e
il
carciofo». Con si–
mile spirito, benché addolcito dall'amor di
vita che non lo abbandonò mai, Restif de la
Bretonne diceva che ]a nostra reverenza per
la natura, quasi che lei si curasse della nostra
presenza, è cosl buffa come se vedessimo
i
nostri pidocchi e le nostre pulci cimici ec–
cetera,
«
l'encensoir
à
la main
»,
prosternarsi
di fronte a noi cantando inni e salmi. E Vol–
taire:
«
Il comandante della nave del Re si
preoccupa forse della sorte dei topi nella
stiva?
».
Solo che Sade e Leopardi assumono
]a situazione tragicamente, e cioè poeticamen–
te: come si diceva , con ira e dolore. Il
for–
sennato orgoglio
della
«
Ginestra
»
è quasi
letteralmente
le sot orgueil
dell 'uomo,
«
che
rimarrebbe ben stupito se vedesse, dopo la
distruzione rotale della specie umana, nulla
mutare nella natura, e
il
corso degli astri
neppur ritardato ». Lo gnomo del dialogo
















