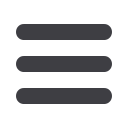
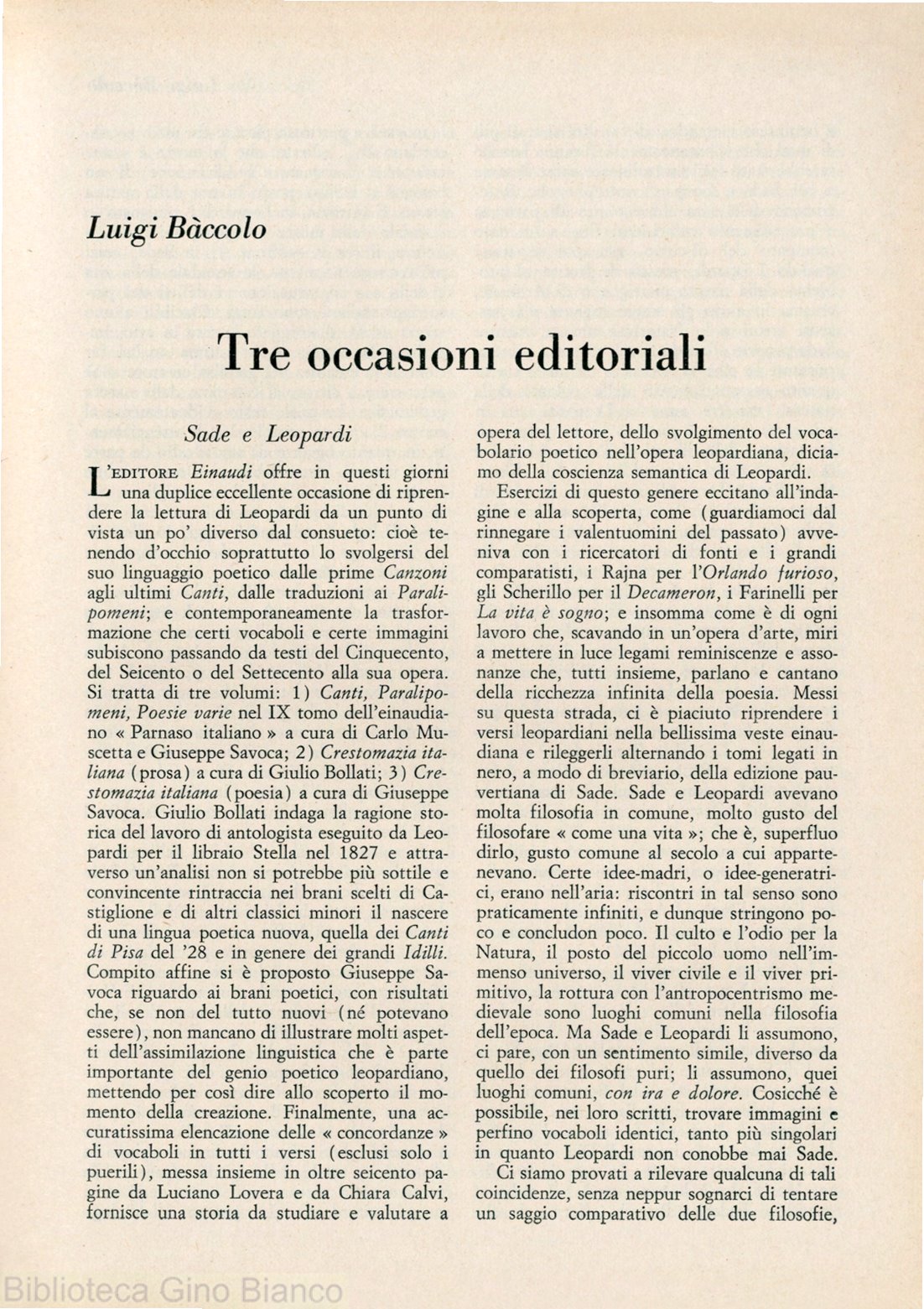
Lu igi Bàccolo
Tre occasioni editoriali
Sade e Leopardi
[
EDITORE
Einaudi
offre in quest i giornj
una duplice eccellente occasione di ripren–
dere la lettura di Leopardi da un punto di
vista un po' diverso dal consueto: cioè te–
nendo d'occhio soprattutto lo svolgersi del
suo linguaggio poetico dalle prime
Canzoni
agli ultimi
Canti,
dalle traduzioni ai
Parali–
pomeni;
e contemporaneamente la trasfor–
mazione che cerci vocaboli e certe immagini
subiscono passando da testi del Cinquecento ,
del Seicento o del Settecento alla sua opera.
Si tratta di tre volumi: 1)
Canti, Paralipo–
meni, Poesie varie
nel
IX
torno dell'einaudia–
no
«
Parnaso italiano
»
a cura di Carlo Mu–
scetta e Giuseppe Savoca; 2)
Crestomazia ita–
liana
(prosa) a cura
cli
Giulio Bollati; 3)
Cre–
stomazia italiana
(poesia) a cura di Giuseppe
Savoca. Giulio Bollati indaga la ragione sto–
rica del lavoro di antologista eseguito da Leo–
pardi per il libraio Stella nel 1827 e attra–
verso un'analisi non si potrebbe
più
sottile e
convincente rintraccia nei brani scelti di Ca–
stiglione e
di
altri classici minori
il
nascere
di una lingua poetica nuova, quella dei
Canti
di Pisa
del '28 e in genere dei grandi
Idilli.
Compito affine si
è
proposto Giuseppe $a–
voca riguardo ai brani poetici, con risultati
che, se non del tutto nuovi (né potevano
essere
L
non mancano di illustrare molti aspet–
ti dell'assimilazione linguistica che
è
parte
importante del genio poetico leopard iano,
mettendo per cosl dire allo scoperto
il
mo–
mento della creazione . Finalmente, una ac–
curatissima elencazione delle
«
concordanze
»
di vocaboli in rutti i versi (esclusi solo i
puerili), messa insieme in oltre seicento pa–
gine da Luciano Lovera e da Chiara Calvi,
fornisce una storia da stud iare e valutare a
opera del lettore, dello svolgimento del voca–
bolario poetico nell'opera leopardiana, dicia–
mo deUa coscienza semantica di Leopardi.
Esercizi di questo genere eccitano all'inda–
gine e alla scoperta , come (guardiamoci dal
rinnegare i valentuomini del passato) avve–
niva con i ricercatori di fonti e
i
grandi
comparatisti,
i
Rajna per
l'Orlando furioso,
gli Scherillo per il
Decamero11,
i Farinelli per
La
vita è sogno;
e insomma come
è
di
ogni
lavoro che, scavando in un'opera d'arte, miri
a mettere in luce legami reminiscen ze e asso–
nanze che, tutti insieme, parlano e cantano
della ricchezza infinita della poesia. Messi
su que sta strada,
ci
è
piaciuto riprendere i
versi leopardiani nella bellissima veste einau–
diana e rileggerli alternando i tomi legati in
nero, a modo di breviario, della edizione pau–
vertiana di Sade. Sade e Leopardi avevano
molta filosofia in comune, molto gusto del
filosofare
«
come una vita»; che è, superfluo
dirlo, gusto comune al secolo a cui apparte–
nevano. Certe idee-madri, o idee-generatri–
ci,
erano neU'ada: riscontri in tal senso sono
praticamente infiniti, e dunque stringono
po–
co e concludon poco. Il culto e l'odio per la
Natura, il posto del piccolo uomo nell'im–
menso universo, il viver civile e il viver pri–
mitivo , la rottura con l'antropocentrismo me–
dievale sono luoghi comuni nella filosofia
dell'epoca. Ma Sade e Leopardi
li
assumono,
ci
pare, con un sentimento simile, diverso da
quello dei filosofi puri;
li
assumono , quei
luoghi comuni,
con ira e dolore.
Cosicché
è
possibile, nei loro scritti , trovare immagini e
perfino vocaboli identici, tanto più singolari
in quanto Leopardi non conobbe mai Sade.
Ci siamo provati a rilevare qualcuna di tali
coincidenze, senza neppur sognarci di tentare
un saggio comparativo delle due filosofie,
















