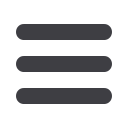
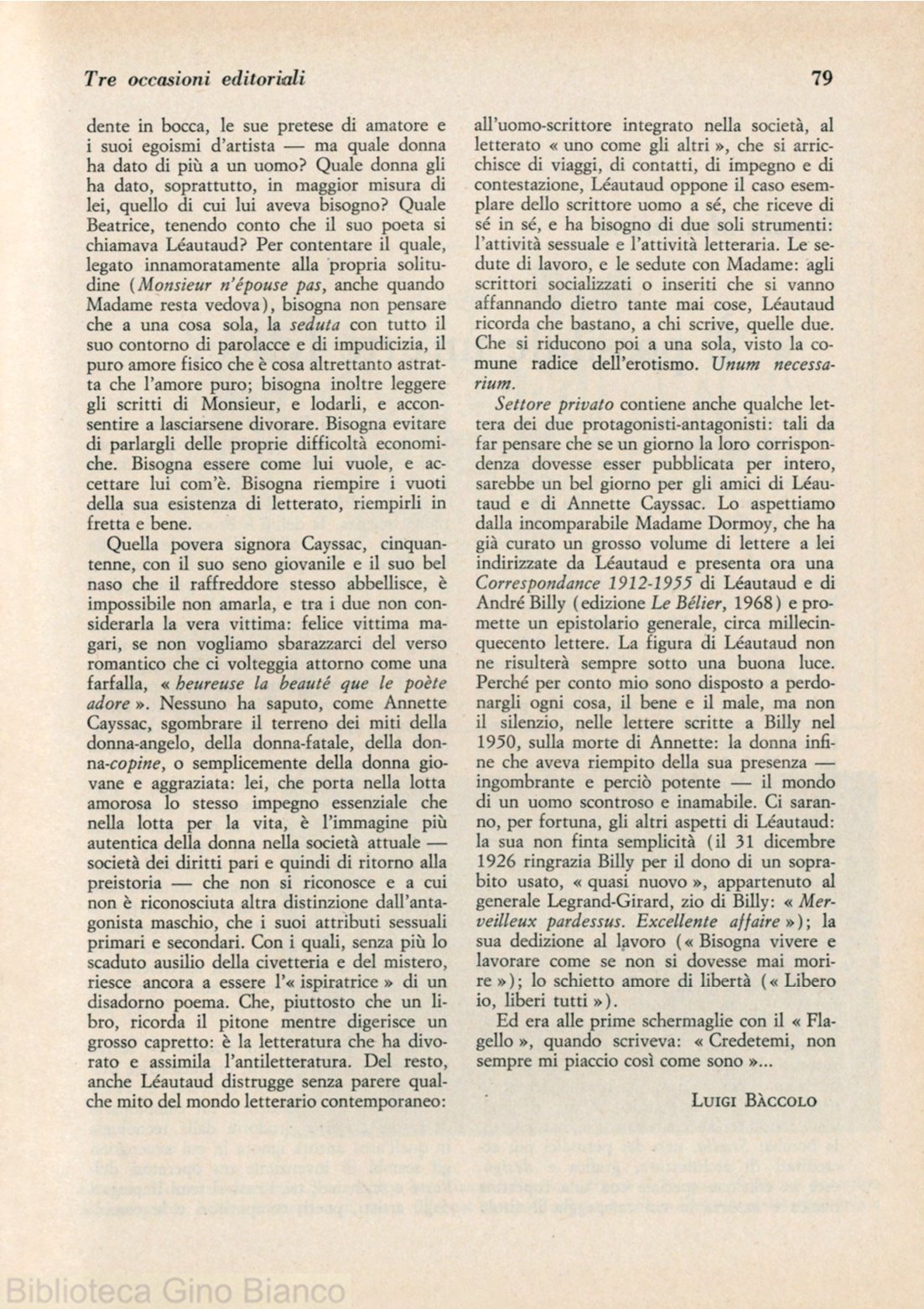
Tre occasioni editoriali
dente in bocca, le sue pretese di amatore e
i
suoi egoismi d'artista - ma quale donna
ha dato di più a un uomo? Quale donna gli
ha dato, soprattutto, in maggior misura di
lei, quello di cui lui aveva bisogno? Quale
Beatrice, tenendo conto che
il
suo poeta si
chiamava Léautaud? Per contentare
il
quale ,
legato innamoratamente alla ·propria solitu–
dine
(Monsieur n'épouse pas,
anche quando
Madame resta vedova), bisogna non pensare
che a una cosa sola, la
seduta
con tutto il
suo contorno
di
parolacce e di impudicizia,
il
puro amore fisico che
è
cosa altrettanto astrat–
ta che l'amore puro; bisogna inoltre leggere
gli scritt i di Monsieur, e lodarli , e accon–
sentire a lasciarsene divorare . Bisogna evitare
di parlargli delle proprie difficoltà economi–
che. Bisogna essere come lui vuole, e ac–
cettare lui com'è. Bisogna riempire
i
vuoti
della sua esistenza
di
lette rato , riempirli in
fretta e bene.
Quella povera signora Cayssac, cinquan–
tenne, con il suo seno giovanile e
il
suo bel
naso che il raffreddore stesso abbellisce,
è
impossibile non amarla, e tra i due non con–
siderarla la vera vittima: felice vittima ma–
gari, se non vogliamo sbarazzarci del verso
romantico che
ci
volteggia attorno come una
farfalla,
«
heureuse la beauté que le poète
odore
».
Nessuno ha saputo, come Annette
Cayssac, sgombrare
il
terreno dei miti della
donna-angelo, della donna-fatale, della don–
na-copine,
o semplicemente della donna gio–
vane e aggraziata: lei, che porta nella lotta
amorosa lo stesso impegno essenziale che
nella lotta per la vita,
è
l'immagine più
autentica della donna nella società attuale -
società dei diritti pari e quindi di ritorno alla
preistoria - che non si riconosce e a cui
non
è
riconosciuta altra distinzione dall'anta–
gonista maschio, che
i
suoi attributi sessuali
primari e secondari. Con i quali, senza più lo
scaduto ausilio della civetteria e del mistero,
riesce ancora a essere l'« ispiratrice» di un
disadorno poema. Che, piuttosto che un li–
bro, ricorda
il
pitone mentre digerisce un
grosso capretto:
è
la letteratura che ha divo–
rato e assimila l'antiletteratura. Del resto,
anche Léautaud distrugge senza parere qual–
che mito del mondo letterario contemporaneo:
79
all'uomo-scrittore integrato nella società, al
letter ato
«
uno come gli altri », che si arric–
chisce di viaggi,
di
contatti ,
cli
impegno e di
contestaz ione, Léautaud oppone il caso esem–
plare dello scrittore uomo a sé, che riceve di
sé in sé, e ha bisogno di due soli strumenti:
l'attività sessuale e l'attività letteraria. Le se–
dute di lavoro, e le sedute con Madame : agli
scritto ri socializzati o inseriti che si vanno
affannando dietro tante mai cose, Léautaud
ricorda che bastano, a chi scrive, quelle due.
Che si riducono poi a una sola, visto la co–
mune radice dell' erotismo.
Unum necessa–
riu.m.
Settore privato
contiene anche qualche let–
tera dei due protagonisti-antagonisti: tali da
far pensare che se un giorno la loro corrispon–
denza dovesse esser pubblicata per intero,
sarebbe un bel giorno per gli amici di Léau–
taud e di Annet te Cayssac. Lo aspettiamo
dalla incomparabile Madame Dormoy, che ha
già curato un grosso volume di lettere a lei
indirizzate da Léautaud e presenta ora una
Correspondance 1912-1955
di Léautaud e di
André Billy (edizione
Le Bélier,
1968)
e pro–
mette un epistolario generale, circa millecin–
quecento lettere . La figura ai Léautaud non
ne risulterà sempre sotto una buona luce.
Perché per conto mio sono disposto a perdo–
nargli ogni cosa,
il
bene e
il
male, ma non
il
silenzio, nelle lettere scritte a Billy nel
1950,
sulla morte di Annette: la donna infi–
ne che aveva riempito della sua presenza -
ingombrante e perciò potente -
il
mondo
di un uomo scontroso e inamabile. Ci saran–
no, per fortuna, gli altri aspetti di Léautaud :
la sua non finta semplicità (il
31
dicembre
1926
ringrazia Billy per il dono di un sopra–
bito usato,
«
quasi nuovo», appartenuto al
generale Legrand-Girard, zio di Billy:
«
Mer–
veilleux pardessus. Excellente a//aire
»);
la
sua dedizione al lt3voro (
«
Bisogna vivere e
lavorare come se non si dovesse mai mori–
re
»);
lo schietto amore di libertà (
«
Libero
io, liberi tutti »).
Ed era alle prime schermaglie con
il
«
Fla–
gello», quando scriveva:
«
Credetemi, non
sempre mi piaccio cosl come sono »...
LUIGI
BÀCCOLO
















