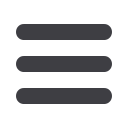
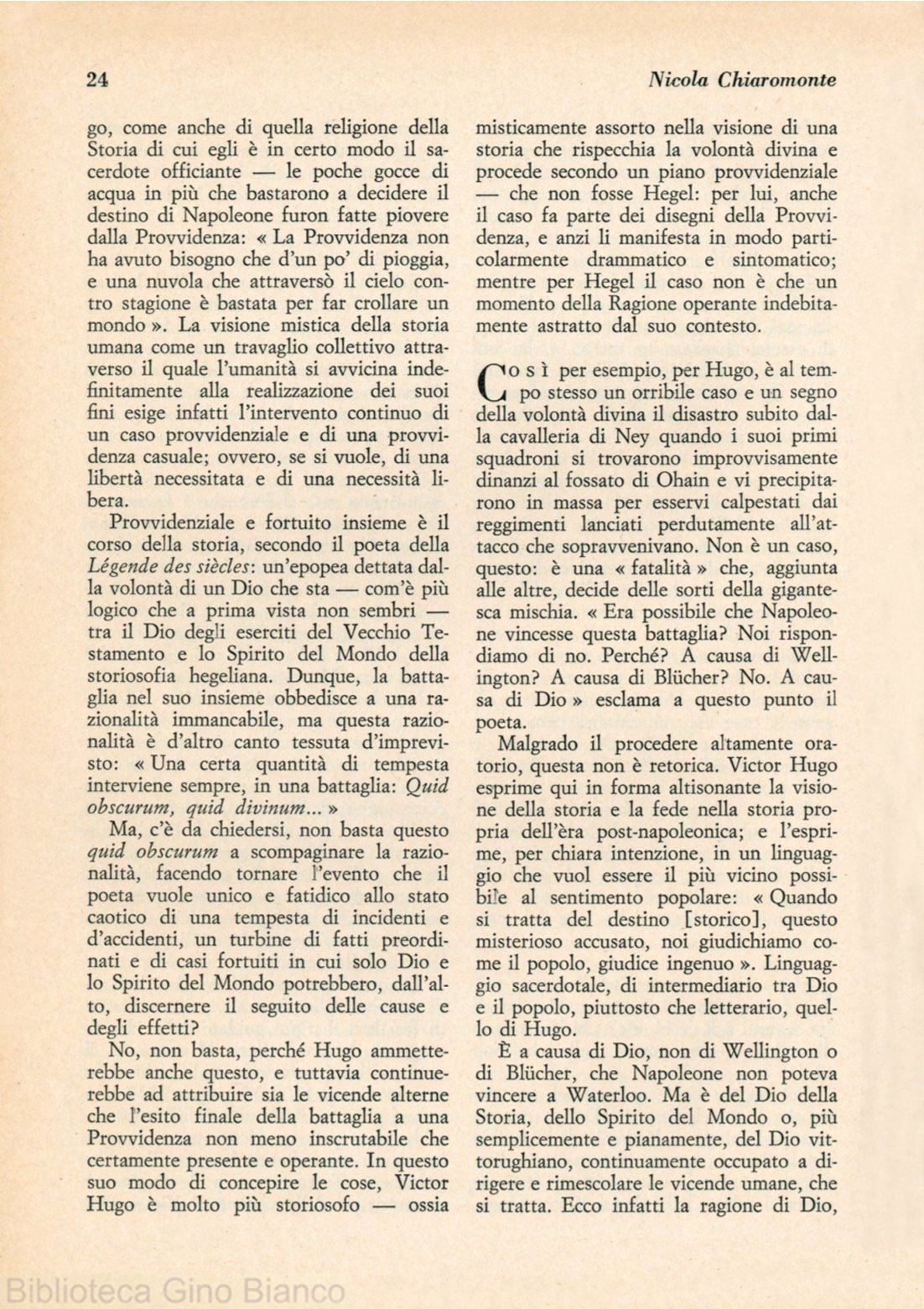
24
go, come anche di quella religione della
Storia
cli
cui egli è in certo modo il sa–
cerdote officiante - le poche gocce di
acqua in più che bastarono a decidere il
destino di Napoleone furon fatte piovere
dalla Provvidenza:
«
La Provvidenza non
ha avuto bisogno che d'un po' di pioggia,
e una nuvola che attraversò il cielo con–
tro stagione
è
bastata per far crollare un
mondo ». La visione mistica della storia
umana come un travaglio collettivo attra–
verso il quale l'umanità si avvicina inde–
finitamente alla realizzazione dei suoi
fini esige infatti l'intervento continuo
cli
un caso provvidenziale e di una provvi–
denza casuale; ovvero, se si vuole, di una
libertà necessitata e di una necessità li–
bera.
Provvidenziale e fortuito insieme è il
corso della storia, secondo il poeta della
Légende des siècles:
un'epopea dettata dal–
la volontà
cli
un Dio che sta - com'è più
logico che a prima vista non sembri -
tra il Dio degli eserciti del Vecchio Te–
stamento e lo Spirito del Mondo della
storiosofia hegeliana. Dunque, la batta–
glia nel suo insieme obbedisce a una ra–
zionalità immancabile, ma questa razio–
nalità è d'altro canto tessuta d'imprevi–
sto: « Una certa quantità di tempesta
interviene sempre, in una battaglia:
Quid
obscurum, quid divinum ...
»
Ma, c'è da chiedersi, non basta questo
quid obscurum
a scompaginare la razio–
nalità, facendo tornare l'evento che il
poeta vuole unico e fatidico allo stato
caotico di una tempesta
cli
incidenti e
d'accidenti, un turbine di fatti preordi–
nati e di casi fortuiti in cui solo Dio e
lo Spirito del Mondo potrebbero , dall'al–
to, discernere il seguito delle cause e
degli effetti?
No, non basta, perché Hugo ammette–
rebbe anche questo, e tuttavia continue–
rebbe ad attribuire sia le vicende alterne
che l'esito finale della battaglia a una
Provvidenza non meno inscrutabile che
certamente presente e operante.
In
questo
suo modo
cli
concepire le cose, Victor
Hugo è molto più storiosofo - ossia
Nico ÙLChi.aromonte
misticamente assorto nella visione di una
storia che rispecchia la volontà divina e
procede secondo un piano provvidenziale
- che non fosse Hegel: per lui, anche
il caso fa parte dei disegni della Provvi–
denza, e anzi li manifesta in modo parti–
colarmente drammatico e sintomatico;
mentre per Hegel il caso non è che un
momento della Ragione operante indebita–
mente astratto dal suo contesto.
C
o s
ì
per esempio, per Hugo, è al tem–
po
stesso un orribile caso e un segno
della volontà divina il disastro subito dal–
la cavalleria di Ney quando i suoi primi
squadroni si trovarono improvvisamente
dinanzi al fossato
cli
Ohain e vi precipita–
rono in massa per esservi calpestati dai
reggimenti lanciati perdutamente all'at–
tacco che sopravvenivano. Non è un caso,
questo: è una «fatalità» che, aggiunta
alle altre, decide delle sorti della gigante–
sca mischia. « Era possibile che Napoleo–
ne vincesse questa battaglia? Noi rispon–
diamo di no. Perché? A causa di Well–
ington? A causa
cli
Bliicher? No. A cau–
sa
cli
Dio
»
esclama a questo punto
il
poeta.
Malgrado il procedere ahamente ora–
torio, questa non è retorica. Victor Hugo
esprime qui in forma altisonante la visio–
ne della storia e la fede nella storia pro–
pria dell'èra post-napoleonica; e l'espri–
me, per chiara intenzione, in un linguag–
gio che vuol essere il più vicino possi–
bile al sentimento popolare: « Quando
si tratta del destino [storico] , questo
misterioso accusato, noi giudichiamo co–
me il popolo, giudice ingenuo
».
Linguag–
gio sacerdotale,
cli
intermediario tra Dio
e il popolo, piuttosto che letterario , quel–
lo
cli
Hugo.
:È
a causa di Dio, non di Wellington o
di Bliicher, che Napoleone non poteva
vincere a Waterloo. Ma è del Dio della
Storia, dello Spirito del Mondo o, più
semplicemente e pianamente, del Dio vit–
torughiano, continuamente occupato a di–
rigere e rimescolare le vicende umane, che
si tratta. Ecco infatti la ragione di Dio,
















