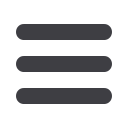
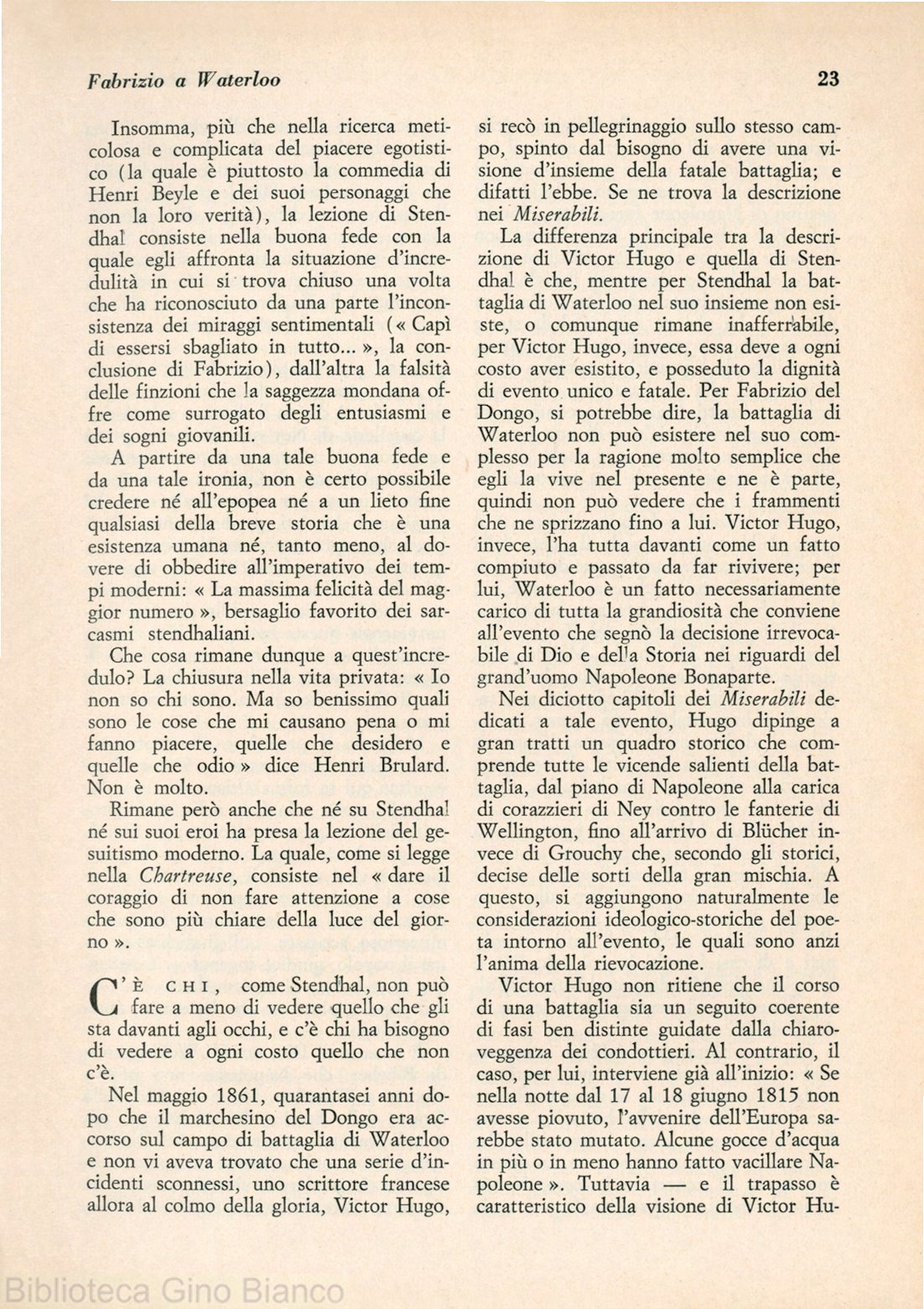
Fabrizio a Waterloo
Insomma, più che nella ricerca meti–
colosa e complicata del piacere egotisti–
co (la quale è piuttosto la commedia di
Henri Beyle e dei suoi personaggi che
non la loro verità), la lezione
di
Sten–
dhal consiste nella buona fede con la
quale egli affronta la situazione d'incre–
dulità in cui si trova chiuso una volta
che ha riconosciuto da una parte l'incon–
sistenza dei miraggi sentimentali (
«
Capl
di essersi sbagliato in tutto ... », la con–
clusione di Fabrizio), dall'altra la falsità
delle finzioni che la saggezza mondana of–
fre come surrogato degli entusiasmi e
dei sogni giovanili.
A partire da una tale buona fede e
da una tale ironia, non è certo possibile
credere né all'epopea né a un lieto fine
qualsiasi della breve storia che è una
esistenza umana né, tanto meno,
al
do–
vere di obbedire all'imperativo dei tem–
pi moderni:
«
La massima felicità del mag–
gior numero», bersaglio favorito dei sar–
casmi stendhaliani.
Che cosa rimane dunque a quest'incre–
dulo? La chiusura nella vita privata:
«
Io
non so chi sono. Ma so benissimo quali
sono le cose che mi causano pena o mi
fanno piacere, quelle che desidero e
quelle che odio » dice Henri Brulard.
Non è molto.
Rimane però anche che né su Stendhal
né sui suoi eroi ha presa la lezione del ge–
suitismo moderno. La quale, come si legge
nella
Chartreuse,
consiste nel
«
dare
il
coraggio di non fare attenzione a cose
che sono più chiare della luce del gior–
no» .
e '
È
e
H
r , come Stendhal, non può
fare a meno di vedere quello che gli
sta davanti agli occhi, e c'è chi ha bisogno
di vedere a ogni costo quello che non
c'è.
Nel maggio 1861, quarantasei anni do–
po che
il
marchesino del Dongo era ac–
corso sul campo di battaglia
di
Waterloo
e non vi aveva trovato che una serie d'in–
cidenti sconnessi, uno scrittor e francese
allora al colmo della gloria, Victor Hugo,
23
si recò in pellegrinaggio sullo stesso cam–
po, spinto dal bisogno
di
avere una vi–
sione d'insieme della fatale battaglia; e
difatti l'ebbe. Se ne trova la descrizione
nei
Miserabili.
La differenza principale tra la descri–
zione di Victor Hugo e quella di Sten–
dhal è che, mentre per Stendhal la bat–
taglia di Waterloo nel suo insieme non esi–
ste, o comunque rimane inafferr\ibile,
per Victor Hugo, invece, essa deve a ogni
costo aver esistito, e posseduto la dignità
di evento unico e fatale. Per Fabrizio del
Dongo, si potrebbe dire, la battaglia di
Waterloo non può esistere nel suo com–
plesso per la ragione molto semplice che
egli la vive nel presente e ne è parte,
quindi non può vedere che i frammenti
che ne sprizzano fino a lui. Victor Hugo,
invece, l'ha tutta davanti come un fatto
compiuto e passato da far rivivere; per
lui, Waterloo è un fatto necessariamente
carico di tutta la grandiosità che conviene
all'evento che segnò la decisione irrevoca–
bile di Dio e della Storia nei riguardi del
grand'uomo Napoleone Bonaparte.
Nei diciotto capitoli dei
Miserabili
de–
dicati a tale evento, Hugo dipinge a
gran tratti un quadro storico che com–
prende tutte le vicende salienti della bat–
taglia, dal piano di Napoleone alla carica
di corazzieri di Ney contro le fanterie di
Wellington , fino all'arrivo di Bliicher in–
vece di Grouchy che, secondo gli storici,
decise delle sorti della gran mischia. A
questo, si aggiungono naturalmente le
considerazioni ideologico-storiche del poe–
ta intorno all'evento, le quali sono anzi
l'anima della rievocazione.
Victor Hugo non ritiene che
il
corso
di una battaglia sia un seguito coerente
di fasi ben distinte guidate dalla chiaro–
veggenza dei condottieri. Al contrario ,
il
caso, per lui, interviene già all'inizio:
«
Se
nella notte dal 17 al 18 giugno 1815 non
avesse piovuto, l'avvenire dell'Europa sa–
rebbe stato mutato. Alcune gocce d'acqua
in più o in meno hanno fatto vacillare Na–
poleone». Tuttavia - e
il
trapasso
è
caratteristico della visione
di
Victor Hu-
















